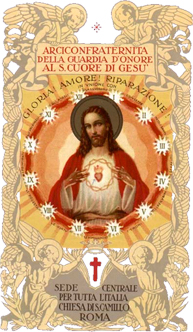Quello che gli attuali vertici della Chiesa non sono stati capaci di dire – prima, durante e dopo il summit in Vaticano del 21-24 febbraio sugli abusi sessuali compiuti da ministri consacrati – l’ha detto e scritto il “papa emerito” Benedetto XVI negli “appunti” che ha reso pubblici l’11 aprile, dopo averne informato il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin e papa Francesco.
Quello che gli attuali vertici della Chiesa non sono stati capaci di dire – prima, durante e dopo il summit in Vaticano del 21-24 febbraio sugli abusi sessuali compiuti da ministri consacrati – l’ha detto e scritto il “papa emerito” Benedetto XVI negli “appunti” che ha reso pubblici l’11 aprile, dopo averne informato il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin e papa Francesco.
Joseph Ratzinger è andato alla radice dello scandalo: alla rivoluzione sessuale del ’68, al “collasso” della dottrina e della morale cattolica tra gli anni Sessanta e Ottanta, alla caduta della distinzione tra bene e male e tra verità e menzogna, al proliferare nei seminari di “club omosessuali”, all’imporsi di un “cosiddetto garantismo” che rendeva intoccabili chi giustificava tali novità compresa la stessa pedofilia, in ultima analisi a un allontanamento da quel Dio che è la ragione di vita della Chiesa e il senso d’orientamento di ogni uomo.
Da cui consegue, a giudizio di Ratzinger, che il compito della Chiesa di oggi è di ritrovare il coraggio di “vivere di Dio” e di “anteporre” Dio a tutto, di tornare a crederlo realmente presente nell’eucaristia invece che “declassarla a gesto cerimoniale”, di guardare alla Chiesa come piena di zizzania ma anche di buon grano, di santi, di martiri, da difendere dal discredito del Maligno, senza illudersi di rifarne da noi stessi una migliore, tutta politica, che “non può rappresentare alcuna speranza”.
È un’analisi che farà certamente discutere, questa di Ratzinger, visto com’è distante da ciò che si dice e si fa oggi ai vertici della Chiesa riguardo allo scandalo degli abusi sessuali, in un’ottica che è sostanzialmente giudiziale e che oscilla tra i due poli della “tolleranza zero” e del garantismo.
Un garantismo tutto diverso da quello – “cosiddetto” – richiamato da Ratzinger, perché riguarda piuttosto i diritti di difesa degli imputati, la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva, la proporzionalità della pena, e che è utile misurare come viene impiegato oggi nei confronti di cardinali e arcivescovi implicati in abusi.
Concentrando l’analisi su quest’ultimo punto, ecco che cosa se ne può ricavare.
*
Fino allo scorso autunno la formula “tolleranza zero” – mai usata da papa Benedetto XVI – era una delle più ricorrenti nelle parole e negli scritti di Francesco, per dire come contrastare gli abusi sessuali del clero su vittime di minore età.
Ma da allora è scomparsa. Sparita nel documento finale del sinodo sui giovani; sparita nella successiva esortazione apostolica “Christus vivit”; sparita nei discorsi e documenti del summit sugli abusi tenuto in Vaticano dal 21 al 24 febbraio.
Anzi, all’inizio di quel summit Francesco distribuì ai convenuti 21 “punti di riflessione” scritti di suo pugno che con la “tolleranza zero” non andavano per niente d’accordo.
Il punto 14 ad esempio diceva:
“Occorre salvaguardare il principio di diritto naturale e canonico della presunzione di innocenza fino alla prova della colpevolezza dell’accusato.”.
E il punto 15:
“Osservare il tradizionale principio della proporzionalità della pena rispetto al delitto commesso. Deliberare che i sacerdoti e i vescovi colpevoli di abuso sessuale su minori abbandonino il ministero pubblico”.
I provvedimenti adottati in questi ultimi due mesi contro cinque cardinali e arcivescovi finiti sotto processo per abusi commessi o “coperti” confermano in pieno questo mutamento di linea.
Non c’è un provvedimento che sia uguale a un altro. E solo in un caso esso è consistito nella riduzione allo stato laicale del condannato, quando invece, in forza della “tolleranza zero”, questa sarebbe dovuta essere la sanzione da comminare a tutti, anche a chi avesse commesso un solo abuso su una sola vittima in anni lontani.
*
Ad essere ridotto allo stato laicale, si sa, è stato soltanto l’ex cardinale Theodore McCarrick. Nessuno, invece, degli altri quattro sanzionati prima e dopo di lui.
Il cardinale australiano George Pell e il cardinale francese Philippe Barbarin, entrambi condannati dai tribunali secolari dei rispettivi paesi ed entrambi in attesa di un processo di appello, hanno avuto nel foro ecclesiastico un trattamento molto diverso, più pesante con Pell e più garantista con Barbarin, come Settimo Cielo ha documentato:
> Con Pell e Barbarin il papa usa due pesi e due misure
Ancora più indulgente è apparso il papa con il cardinale Ricardo Ezzati Andrello, del quale s’è limitato il 23 marzo ad accettare le dimissioni da arcivescovo di Santiago del Cile, il giorno dopo della sua chiamata a processo per occultamento di abusi.
E ancora diverso dai precedenti è stato il trattamento dell’ex arcivescovo di Agaña nell’isola di Guam, Anthony Sablan Apuron (nella foto), condannato in forma definitiva lo scorso 7 febbraio – con sentenza resa nota il 4 aprile dalla congregazione per la dottrina della fede – a scontare queste tre pene: “la privazione dell’ufficio; il divieto perpetuo di dimorare anche temporaneamente nell’arcidiocesi di Agaña; il divieto perpetuo di usare le insegne proprie dell’ufficio di vescovo”.
*
Dal momento che l’isola di Guam, nel Pacifico, è territorio degli Stati Uniti, Apuron è il primo arcivescovo statunitense finora colpito da una condanna canonica definitiva per abusi sessuali, sei giorni prima di quel 13 febbraio in cui fu laicizzato McCarrick.
Ma appunto, a differenza di quest’ultimo, Apuron non è stato ridotto allo stato laicale, nonostante anche lui sia stato riconosciuto colpevole di “delitti contro il sesto comandamento con minori”. Continua a poter celebrare, sia pure lontano da Guam e senza portare le insegne episcopali.
E questo contrasta vistosamente con la “tolleranza zero” che è la parola d’ordine della Chiesa cattolica degli Stati Uniti a partire dalla “Carta di Dallas” del 2002, quando era presidente della conferenza episcopale proprio quel Wilton Gregory che papa Francesco ha promosso ad arcivescovo di Washington il giorno stesso della pubblicazione della mite condanna di Apuron.
Ma come si è giunti a questo epilogo?
In prima istanza, il caso di Apuron fu giudicato da una giuria presieduta dal cardinale Raymond L. Burke, canonista di chiara fama, anche lui statunitense ma molto attento alle garanzie da assicurare agli imputati, nominato a questo ruolo personalmente da papa Francesco.
Questo primo processo si concluse il 16 marzo 2018 con una condanna per abusi su minori e con la rimozione di Apuron da arcivescovo di Guam.
Apuron tuttavia ricorse in appello. E in Vaticano ripartì un nuovo processo canonico, questa volta presieduto personalmente da Francesco, stando a quanto da lui rivelato nella conferenza stampa del 26 agosto scorso, di ritorno dall’Irlanda:
“L’arcivescovo di Guam è ricorso in appello e io ho deciso – perché era un caso molto, molto complesso – di usare un diritto che ho io, di prendere su di me l’appello e non mandarlo al tribunale d’appello che fa il suo lavoro con tutti i preti, ma l’ho preso su di me.
Ho fatto una commissione di canonisti che mi aiuti e mi hanno detto che, in breve, un mese al massimo, sarà fatta la ‘raccomandazione’ perché io faccia il giudizio.
È un caso complicato, da una parte, ma non difficile, perché le evidenze sono chiarissime; dal lato delle evidenze, sono chiare. Ma non posso pre-giudicare. Aspetto il rapporto e poi giudicherò. Dico che le evidenze sono chiare perché sono quelle che hanno portato il primo tribunale alla condanna”.
E siamo alla sentenza di condanna definitiva del 7 febbraio di quest’anno. Contro la quale però Apuron continua a protestarsi innocente, vittima “di un gruppo di pressione che ha progettato di distruggere me” reclutando accusatori “persino dietro offerta di denaro”.
In effetti, un dettagliato reportage pubblicato il 20 settembre 2017 su “Vatican Insider” aveva dato una descrizione inquietante delle lotte di potere ai vertici dell’arcidiocesi di Agaña, prima e dopo l’avvio del processo contro Apuron, lotte non sopite ma divenute ancor più furibonde durante la fase di commissariamento dell’arcidiocesi affidato dal Vaticano all’allora segretario di “Propaganda Fide” Savio Hon Taifai e all’arcivescovo coadiutore Michael Jude Byrnes, oggi promosso titolare.
Che alcune delle accuse rivolte contro Apuron fossero inconsistenti l’aveva riscontrato anche la giuria presieduta dal cardinale Burke, che però aveva ritenuto provati un paio di delitti, con la conseguente condanna.
Resta tuttavia il fatto che dei due processi pochissimo è stato reso noto. E Apuron non aveva torto quando ha dichiarato, dopo la seconda e definitiva condanna, che “il segreto pontificio mi impedisce di difendere il mio buon nome in pubblico”.
Durante il summit del 21-24 febbraio diverse voci – tra cui quella del cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e membro del consiglio dei cardinali che coadiuvano Francesco nel governo della Chiesa universale – si sono levate ad invocare l’allentamento del segreto pontificio che preclude l’accesso agli atti dei processi canonici.
Ma nulla finora è cambiato, su questo. E se davvero si vogliono superare le ingiustificabili rigidità della “tolleranza zero” in nome dei diritti di difesa degli imputati e della proporzionalità delle pene, anche la tanto decantata “trasparenza” deve essere messa in pratica, con la pubblicazione non solo delle sentenze finali, ma anche del percorso che le ha prodotte.