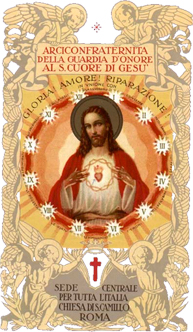Nel 1846 Kierkegaard pubblica la Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, con lo pseudonimo di Joannes Climacus. Con la consueta ironia, degna di un cesellatore di paradossi, egli chiama “postilla” quello che propriamente è un «saggio esistenziale», un denso testo filosofico di circa settecento pagine. Nella Prefazione, enfatizzando il tono ironico, Climacus scrive di essere pienamente soddisfatto perché il precedente saggio – Briciole di filosofia (1844) – non ha avuto successo, anzi, «non ha prodotto nessuna sensazione, nessunissima» [1].
Nel 1846 Kierkegaard pubblica la Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di filosofia, con lo pseudonimo di Joannes Climacus. Con la consueta ironia, degna di un cesellatore di paradossi, egli chiama “postilla” quello che propriamente è un «saggio esistenziale», un denso testo filosofico di circa settecento pagine. Nella Prefazione, enfatizzando il tono ironico, Climacus scrive di essere pienamente soddisfatto perché il precedente saggio – Briciole di filosofia (1844) – non ha avuto successo, anzi, «non ha prodotto nessuna sensazione, nessunissima» [1].
In un’epoca irrequieta, prodiga nell’elargire consenso o dissenso, sempre affaccendata a schierasi di qua e di là, per il suo saggio non c’è stata alcuna effusione di sangue né di inchiostro: «il volume è passato inavvertito, senza recensioni e senza essere nominato in nessuna parte» [2].
In conformità con il motto di Briciole filosofiche – «meglio bene impiccato, che male sposato» –, la totale mancanza di successo del libro è salutata dall’autore come una benedizione: meglio dondolare penzoloni, beatamente sospeso al cappio dell’indifferenza, che non aver contratto un matrimonio felice con il sistema compiacente.
Kierkegaard, ricordiamo, combatteva la filosofia come sistema onnicomprensivo – così come l’aveva concepita Hegel – dove il Singolo è sacrificato all’universale, all’Assoluto; ancor più, egli avversava quel sistema accademico e culturale che si era inginocchiato ai piedi di Hegel e mostrava interesse solo per chi identificasse la filosofia con il filosofo tedesco.
Secondo Climacus – recensori, pubblicità, intermediari, critici letterari –, nel sistema delle lettere, «sono come i sarti nel mondo borghese, in quanto essi “creano gli uomini”: essi creano la moda dello scrittore e del lettore così che il successo del libro è merito anche loro» [3].
Per un autore che voglia preservare la propria libertà di spirito non c’è disgrazia più grande di ritrovarsi debitore verso i suddetti «benefattori», e «la violazione della libertà è consumata appena uno vuole obbligare un altro a fare una certa cosa» [4].
Dal punto di vista della dialettica, incalza Climacus, il dissenso non è il negativo ma il positivo. Un attacco letterario, ad esempio, non è un’usurpazione della libertà personale, perché non comporta alcuna obbligazione nella vita di un altro: a tutti è permesso di esprimere la propria opinione, e all’attaccato il dissenso non impedisce di continuare ad attendere al proprio lavoro, riempirsi la pipa, scherzare con l’amata, dormire dolcemente su due cuscini o fare addirittura a meno di leggere quell’attacco.
Un consenso è invece più pericoloso: le «tenere sollecitudini degli ammiratori» diventano altrettanti obblighi per l’ammirato il quale, prima di rendersene conto, si ritroverà carico di impegni e debiti anche se è lo scrittore più indipendente del mondo.
E quel che vale per uno scrittore riguardo al dissenso vale ugualmente per la gente comune: se per strada un passante ci guarda con indifferenza o arroganza, costui non ci obbliga a nulla e ci solleva da ogni obbligo, primo fra tutti dalla seccatura di toglierci il cappello.
Così Climacus, scampato al successo e al consenso del sistema culturale e accademico, gioisce perché sente di non dovere nulla e di poter andare libero per la propria strada: «seguendo completamente il mio cenno interiore, io continuo a rimuginare i pensieri fino a quando, secondo il mio giudizio, la mia pietanza non sia pronta» [4].
Climacus è lontano dall’avere dei servi, come da essere egli stesso un servo altrui.
In una società apparentemente liberale e spregiudicata come la nostra, si legge nella Postilla, «Il principio della socialità è precisamente un principio illiberale» [5]: la società rifiuta il dissenso che comunque lascia ognuno libero di esprimere la propria opinione, mentre plaude al consenso che pone l’ammirato nella condizione di debitore verso l’ammiratore.
Il ragionamento di Kierkegaard, fin qui esposto, ci suggerisce qualche considerazione sulla società contemporanea, che oggi sembra essere tanto più apparentemente liberale e spregiudicata quanto più combatte il dissenso e insegue il consenso.
Su social network, blog, giornali on line, ad esempio, il principio della socialità si fonda volontariamente, quasi sfacciatamente, su opzioni pensate per generare consenso e aggregazione di consensi: “mi piace”, “condividi”, “preferiti”, “ritweetta”, “hashtag”, “gruppi suggeriti”, “amici in comune”.
Il dissenso non è contemplato in forma “ufficiale”, e, non potendo essere impedito entro certi limiti, è rilegato a forme di generazione spontanea nello spazio riservato ai “commenti”, o esercitato attraverso “hashtag”/“gruppi” che, per reazione, esercitano il dissenso per lo più in maniera polemica o già in partenza risentita.
In un sistema così pensato, in sintesi, il positivo è forzatamente il “consenso” e il negativo è pregiudizialmente il “dissenso”.
Si pubblichi una foto di un tramonto o un saggio di fisica quantistica, il positivo è a priori il numero dei “mi piace” consenzienti, mentre il “silenzio-dissenso” e il dissenso esplicito in un commento sono considerati il negativo.
Un sistema strutturato preventivamente per generare consenso ci sembra comporti lo snaturamento della funzione tanto del consenso quanto del dissenso.
Il dissenso, come libera espressione della propria opinione, è svuotato della sua forza critica e ammesso solo nei limiti delle funamboliche ipocrisie del politically correct: va riportato attraverso funeste e capricciose diatribe verso il consenso, oppure va “rimosso”.
Il “mi piace”, dall’altra parte, non è sempre puro e sincero: spesso è il pegno o tributo con il quale ognuno risponde di rimando alle «tenere sollecitudini» di amici, sodali, parenti, gruppi affini o ammiratori in generale. Un consenso indotto, “a prescindere” e a “senso unico”, è veramente tale? Un sistema che limita strutturalmente il dissenso è veramente liberale?
Quel che qui si è offerto è un contributo per riflettere sui pericoli di un sistema, come quello della Rete, per il quale il positivo è forzatamente il “consenso” e il negativo è pregiudizialmente il “dissenso”.
Che l’unica cosa alla quale dovremmo aspirare nella comunicazione – scritta e orale – sia invece il “buono” resta ancora oggi una piccola postilla, purtroppo.
Claudia Mancini
———————————————————-
[1] S.Kierkegaard, Postilla conclusiva non scientifica alle Briciole di Filosofia, ed. a cura di Cornelio Fabro, Edizioni Piemme, Casale Monferrato (AL) 1995, p. 125.
[2] Ivi, p. 126.
[3] Ibidem.
[4] Ivi, pp.126-127.
[5] Ivi, 129.
articolo pubblicato su La Porzione