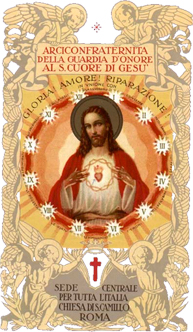Dalle primavere arabe ad oggi, quelle per intenderci targate Obama-Clinton che hanno devastato l’equilibrio in Nordafrica e Medioriente, sono passati sei anni. Il fenomeno migratorio è prima esploso per poi raggiungere una sorta di costante stabilità, quasi una normalità, che però, con tutta evidenza, si legge ‘stabile emergenza’. Le primavere sono state “false rivoluzioni” senza esito finale né si sono completate in un cambiamento stabile. Parlare di democrazia, poi, è roba da farsi ridere dietro.
Dalle primavere arabe ad oggi, quelle per intenderci targate Obama-Clinton che hanno devastato l’equilibrio in Nordafrica e Medioriente, sono passati sei anni. Il fenomeno migratorio è prima esploso per poi raggiungere una sorta di costante stabilità, quasi una normalità, che però, con tutta evidenza, si legge ‘stabile emergenza’. Le primavere sono state “false rivoluzioni” senza esito finale né si sono completate in un cambiamento stabile. Parlare di democrazia, poi, è roba da farsi ridere dietro.
Nel frattempo, e quasi parallelamente nei tempi e nei riferimenti geografici, cresceva il sogno del Califfato, con le vittorie, l’espansione e la conquista prepotente della scena a opera del Daesh. O Isis come in Europa viene chiamato.
La paura e poi il terrore sono gli ingredienti di un mix micidiale insieme a confusione, titubanza, e indecisione mostrati da un Occidente timoroso e lento nel leggere la vera minaccia e nel reagire. Stranamente lento.
Oggi, mentre il Daesh – militarmente almeno – boccheggia, il fenomeno migratorio non rallenta. Anzi, inizia a mostrare ulteriori nuovi aspetti preoccupanti anche e soprattutto in coloro i quali una sorta di accoglienza già l’hanno ricevuta.
Perché oggi aprire a 360° questo argomento, in prima pagina da anni e analizzato e vivisezionato da numerosi esperti e studiosi? Perché nell’ultimo periodo, e ciò interessa il nostro Paese, due sono gli elementi di novità e – sostanzialmente – le nuove minacce, che si sono mostrate in tutta la loro pericolosità: il primo è l’ormai palese avvolgimento della spirale della violenza, in particolare sulle donne ma anche in numerose circostanze su forze dell’ordine, esercenti pubblici, incaricati di pubblico servizio e cittadini.
Lo raccontano cronache scevre da ogni genere di possibile strumentalizzazione.
Il secondo è l’occupazione forzata del territorio, di stabili e abitazioni, ma anche di parchi, piazze e aree comuni, con la volontà e la determinazione di resistere con la forza ai tentativi di sgombero o trasferimento, di impossessarsi a pieno titolo degli spazi.
E su entrambe non sembra che leggi in vigore e forze di sicurezza, tanto meno gli organi di giustizia, riescano a porre un freno che non sia momentaneo. Il timore del punto di non ritorno, umano e sociale, esiste.
E con il concretizzarsi di ulteriori turbative, foriere di pericolose spirali, occorre ora tirare una riga. E la base di questa riga, a premessa di qualunque strategia si voglia scegliere o adottare, non può prescindere dal colmare una lacuna.
La lacuna: sapere, distinguere, capire e agire. Perché al momento subiamo. Senza se e senza ma.
Il terrore che ci pervade ormai impedisce analisi lucide. Questo mare di umanità in afflusso, come quello ormai già stabilizzato e “lungodegente” è tutt’altro che omogeneo.
Grande nei numeri e a macchia di leopardo per categorie, molte delle quali assolutamente meritevoli di aiuto e accoglienza, ma che rischiano di confluire, per il timore diffuso e nella percezione dei nostri connazionali, in due sole definizioni: clandestini e terroristi. E in un diffuso sentimento di paura mista ad impotenza.
Allora facciamo ordine, perché solo riordinando le idee si può pensare a un passo successivo, isolare chi è buono da chi è cattivo, chi respingere da chi aiutare. Teoricamente, e questa è la comunicazione di media, ONG, opinionisti e strateghi di varia estrazione, il mondo di umanità che ci invade si comporrebbe principalmente di fuggitivi da vari conflitti: migranti, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, sfollati, ricongiunti, minori non accompagnati.
Ognuna di queste definizioni porta con sé una serie di diritti riconosciuti da leggi internazionali, e per ognuna di esse sono previste e codificate procedure diverse, differenti tipologie di supporto.
Al momento, invece, la realtà dei fatti ci racconta solo caos. Iniziamo dai numeri. Che qualcuno potrà dire asettici, incapaci di spiegare, insomma un parametro superficiale.
Ma si dà il caso che questo fenomeno viva quasi esclusivamente di numeri: arrivi e sbarchi, annegati, quote da distribuire per Nazioni, rimpatriati, senza casa, richiedenti asilo, ospitati nei centri di accoglienza, ecc.
Quindi dai numeri non si può prescindere. Ma spingiamoci ancora più a fondo, sempre alla ricerca di quella chiarezza che sola ci può portare a uscire dal circolo vizioso: ”clandestini-terroristi”.
Un numero su cui lavorare: 24.500 quelli che hanno raggiunto l’Italia nei primi 3 mesi del 2017. Un numero statisticamente significativo. Bene, smontiamo il primo asserto: fuggono tutti dalle guerre.
Premesso che, è mia personale opinione questa, nelle more di una analisi più profonda, ritengo rispettabili e degni di piena comprensione solo i bambini, le donne e gli anziani quando fuggono da un conflitto interno o da una guerra civile. Certo non dobbiamo buttare la croce addosso ai 20-30enni, perché la paura è un sentimento comprensibile e giustificabile.
Ma rispetto e comprensione sono termini precisi, di profondo significato, che ritengo vadano prima a chi è rimasto a combattere, a difendere persone e cose, a morire per farlo.
E di questo un esempio viene dai Peshmerga curdi, che hanno sfollato vecchi e bambini, ma sono rimasti fermi al loro posto nonostante violenze e un enorme prezzo di sangue da pagare. Uomini e donne.
Noi abbiamo avuto il nostro risorgimento, la Francia la sua Rivoluzione, gli Stati Uniti e la Spagna le loro guerre civili, e potrei andare avanti. Tutti le abbiamo combattute e tutti abbiamo pagato un tributo di sangue, non certo siamo espatriati a migliaia nei Paesi vicini. Che poi sarebbe da capire da quali guerre fuggono.
Eravamo rimasti ai 24.500 accolti in Italia. Il 13% originari della Guinea (nessuna guerra in atto, economia povera e in lento sviluppo, grandi risorse minerarie); il 12% viene dalla Nigeria (nessuna guerra in atto, l’economia più forte del continente avendo superato anche il Sud Africa, risorse di ogni genere fra cui spiccano quelle petrolifere, metà cristiani e metà musulmani); l’11% provengono dal Bangladesh (nessuna guerra in atto, paese musulmano moderato a maggioranza sunnita; Goldman Sachs nel 2005 lo pronosticava tra le prime 11 economie mondiali entro 20 anni); un altro 10% sono gli originari della Costa d’Avorio (paese pacifico, dopo la guerra civile del 2010, e economia prospera e di grandi potenzialità); dal Gambia è arrivato un 9% (paese modesto, con un’economia ancora poco sviluppata, ma niente conflitti); anche dal Senegal arriva un 9% di immigrati (nessuna guerra, una democrazia semipresidenziale stabile, una economia in pur lento sviluppo); dal Marocco arriva il 5% (monarchia costituzionale, nessuna guerra, economia in lenta ma costante crescita); dal Mali il 5% (qui guerra civile nel 2012, ma le successive elezioni hanno portato a una relativa stabilità, comunque in media con molte altre realtà del continente africano).
Quindi? Non fuggono dalle guerre. E questo è il primo punto, per cui, salvo pochi casi, non possiamo ritenerli né rifugiati, né profughi né richiedenti asilo. Ci rimane migranti.
Esseri umani che cercano migliori condizioni di vita. Ci sta. Ma abbiamo completamente cambiato registro. Manca un pezzo, e importante, e così arriviamo alla “guerra”: migrano da disperati, con marce forzate lungo i Balcani o traversate rischiose in mari agitati su barche e gommoni che definire insicuri è poco. Quindi, per far ciò, hanno sì la spinta di una minaccia, hanno paura.
Ma allora da dove fuggono?
Fuggono da quello che loro stessi hanno cercato, ovvero dalla Libia ancora in fiamme e dai trafficanti, crudeli e spietati, ma ai quali essi stessi si sono rivolti (dalla Nigeria alla Libia la strada non è breve…).
Allora forse, e azzardo, non stiamo sbagliando i riferimenti territoriali quando diciamo che dobbiamo impedire ai gommoni di lasciare la Libia? Forse non è più efficace impedire a loro di arrivarci in Libia? Certo, perché è la Libia il problema, è li che si concentrano minacce e pericoli, scafisti e trafficanti di esseri umani, bande criminali di vario genere. È li che c’è la guerra, forse non ci vuole un genio per capire che in moltissimi da lì fuggono.
Perciò lo sforzo dell’Europa va concentrato sulla Libia, ma non sulle coste libiche. Sui Paesi d’origine, oggi ai margini del discorso e il cui ruolo di controllo è sottostimato e non stimolato. Un’Europa disunita ed egoista, più preoccupata di chiudersi dentro solide mura che di trovare soluzioni di lungo periodo non sembra avere la capacità di confrontarsi efficacemente con un fenomeno epocale.
Un’Europa a diverse velocità, a gestione sottilmente (e solo per alcuni) nazionalistica, che non sa e non vuole essere coesa e solidale, che abdica a ONG di dubbia affidabilità poi legate a cooperative e associazioni anch’esse tutt’altro che trasparenti, e non riesce a trovare il bandolo della matassa.
Ma che di questa dissertazione rimanga il nocciolo: capire, discernere con attenzione, conoscere, per poter poi prendere decisioni che siano efficaci e giuste, umane ma determinate. I nuovi fenomeni di non integrazione, emersi recentemente, lo pretendono. Prima che sia troppo tardi. E forse lo è già.