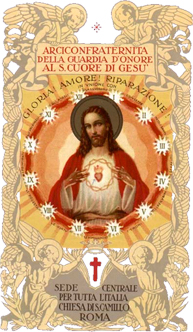Claire Ly non odia. Ed è strano. Scampata per il rotto della cuffia alla follia omicida del regime cambogiano dei khmer rossi – che le hanno fucilato il padre, il marito e due fratelli –, costretta a diventare contadina quando aveva un figlio per mano e uno in grembo, dopo un passato da insegnante di filosofia, Claire Ly non lascia trasparire nemmeno un accenno d’odio, uno sguardo offuscato, la smania di vendetta.
Claire Ly non odia. Ed è strano. Scampata per il rotto della cuffia alla follia omicida del regime cambogiano dei khmer rossi – che le hanno fucilato il padre, il marito e due fratelli –, costretta a diventare contadina quando aveva un figlio per mano e uno in grembo, dopo un passato da insegnante di filosofia, Claire Ly non lascia trasparire nemmeno un accenno d’odio, uno sguardo offuscato, la smania di vendetta.
A 66 anni, docente all’Istituto di Scienze e Teologia delle Religioni di Marsiglia, dopo il lungo travaglio dell’esule – sbarcò in Francia a 37 anni –, la conversione al cattolicesimo e il battesimo il 24 aprile 1983, si può pensare a un’astratta acquisizione di calma, un placido equilibrio interiore, un impermeabile nirvana. Nulla di più errato. È la sua storia a narrarlo.
Ospitata dal Pime (Pontificio istituto missioni estere di Milano), Claire Ly ha raccontato la sua vita a una folla di gente stipata nel piccolo teatro del complesso, la sera del 17 ottobre, e ha presentato il suo nuovo libro, Mangrovia. Una donna, due anime, edito da Pimedit (159 pagine, 13 euro). Una canzone di Joan Baez, spezzoni di Urla del silenzio, il film di Roland Joffé sul regime di Saloth Sar, conosciuto alle cronache più buie della storia con l’epiteto Pol Pot. Tra il 1975 e il 1979, il suo regime di stampo leninista-maoista, rurale e autarchico ha deportato la popolazione nelle grandi aree rurali, costringendola a pesanti privazioni, maltrattamenti, lavori da bestie da soma.
Tra campi di sterminio, malattie, malnutrizione e omicidi sommari, si stimano circa 2 milioni di morti su una popolazione che allora era di 8. Un quarto di cambogiani, in appena quattro anni di dittatura.
Un computo da rabbrividire. In un territorio di circa 181 mila chilometri quadrati sono state rinvenute: 189 prigioni, 380 fosse comuni di cambogiani giustiziati, 19.408 fosse comuni di cambogiani morti per fame e stenti. «C’è solo dolore in Cambogia, non c’è domani in Cambogia», ripetono le parole di Joan Baez mentre Claire Ly racconta dell’assassinio dei suoi, eliminati «perché borghesi, perché intellettuali». Perché contrari alle prospettive di un’ideologia che voleva imporre l’uguaglianza tra le diverse classi sociali. Tutti insieme, a lavorare la terra, ciascuno uguale all’altro, indipendentemente da quello che era stato. Pol Pot volle fare tabula rasa, polverizzando privilegi di casta e di ceto. E ci riuscì. Claire Ly era poliglotta. Conosceva la lingua khmer quanto il francese (la Cambogia fu protettorato di Parigi dal 1863 al 1941) ma, per sopravvivere, le conveniva stare zitta.
Così fece per i due anni di lavori forzati che le erano stati comminati in quanto intellettuale. La filosofia buddista predica il distacco e la disaffezione, per scampare dalla schiavitù del mondo. Ma nella tragedia di un popolo oppresso, schiacciato sotto il tacco duro del comunismo più perverso, Claire Ly non riusciva a sopportare il dolore senza un grido di rivolta: «Perché tutto questo? Perché proprio a me?».
Un urlo silenzioso, perché «dovevo mantenere queste cose nel segreto del mio cuore». L’impassibilità, il distacco dalle sofferenze, insegnata dal buddismo ha la sua radice nell’idea di karma: le fatiche che si scontano oggi sono conseguenze di errori e malefatte compiuti nel passato. «Ma non potevo accettare che le persone che amavo fossero morte per colpa dei loro peccati». L’ingiustizia non trovava risposta, e «scivolavo nei tre sentimenti peggiori della morale buddista: l’odio, la collera e la vendetta».
Quando odiavo il dio occidentale Tuttavia, la filosofia apre una via d’uscita: «Tra i consigli di Shakyamuni, il Buddha, per superare i momenti di tentazione, vi è quello di creare un “feticcio”, un oggetto mentale sul quale scaricare tutte le colpe, tutti gli odi repressi e giustificati per liberarsi dalla gravità del male». A questo oggetto, Claire Ly diede un nome: il “dio degli occidentali”. «Il comunismo deriva dal marxismo, che a sua volta si è formato nell’età industriale europea», spiega la cambogiana.
Con questa entità, Claire Ly ci ha fatto a pugni costantemente, per due anni. Gli parlava, gli rinfacciava ogni malignità, l’assurda reprimenda per un dolore da lui causato a un popolo inerme. Finché la stagione dei campi di lavoro finì e lei divenne una compagna contadina, secondo i khmer rossi. «Quel giorno stesso, a tarda sera, ho chiesto al “dio degli occidentali” di applaudire alla mia vittoria. “Non vedi come sono stata brava?”, gli dicevo. Eppure non lo ha fatto. Dio è rimasto in un silenzio assordante. Non lo sentivo semplicemente come assenza di rumore, ma come un’assenza abitata». L’irruzione di qualcosa – o di qualcuno – di indicibile. Nel male assoluto, il Dio degli occidentali si era fatto presenza.
L’esilio a Marsiglia L’inizio della conversione è proprio qui, nel rinfacciare il proprio male a un’entità accolta perché presente. Un dolore che non schiaccia, ma apre. Con la caduta del regime di Pol Pot e l’invasione delle truppe vietnamite del territorio cambogiano, Claire Ly si carica delle poche cose in suo possesso, prende i figli e parte. Direzione: Marsiglia, in Francia, complice la conoscenza della lingua, che tuttavia non riesce a evitarle di sentirsi straniera, non voluta, sanguisuga del sistema assistenzialista dell’Eliseo. «Avevo perso quello che Albert Camus chiamava il “rapporto tra la terra e il piede”. In Francia ci si riempie la bocca del termine “integrazione”. A me fa paura. Significa “disintegrarsi” da ciò che era prima, dalla cultura delle origini. Preferisco il termine “adozione”, dove il rapporto è giocato nella libertà assoluta delle due parti».
Nel 1980 Claire Ly è in Francia. «A quel tempo pensavo a Gesù come a un maestro grande quanto Buddha». Fino all’incontro con il Vangelo: «È stato un brano di Giovanni ad accendere il mio interesse: “Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto”. Che fa da contraltare alla frase di Luca, che dipinge Gesù come nato sfollato: “Per loro non c’era posto nell’alloggio”. Il Dio dei cristiani conosceva la mia stessa sofferenza.
Buddha non ha mai preteso di essere un Dio, ma un maestro. Era l’immagine dell’uomo perfetto, senza difetto, e per questo fin troppo lontano da me. È un ideale. Gesù, che si è detto Dio, paradossalmente è più umano. Soffre nella carne, è vicino alle mie debolezze. San Tommaso dice: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo”, e lo afferma non perché incredulo, ma perché ha bisogno che Dio prenda sul serio la sua integrità umana. Vuole vedere i segni del dolore, perché i suoi siano illuminati».
La conversione al cattolicesimo non è stata un’inversione. Claire Ly non ha fatto tabula rasa della sua antica tradizione, radicata nel terreno delle pianure della Cambogia. È stata attratta da Cristo, Claire Ly, e non ha dovuto rinnegare nulla dell’insegnamento del Buddha. «L’incontro tra la saggezza orientale, vissuta secondo la via di mezzo insegnata da Shakyamuni, e l’amore folle di un Dio venuto a prendermi nel deserto del genocidio di Pol Pot» si sono abbracciati, permettendo la rivelazione senza disintegrare alcunché. «Ed è per questo che, ad oggi, mi muovo molto perché gli immigrati si sentano a casa nei loro luoghi d’esilio. Perché io sono la testimonianza vivente che due culture diverse possono convivere in una stessa anima».
Una nuova certezza Questo è il senso profondo dell’ultimo libro di Claire Ly, Mangrovia. La mangrovia è una foresta tropicale irrigata alternativamente da correnti d’acqua salata e di acqua dolce. È un fiorente habitat di specie animali e vegetali che, sviluppandosi sulla costa, protegge dalla furia degli tsunami. Non è facile vivere tra due acque, così come non è facile vivere tra due anime. Su questo parallelismo si gioca tutta la trama del libro. Ravi, buddista, e Soraya, cristiana, sono due cambogiane, entrambe scampate al massacro di Pol Pot, entrambe esuli in Francia. Tornano insieme periodicamente a Phnom Penh e a Battambang, città d’origine, per rivivere insieme il passato sotto la luce nuova della diversa fede.
Così, le anime di Claire Ly si sdoppiano in due maschere che dialogano delle proprie certezze, le verificano e le mettono sul piatto del giudice: il cuore, che non risparmia dall’inquietudine. «Ho finalmente la certezza che il mio Dio Testimone non è il frutto della mia immaginazione, ma che è Lui, il Dio di Gesù Cristo. Non è una certezza assoluta, stranamente è una certezza che si presenta, sempre, come una ferita».
Fonte: Tempi.it