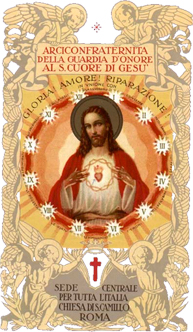«È incredibile quanto sia diventato difficile spiegare che il matrimonio non è una creazione del cristianesimo, e che quindi quando la Chiesa lo difende non difende qualcosa di suo. E quanto sia faticoso chiarire che l’etica sessuale degli antichi greci non è la stessa del marchese de Sade o di un Cecchi Paone qualsiasi».
«È incredibile quanto sia diventato difficile spiegare che il matrimonio non è una creazione del cristianesimo, e che quindi quando la Chiesa lo difende non difende qualcosa di suo. E quanto sia faticoso chiarire che l’etica sessuale degli antichi greci non è la stessa del marchese de Sade o di un Cecchi Paone qualsiasi».
Così parla a Tempi Francesco Colafemmina, filologo e grecista, autore del saggio Il matrimonio nella Grecia classica. Il libro – «formidabile, ricco di citazioni sorprendenti e di brillante scrittura» secondo lo scrittore e giornalista Antonio Socci – fa a pezzi la vulgata tradizionale inneggiante a una Grecia classica libera e gaia, la cui felicità sarebbe stata soffocata dall’avvento della buia morale cristiana.
Ha contro non pochi accademici, Francesco Colafemmina, ma dalla sua ha una documentazione che grida vendetta, e citazioni schiaccianti dei suoi amati autori greci. «Per cui – dice – se il fine recondito di certa propaganda era quello di sovvertire l’ordine fondato sul matrimonio tra uomo e donna, è arrivato il momento di un surplus di efficacia, chiarezza e coraggio».
Colafemmina, studiosi di fama come Michel Foucault (Storia della sessualità, Feltrinelli), il celebrato professore oxoniense Kenneth Dover (L’omosessualità nella Grecia antica, Harvard University Press), fino a Eva Cantarella (Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, Rizzoli) hanno scritto libri con tesi chiarissime fin dai loro titoli. La conseguenza è che negli ultimi cinquant’anni tutto il sistema accademico – tanti giovani in primis – è stato bombardato da questa teoria: le donne greche avevano mariti perlopiù bisessuali e/o pedofili. Quanto c’è di vero?
Più che una teoria questo oramai è un “dogma di fede”. Si può rispondere almeno in due modi: c’è una “via biografica”, alquanto rivelatrice ma che nel saggio non ho percorso, e c’è una via basata invece sugli scritti autentici, direi sui virgolettati degli autori greci.
Se è rivelatrice e inedita, inizi senz’altro dalla “via biografica”.
Be’, sarà un caso che molti degli accademici che hanno messo in giro queste idee siano omosessuali? Il filosofo Michel Foucault, professore al Collège de France, la più prestigiosa istituzione culturale francese, morì di Aids nel 1984. Anche John Boswell, docente all’Università di Yale e attivista gay (a Yale organizzò il Centro di studi lesbici e gay), colui che per tutta la vita tentò di far convivere morale cattolica e condotte gay (vedi il suo Cristianesimo, tolleranza, omosessualità. La Chiesa e gli omosessuali dalle origini al XIV secolo), morì di Aids a 47 anni, alla vigilia del Natale del 1994.
E l’elenco degli studiosi con biografie “interessate” sarebbe ancora lungo. Per la cronaca, Boswell è l’autore a cui si rifà Umberto Galimberti (senza ovviamente citarlo, com’è suo costume) per affermare che sant’Anselmo d’Aosta, canonizzato nel 1494 e proclamato Dottore della Chiesa nel 1720, fosse omosessuale. Galimberti lo scrive in una risposta a un lettore apparsa su D, il magazine femminile di Repubblica, il 28 luglio scorso. Purtroppo siamo a questo punto.
A grattare queste biografie si materializza il verso che Dante dedica a Semiramide, colei che «libido fé licito in sua legge». Ma veniamo ai testi. Cosa scrivono, davvero, gli autori greci sull’omosessualità?
In effetti è quello il punto nodale. È fondamentale però fare prima un passo indietro. Secondo il dogma ormai imperante, nell’antica Grecia la pedofilia (o efebofilia) sarebbe stata al centro di un vero e proprio rito di iniziazione: l’uomo adulto, l’erastés, aveva rapporti sessuali con l’adolescente, l’eròmenos, e così facendo lo formava anche spiritualmente. Capiamo bene che nella prospettiva di una formazione spirituale dell’adolescente avere rapporti pedofili diventava un merito! Di qui si è poi passati a definire il dogma dell’assenza di una “morale sessuale” nell’antichità classica attraverso la proclamazione dell’omosessualità come qualcosa di naturale.
Scusi Colafemmina, è un caso che l’oncologo Umberto Veronesi tempo fa affermò che gli omosessuali, a differenza degli eterosessuali, vivono un “amore puro” perché non volto alla procreazione, quindi un amore spirituale?
Non è affatto un caso, è esattamente la stessa folle visione. Attenzione però: quello dell’amore puro e spirituale non è altro che ciò che anche i gay del tempo affermavano per giustificare le loro pratiche, in un contesto sociale che invece le condannava risolutamente. L’errore madornale è che chi ripete oggi queste tesi non fa altro che ripetere ciò che dicevano gli autori omosessuali della Grecia classica. Oppure non fa altro che ridire ciò che Platone fa dichiarare ad alcuni suoi personaggi già noti come omosessuali nell’antichità (come Pausania nel Simposio) per arrivare però a smontare le loro tesi e a sostenere l’esatto contrario. È qui che è caduto Galimberti nell’articolo citato, scambiando Pausania, voce che Platone fa parlare ma non approva, per Platone.
Come dire che Manzoni la pensa come don Rodrigo… Ci spiega allora come mai nell’immaginario collettivo Platone passa per un autentico guru dell’omosessualità?
La promiscuità sessuale è tipica di taluni ambienti aristocratici ateniesi e Platone ci racconta anche questo. Eppure più che il soddisfacimento delle nostre pruderie storiche dovrebbe interessarci ciò che Platone ha davvero scritto sull’omosessualità: quattrocento anni prima di Cristo e duemilaquattrocento anni prima del Catechismo della Chiesa cattolica, Platone scrive che l’omosessualità è «contro natura». Nelle Leggi (636, c), ad esempio, si legge testualmente: «Il piacere di uomini con uomini e donne con donne è contro natura e tale atto temerario nasce dall’incapacità di dominare il piacere». Più chiaro di così!
La verità è che nella Grecia classica l’omosessualità non era affatto così diffusa come si crede, e soprattutto, cosa che conta ancora di più, non era istituzionalizzata. Eschine, politico e oratore ateniese del IV secolo avanti Cristo, nell’orazione Contro Timarco scrive che ad Atene era vietato aprire scuole e palestre col buio affinché i ragazzi fossero sempre sorvegliati; e che, anche se col consenso del familiare, era vietato dare un giovane a un amante omosessuale per ottenerne in cambio denaro o altri benefici.
Eschine scrive che era addirittura vietato agli adulti essere apertamente omosessuali praticanti. È interessante notare che gli omosessuali erano chiamati con un appellativo decisamente forte: cinedi (kinaidos al singolare), etimologicamente “colui che smuove la vergogna” o, per altri, e in un senso ancor più realistico, “le vergogne”.
Vuole dire che nella Grecia del IV e V secolo a.C. a uno come Cassano nessuno avrebbe intimato di scusarsi in ginocchio sui ceci?
Guardi, basterebbe leggere Aristofane per fare di Cassano un chierichetto. Celebre è il repertorio, che oggi si direbbe omofobico, che il commediografo greco dedica ad gay del suo tempo. Parliamo di epiteti come lakkoproktos, katapygon, euryproktos, parole assolutamente intraducibili. Altro che cassanate.
Gentilmente, traduca. Gli accademici potrebbero rimproverarla di non essere un filologo rigoroso.
Confidando nella libertà di tono di questo giornale posso dire che euryproktos, per esempio, può tranquillamente tradursi con “culaperto”. Espressione tipica della sospensione delle regole operata dalla commedia, ma certamente poco gay-friendly. L’omosessuale era un tipo comico e se volessimo seguire la teoria di Henri Bergson potremmo affermare che il riso della commedia è un cementante sociale.
Ma allora dove nasce il mito dell’ordinaria omosessualità del mondo greco?
I molti che erano in malafede (spesso perché gay) ci hanno marciato, e lo abbiamo detto; chi era in buona fede, invece, ha commesso lo sbaglio tipico della nostra epoca di “sessualizzare” tutto e troppo. I “ti amo” trovati nelle lettere di Leopardi a Ranieri o in quelle di Frontone a Marc’Aurelio, l’amicizia di Patroclo e Achille o di Eurialo e Niso, sono diventati immediatamente “chiari indici di omosessualità”.
Semplicemente leggiamo quegli scambi di amichevole e profonda affettuosità con gli occhi malati di oggi, interpretando male amicizie autentiche, sane e purissime. È un errore e, insieme, una grande perdita. Non è un caso che oggi sviliamo l’amicizia e il suo valore a una richiesta di un contatto su Facebook.
Che ci dice invece della figura della donna nella Grecia classica? Davvero il suo ruolo era nettamente inferiore a quello di una donna contemporanea o anche qui c’è qualche mito da sfatare?
Segregata, la donna, non direi proprio. Pensiamo solo alle feste religiose dell’Atene del V e VI secolo: si è calcolato che fossero addirittura 150 l’anno, se solo i tribunali pubblici restavano chiusi per le feste religiose per 54 giorni. Tra queste e un po’ di shopping, alle ragazze ateniesi non mancava certo la possibilità di adocchiare e sorridere a potenziali pretendenti. E poi avevano stratagemmi privati anche per contribuire alla scelta del marito.
Si riferisce al “caffè della consolazione” raccontato nel suo saggio?
Sì, per esempio. È stata una tradizione viva fino a qualche decennio fa in Grecia. Il pretendente, il gambròs, si recava nella casa della ragazza per incontrare il padre e magari concordare i termini della dote. La particolarità era tutta nel salotto in cui il giovane veniva accolto (nel museo di Kastorià, nel nord della Grecia, se ne conserva uno bellissimo). Nascosto da un quadro, un buco sulla parete permetteva alla figlia di osservare chi era arrivato fin lì per chiedere la sua mano. Se il giovane non le andava a genio veniva servito un caffè molto zuccherato, il caffè della consolazione, appunto. Il giovane non avrebbe avuto la mano della ragazza ma sarebbe tornato a casa con la bocca dolce.
Eppure si insiste sull’idea che la donna non fosse pari all’uomo.
Era l’ordine della società tradizionale, non si può e non si deve parlare di arretratezza, di discriminazione. È ridicolo guardare con cipiglio femminista e postmoderno alla condizione della donna nell’antica Grecia: quel ruolo e quell’ordine familiare sono il fondamento della società che ci ha trasmesso le opere di genio più importanti della storia.
Di più: sono il fondamento della società che ha fondato la civiltà occidentale. La categoria di emancipazione è anacronistica e noi non abbiamo alcun diritto di giudicare. Tra l’altro quella società e quel ruolo della donna non sono che quelli della nostra società contadina fino al secondo dopoguerra, da cui noi discendiamo direttamente.
Solo oggi molte ex femministe, specie negli Stati Uniti, dove sul tema c’è una pubblicistica molto interessante ancora poco nota in Italia, cominciano a rendersi conto di come il movimento femminista sia stato un’arma utile al capitalismo per asservire la donna, più che per offrirle una piena realizzazione.
Quali sono le assonanze tra matrimonio cristiano e matrimonio greco?
Sono fortissime. Guardi, possiamo essere precisi perché in questo ci aiuta molto l’Economico di Senofonte. Come per il cattolicesimo, anche per la Grecia classica il fine principale del matrimonio era la procreazione. L’ateniese del IV secolo avanti Cristo considerava i figli “una grazia di Dio”. Sempre da Senofonte sappiamo che l’altro fine del matrimonio era l’educazione della prole.
Per cui quanto a scopi principali siamo perfettamente in linea con quanto insegna la dottrina cattolica nella Gaudium et Spes. Non solo, nel matrimonio greco c’è anche la meta della castità coniugale. Oltre che in Senofonte, la sophrosyne, un concetto assolutamente analogo a quello di castità, lo troviamo in Plutarco e in autori come Carìtone d’Afrodisia.
Dov’è allora la differenza?
Per certi versi si può trovare nell’indissolubilità, elemento che il cristianesimo ha portato a pienezza e purificato. Le nozze per gli antichi greci non erano legalmente indissolubili come per i cristiani. Eppure anche su questo tema quello che solitamente non si legge è che il rapporto monogamico è in qualche modo insito nella cultura greca.
Basterebbe leggere l’Andromaca (vv. 11-179), in cui Euripide si lancia in un nobilissimo elogio della fedeltà monogamica, come del resto fa anche nell’Alcesti. È però forse di Plutarco la più bella celebrazione del vincolo sacro: nell’Amatorius (767 D-E) si arriva ad affermare che l’affetto per le proprie mogli è «simile alla partecipazione ai grandi riti sacri».
Infatti leggendo Plutarco di Cheronea sembra di avere davanti un autore cristiano, non siamo lontani dallo zelo e dal pathos delle lettere paoline. I Precetti coniugali – opera plutarchea che lei riporta integralmente in appendice al saggio – possono essere considerati una sintesi della visione che la Grecia classica aveva dell’etica matrimoniale?
I Precetti coniugali (Gamikà Paranghélmata) sono in effetti una lettura strabiliante se pensiamo che provengono da una fonte pagana. Furono composti da Plutarco in occasione del matrimonio di due suoi allievi, Polliano ed Euridice, nel I secolo dopo Cristo. È un’opera agile e godibilissima, un trattatello sulla vita coniugale ricco di massime, amorevoli consigli pratici e racconti esemplari, quasi un libro sapienziale se non fosse per l’allegria che lo pervade. Un’opera che personalmente farei leggere nei corsi prematrimoniali, spesso così scialbi.
Di certo i Precetti coniugali rappresentano bene quella che era l’etica matrimoniale per gli antichi greci, nutrita da valori saldi, da rapporti fondamentalmente monogamici propri di una solida civiltà contadina, valori poi trasferitisi nella società cristiana e nobilitati dalla sua etica. Non è certo un caso se l’opera plutarchea sarà poi ripresa da autori cristiani come Ugo da San Vittore (De amore sponsi ad sponsam) e san Girolamo (Adversus Iovinianum).
Colafemmina, qual è lo scopo ultimo del suo saggio?
In realtà è un augurio. Che una sintesi alta tra una ritrovata morale ellenica e l’etica cattolica possa offrire uno specchio in cui riflettere l’eredità inestimabile che abbiamo ricevuto dal mondo classico. E in cui vedere anche il rischio che comporta l’incamminarsi a passo svelto nella direzione opposta, quella del baratro.
Fonte: Tempi.it