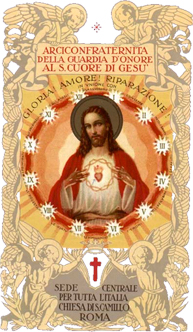Nell’incontro a porte chiuse che ha tenuto all’inizio della Quaresima, il 15 febbraio, con i preti della diocesi di Roma di cui è vescovo, Francesco ha tratteggiato in modo inatteso il percorso della propria vita, descrivendola come una serie di “passaggi”, alcuni luminosi, altri oscuri. Ripercorriamo parola per parola questa sua autobiografia, molto istruttiva della personalità di Jorge Mario Bergoglio, nella trascrizione ufficiale che ne è stata diffusa e che rispetta il disordine della sua parlata in lingua italiana.
Nell’incontro a porte chiuse che ha tenuto all’inizio della Quaresima, il 15 febbraio, con i preti della diocesi di Roma di cui è vescovo, Francesco ha tratteggiato in modo inatteso il percorso della propria vita, descrivendola come una serie di “passaggi”, alcuni luminosi, altri oscuri. Ripercorriamo parola per parola questa sua autobiografia, molto istruttiva della personalità di Jorge Mario Bergoglio, nella trascrizione ufficiale che ne è stata diffusa e che rispetta il disordine della sua parlata in lingua italiana.
La prima fase è di ascesa rapida e folgorante verso quella che più avanti egli definirà “onnipotenza”:
“Appena ordinato, sono stato nominato superiore l’anno dopo, maestro dei novizi, poi provinciale, rettore della facoltà… Una tappa di responsabilità che è incominciata con una certa umiltà perché il Signore è stato buono ma poi, con il tempo, tu ti senti più sicuro di te stesso: ‘Ce la faccio, ce la faccio…’, è la parola che più viene. Uno sa muoversi, come fare le cose, come gestire…”.
In effetti, il giovane gesuita Bergoglio celebrò la prima messa nel 1969, nel 1970 era già maestro dei novizi e nel 1973, a soli 37 anni, fu nominato superiore della provincia argentina della Compagnia di Gesù. Ricoprì questa carica fino al 1979, con successore un gesuita a lui vicino, Andrés Swinnen, e poi fu rettore fino al 1985 del Colegio Máximo di San Miguel.
Va notato però che già in questa sua fase di successo affiorava in lui un’inquietudine interiore, che nel 1978 cercò di risolvere recandosi “per sei mesi una volta alla settimana” da una psicoanalista ebrea, “che mi ha aiutato molto, quando aveva 42 anni”, come ha rivelato lui stesso l’estate scorsa nel libro-intervista col sociologo francese Dominique Wolton.
Ma ecco il secondo “passaggio” della sua autobiografia, non più ascendente ma di discesa a picco, che papa Francesco ha raccontato così ai preti di Roma:
“Ed è finito tutto questo, tanti anni di governo… E lì è incominciato un processo di ‘ma adesso non so cosa fare’. Sì, fare il confessore, finire la tesi dottorale – che era lì, e che non ho mai difeso –. E poi ricominciare a ripensare le cose. Il tempo di una grande desolazione, per me. Io ho vissuto questo tempo con grande desolazione, un tempo oscuro.
Io credevo che fosse già la fine della vita, sì, facevo il confessore, ma con uno spirito di sconfitta. Perché? Perché io credevo che la pienezza della mia vocazione – ma senza dirlo, adesso me ne accorgo – fosse nel fare le cose, queste.
Eh no, c’è un’altra cosa! Non ho lasciato la preghiera, questo mi ha aiutato tanto. Ho pregato tanto, in questo tempo, ma ero ‘secco come un legno’. Mi ha aiutato tanto la preghiera lì, davanti al tabernacolo…
Ma gli ultimi tempi di questo tempo – di anni, non mi ricordo se era dall’anno ’80… dall’’83 al ’92, quasi dieci anni, nove anni pieni –, nell’ultimo tempo la preghiera era molto in pace, era con molta pace, e io mi dicevo: ‘Cosa accadrà adesso?’, perché io mi sentivo diverso, con molta pace.
Facevo il confessore e il direttore spirituale, in quel tempo: era il mio lavoro. Ma l’ho vissuto in modo molto oscuro, molto oscuro e sofferente, e anche con l’infedeltà di non trovare il cammino, e compensazione, compensare [la perdita di] quel mondo fatto di ‘onnipotenza’, cercare compensazioni mondane”.
Desolazione, tempo oscuro, aridità, spirito di sconfitta… In effetti a partire dal 1986, quando nuovo provinciale dei gesuiti argentini divenne Víctor Zorzín, suo nemico acerrimo, Bergoglio fu rapidamente messo ai margini, spedito in Germania a studiare controvoglia e infine costretto a una sorta di esilio nella città di Córdoba, tra il 1990 e il 1992, senza più alcun ruolo.
Si sostenne con la preghiera. Ma da come oggi racconta, Bergoglio visse quegli anni con molta sofferenza, in tensione mai risolta tra senso di sconfitta e volontà di rivincita.
E tra chi allora deteneva il comando Compagnia di Gesù, sia in Argentina che a Roma nella curia generalizia, su su fino al superiore generale Peter Hans Kolvenbach, questa sua mancanza di equilibrio psicologico e quindi questa sua inaffidabilità erano divenute giudizio comune.
È forse per offrire un rimedio postumo a questo dissidio che papa Francesco, lo scorso 20 gennaio in Perù, parlando a braccio a sacerdoti e religiosi, ha voluto ricordare che a Kolvenbach – “un gesuita olandese che è morto l’anno scorso” – “volevo molto bene”, anche perché “si diceva che avesse un tale senso dell’umorismo che era capace di ridere di tutto quello che succedeva, di sé stesso e anche della propria ombra”.
Ma tornando al racconto che Francesco ha fatto della propria vita ai preti di Roma, ecco la terza e ultima serie di “passaggi”, tutti di nuovo ascendenti, a cominciare da quella “chiamata telefonica del nunzio” che – dice – “mi ha messo su un’altra strada”, quella dell’episcopato.
Era la primavera del 1992 e il nunzio vaticano in Argentina dell’epoca, Ubaldo Calabresi, gli telefonò per dirgli che sarebbe stato consacrato vescovo per desiderio dell’allora arcivescovo di Buenos Aires, cardinale Antonio Quarracino, che lo voleva come suo ausiliare.
Il seguito è un’ascesa inarrestabile: a vescovo coadiutore con diritto di successione, ad arcivescovo di Buenos Aires, a cardinale…
“E poi l’ultimo passaggio, dal 2013. Non mi sono accorto cosa è successo lì: ho continuato a fare il vescovo, dicendo: ‘Pensaci Tu che mi hai messo qui’”.
La svolta miracolosa che nel 1992 lo strappò dall’esilio in cui l’avevano confinato i confratelli della Compagnia di Gesù gli fu “preparata da Signore” – ha tenuto a sottolineare – proprio in quel periodo “oscuro, non facile”.
Ma quel periodo comunque non ha risolto, anzi, le sue inquietudini psicologiche, come provano due sue “confessioni” pubbliche fatte da papa, una all’inizio del pontificato e un’altra poche settimane fa.
La prima la confidò a degli studenti di scuole di gesuiti il 7 giugno 2013, a proposito della sua decisione di abitare a Santa Marta invece che nel Palazzo Apostolico:
“Per me è un problema di personalità: è questo. Io ho necessità di vivere fra la gente, e se io vivessi solo, forse un po’ isolato, non mi farebbe bene. Questa domanda me l’ha fatta un professore: ‘Ma perché Lei non va ad abitare là?’. Io ho risposto: ‘Ma, mi senta, professore: per motivi psichiatrici’. È la mia personalità. Non posso vivere da solo, capisci?”.
La seconda l’ha detta lo scorso 16 gennaio ai confratelli gesuiti del Cile (vedi foto), nel colloquio a porte chiuse poi trascritto e pubblicato col suo consenso su “La Civiltà Cattolica” del 17 febbraio, e riguarda il motivo per cui non vuole leggere gli scritti dei suoi oppositori.
Il motivo – ha detto – è quello di salvaguardare la propria “salute mentale”, o in altre parole la propria “igiene mentale”, formule che ha martellato ben tre volte in appena un minuto di conversazione e che presuppongono un apodittico giudizio di “insania” su chi lo critica, senza spazio per un confronto razionale:
“Per salute mentale io non leggo i siti internet di questa cosiddetta ‘resistenza’. So chi sono, conosco i gruppi, ma non li leggo, semplicemente per mia salute mentale.
Se c’è qualcosa di molto serio, me ne informano perché io lo sappia. Voi li conoscete… È un dispiacere, ma bisogna andare avanti. Gli storici dicono che ci vuole un secolo prima che un Concilio metta radici. Siamo a metà strada.
“A volte ci si domanda: ma quell’uomo, quella donna, ha letto il Concilio? E ci sono persone che il Concilio non l’hanno letto. E se l’hanno letto, non l’hanno capito. A distanza di cinquant’anni! Noi abbiamo studiato filosofia prima del Concilio, ma abbiamo avuto il vantaggio di studiare teologia dopo. Abbiamo vissuto il cambio di prospettiva, e c’erano già i documenti conciliari.
“Quando percepisco resistenze, cerco di dialogare, quando il dialogo è possibile; ma alcune resistenze vengono da persone che credono di possedere la vera dottrina e ti accusano di essere eretico.
Quando in queste persone, per quel che dicono o scrivono, non trovo bontà spirituale, io semplicemente prego per loro. Provo dispiacere, ma non mi soffermo su questo sentimento per igiene mentale”.