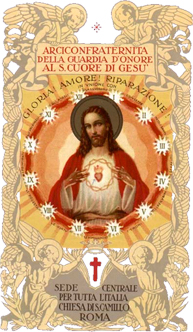La Vita di Malco, l´eremita prigioniero, scritta da san Gerolamo (347-420), è un fior da fiore del tesoro patristico. A secoli di distanza resta freschissima per immediatezza e per studiata essenzialità. La vicenda che vi si narra rimane infatti paradigmatica della grande battaglia cui il cristiano di tutti i tempi è chiamato per conservare comunque la fede e la purezza.
La Vita di Malco, l´eremita prigioniero, scritta da san Gerolamo (347-420), è un fior da fiore del tesoro patristico. A secoli di distanza resta freschissima per immediatezza e per studiata essenzialità. La vicenda che vi si narra rimane infatti paradigmatica della grande battaglia cui il cristiano di tutti i tempi è chiamato per conservare comunque la fede e la purezza.
A rileggerne il testo oggi, in clima di relativismo imperante e di rilassatezza totale dei costumi, vengono alla mente e al cuore tanti episodi che la cronaca ci suggerisce quotidianamente. Ma anche senza voler strafare, forzando il testo in modo inopinato e inopportuno, il martirio bianco cui il Malco del racconto di san Girolamo viene sottoposto dai suoi aguzzini non può non suggerirci di tornare ancora una volta con il pensiero e con la preghiera almeno a due delle grandi sfide che la fede vive nel nostro tempo.
Sono le sfide che la fede cristiana sopporta − distanti ma non lontane, diverse ma fino a un certo punto − da un lato nel ricco mondo dell’Occidente postmoderno e dall’altro nell’Oriente dei fanatismi violenti.
Come, cioè, non rivedere il monaco Malco che resiste alla tentazione grazie al totale affidamento al Signore nei volti dei molti, troppi cristiani perseguitati a causa della fede nel mondo dell’islamismo aggressivo e nel mondo del sessismo lascivo, dove tutto è oramai confusione e malizia, ambiguità e perversione, doppio-senso e promiscuità?
Dal “divorzio super-veloce” alla dittatura del gender”, dal pansessualismo alla sessualità pervertita, dalla castità minacciata alla semplicità oramai svilita, tutto da noi è tornato simile alle angustie cui fu sottoposto l’eremita Malco. E non solo per suggestione geografica, così accade, seppur diversamente, anche là dove la violenza fisica (e non solo culturale e morale) è all’ordine del giorno, là dove lo stupro e la schiavitù sessuale sono l’arma prediletta della cristianofobia.
Per gentile concessione dell’editore Città Nuova di Roma, proponiamo per questo ai nostri lettori di meditare ancora una volta le sfide cui la fede è sottoposto oggi attraverso alcuni passi significativi della Vita di Malco, l’eremita prigioniero contenuta nel volume XV delle Opere di Girolamo (edizione latino-italiana a cura di Claudio Moreschini) appena pubblicato con il titolo Opere storiche e agiografiche a cura di Bazyli Degórski. Malco viene fatto prigioniero dai nemici, resiste alla tentazione e così alla fine Dio lo libera dalla cattività.
* * *
[…] Coloro che vanno da Berea a Edessa incontrano, presso la via pubblica, un deserto attraverso il quale vagano in tutte le direzioni i Saraceni, che non hanno mai una dimora stabile. Il rischio di incontrarli fa sì che i viandanti di quei luoghi si uniscano, per stornare l’imminente pericolo con il mutuo aiuto. Nel mio gruppo vi erano uomini, donne, vecchi, giovani, bambini nel numero di circa settanta.
Ed ecco che d’improvviso, montati su cavalli e cammelli, piombano degli Ismaeliti, con i lunghi capelli sorretti da fasce, il corpo seminudo, trascinando dietro i mantelli e i larghi calzari; pendevano dalla spalla le faretre, brandivano gli archi allentati e portavano lunghe lance. Non erano venuti per combattere, infatti, ma per la preda.
Veniamo rapiti, dispersi, trascinati in diverse direzioni. Intanto io, che dopo lunga assenza ritornavo per prendere possesso della mia eredità e troppo tardi mi pentivo della mia decisione, vengo assegnato in sorte, assieme con una donna minuta, alla servitù di un unico padrone.
Veniamo condotti, anzi, portati in groppa a cammelli e, attraverso il deserto sconfinato, sempre temendo una disgrazia, stiamo abbarbicati piuttosto che seduti. Il cibo era carne mezzo cruda, la bevanda latte di cammelli.
Finalmente, dopo aver attraversato un grande fiume, giungiamo all’interno del deserto dove ci viene imposto di adorare, secondo i costumi dei pagani, la padrona e i suoi figli, e chiniamo le teste.
Là, come se fossi chiuso in carcere, dato che ho cambiato l’aspetto esteriore, imparo a camminare nudo, perché anche le intemperie dell’aria non mi permettevano di coprire nient’altro che le parti vergognose.
Mi vengono affidate delle pecore da pascolare e, in confronto alle mie sventure, godo del sollievo di vedere più raramente i miei padroni e gli altri schiavi. Mi sembrava di avere in me qualcosa del santo Giacobbe, mi ricordavo di Mosè: anch’essi un tempo erano stati pastori di ovini nel deserto. Mi nutrivo di formaggio fresco e di latte.
Pregavo di continuo, cantavo i salmi che avevo imparato nel monastero. Mi dilettavo della mia prigionia e rendevo grazie al decreto di Dio di essere divenuto nel deserto quel monaco che avrei mancato di essere in patria.
Oh, niente è al sicuro presso il diavolo! Oh, le sue insidie sono multiformi e indicibili! Così, la sua invidia mi trovò anche nel mio nascondiglio.
Il padrone – vedendo il suo gregge crescere e non riuscendo a scoprire in me niente di fraudolento (sapevo, infatti, che l’Apostolo aveva comandato che bisogna servire fedelmente i padroni come se si servisse Dio), e volendo ricompensarmi, rendendomi, con ciò, ancor più fidato a sé – mi diede quella compagna di schiavitù che un tempo era stata catturata insieme a me.
E, quando mi rifiutai e dissi che sono cristiano e non è lecito per me prendere la moglie di un uomo tuttora vivente (giacché suo marito, preso insieme a noi, era stato portato via da un altro padrone), quest’implacabile padrone montò in furore e cominciò a minacciarmi con la spada sguainata.
E, se non avessi subito cercato di tenere con il braccio la donna, avrebbe sparso il mio sangue su quel luogo.
Già era scesa una notte più tenebrosa del solito e, per me, troppo presto. Conduco la novella moglie in una spelonca semidiroccata e, avendo la tristezza al posto della pronuba, ci detestiamo a vicenda, ma non lo confessiamo. In quel momento veramente sperimentai la mia prigionia e, prostrato a terra, cominciai a piangere il monaco che perdevo, dicendo: «O me misero, sono stato tenuto in vita per tale scopo?!
Le mie scelleratezze mi hanno condotto a tanto che, con la testa ormai quasi canuta, io, casto, debba diventare sposo? Che mi giova aver disprezzato per il Signore i genitori, la patria, gli averi della famiglia se faccio ciò che, per non fare, disprezzai?
Forse giustamente sopporto questo perché ho desiderato vedere di nuovo la patria. Che facciamo, o anima? Periamo o vinciamo? Aspettiamo la mano del Signore, o ci trafiggiamo con il nostro pugnale?
Volgi contro di te la spada: bisogna temere di più la tua morte che quella del corpo. C’è un martirio anche per conservare la pudicizia. Che giaccia insepolto nel deserto il testimone di Cristo; io stesso sarò per me sia persecutore che martire!».
Dicendo così, trassi una spada che brillava anche nelle tenebre e, volgendo la punta contro di me: «Addio», dissi, «infelice donna! Abbi in me un martire piuttosto che un marito!».
Allora ella, gettatasi ai miei piedi: «Ti prego per Gesù», disse, «e supplico per la gravità di quest’ora: non versare il tuo sangue! Oh, se si deve morire, volgi prima il pugnale contro di me! Coniughiamoci piuttosto così! Anche se tornasse da me mio marito, serberei la castità che mi ha insegnato la prigionia, o perirei prima di perderla.
Perché vuoi morire per non unirti a me? Io morirei se tu volessi quest’unione. Abbi, dunque, in me una coniuge di pudicizia e ama di più l’unione dell’anima che del corpo.
I padroni pensino che tu sia mio marito. Cristo saprà che sei fratello. Facilmente saranno persuasi delle nostre nozze, quando vedranno che ci amiamo in tal modo».
Confesso che rimasi stupefatto e, ammirando la virtù della donna, amai di più questa coniuge. Mai, però, ho visto il suo corpo nudo. Non ho mai toccato la sua carne, temendo di perdere in tempo di pace ciò che avevo custodito in battaglia.
Trascorsero tantissimi giorni in tale matrimonio. Le nostre nozze ci avevano resi più amabili ai padroni. Non sospettavano affatto alcuna fuga e, a volte, potevo restare, fido pastore del gregge, un intero mese nel deserto. […]
Fonte: ilTimone