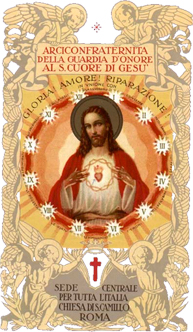Bisogna essere grati a Morgan Stanley, la grande banca d’affari americana, che in un suo studio del 17 gennaio scorso ha distillato i numeri decisivi di quella trappola recessiva che va sotto il nome di euro. Trappola per tutti i cittadini dell’Eurozona, tranne quelli che abitano nel territorio compreso fra Amburgo e Monaco (da nord a sud) e fra Berlino e Colonia (da est a ovest).
Bisogna essere grati a Morgan Stanley, la grande banca d’affari americana, che in un suo studio del 17 gennaio scorso ha distillato i numeri decisivi di quella trappola recessiva che va sotto il nome di euro. Trappola per tutti i cittadini dell’Eurozona, tranne quelli che abitano nel territorio compreso fra Amburgo e Monaco (da nord a sud) e fra Berlino e Colonia (da est a ovest).
Perché se è vero che il tasso di cambio ufficiale fra il dollaro e l’euro oscilla attorno a 1,33, il tasso corretto, quello che rifletterebbe le differenze di competitività e di fondamentali economici, è diverso da paese a paese: la Germania dovrebbe cambiare ogni suo euro contro 1,53 dollari, l’Italia invece contro 1,19. In mezzo, fra i tedeschi e gli italiani, ci starebbero tutti gli altri paesi dell’Unione monetaria (tranne la Grecia, che dovrebbe cambiare addirittura a 1,07).
Detto in altre, più comprensibili parole, le esportazioni tedesche corrono grazie a una moneta che è sottovalutata del 13,2 per cento rispetto al suo valore reale, invece quelle italiane restano al palo a causa di una moneta sopravvalutata del 12,1 per cento. Quando la Germania compete con l’Italia sui mercati mondiali, parte con un vantaggio del 25 per cento che dipende da una sola cosa: siamo tutti e due dentro all’euro, che premia loro e punisce noi, e non avendo più una moneta nostra noi italiani non possiamo intervenire autonomamente sul tasso di cambio.
Per sfangarla dobbiamo ricorrere alla “svalutazione interna”, cioè alla macelleria sociale fatta di tagli della spesa pubblica, nuove tasse e stipendi bloccati. Col bel risultato che i consumi scendono, il Pil si contrae, il gettito fiscale idem e ci ritroviamo più indebitati di prima.
Se recupereremo un po’ di competitività, servirà solo a pagare interessi sul debito pubblico diventati nel frattempo più onerosi; perché se è vero che i tassi d’interesse sul debito pubblico italiano sono un po’ diminuiti grazie anche all’austerity del governo Monti (ma in realtà grazie soprattutto alla Bce di Mario Draghi e alla sua decisione di acquistare i titoli del debito pubblico dei paesi in crisi sul mercato secondario “senza limiti”), è altrettanto vero che il rapporto debito/Pil si è velocemente logorato: fra il terzo trimestre del 2011 e il terzo del 2012, cioè sotto il governo Monti meno un mese e poco più di governo Berlusconi, siamo passati da un debito pubblico che era pari al 119,9 per cento del Pil a uno che è il 127,3 per cento: 7,4 punti percentuali in più!
Quello che abbiamo guadagnato sul fronte dello spread, lo abbiamo perso sul fronte dell’indebitamento in rapporto alla ricchezza prodotta. Non si era mai visto un deterioramento così cospicuo nel giro di un anno, se non ai tempi della manovra «lacrime e sangue» di Giuliano Amato nel luglio 1992: quell’anno il debito pubblico italiano arrivò al 116,2 per cento del Pil, mentre alla fine del 1991 si era fermato a 106,9.
Autorevoli autodenunce
Alcuni dicono: non è colpa dell’euro e neppure della Germania, è colpa dei paesi europei che, Italia in testa, non hanno fatto per tempo le riforme strutturali nelle quali si è impegnata la Germania alla fine degli anni Novanta, mentre si decideva la nascita dell’euro, e nei primi anni del nuovo secolo. Ci tocca farle oggi, ed è molto più difficile l’operazione ed è incerto il risultato finale. Ragionamento fallace. In realtà, la colpa della crisi dell’Unione monetaria europea è anzitutto dei tedeschi.
E a dirlo non sono politici italiani versati nella retorica antieuropeista e antitedesca per esigenze di campagna elettorale: no, a criticare l’architettura dell’euro e le politiche passate e presenti di Berlino sono autorevoli firme tedesche. Per esempio Wolfgang Münchau, l’editorialista del Financial Times che ha fatto tanto incavolare Mario Monti, e Jörg Bibow, economista che insegna al Levy Economics Institute del Bard College di New York ed è autore di uno studio del maggio scorso che spiega come a dinamitare l’euro sia stata la Germania sin dall’inizio.
Münchau scrive e ripete da anni che non sono state le riforme, genericamente intese, a produrre il boom dell’export tedesco, ma la moderazione salariale, che ha generato una riduzione del costo del lavoro per unità di prodotto. Se la questione principale fossero le riforme, l’Italia non doveva avere i problemi che ha avuto: il sistema pensionistico italiano era giudicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) uno dei più sostenibili del mondo già prima della riforma Fornero grazie alle riforme Dini e Maroni.
I sermoni della Merkel che invitano gli altri paesi dell’Eurozona a replicare la ricetta tedesca suonano insensati alle orecchie dell’editorialista tedesco: «Una riduzione nei costi per unità di prodotto rappresenta un guadagno solo se la fa un paese e gli altri no. Ma se la proponete come la politica che ogni paese della zona deve praticare, alla fine tutti si ritroveranno negli stessi rapporti di forza iniziali».
Mano d’opera e inflazione
Ma il vero fustigatore delle politiche di Berlino è Jörg Bibow; è lui che ribalta sulla Germania l’accusa di indisciplina che i tedeschi normalmente indirizzano alla periferia dell’Europa: è stata Berlino per prima a violare lo spirito di Maastricht e le indicazioni della Bce, e da lì sono derivati i mali attuali. Spiega Bibow nella sua ricerca “The Euro Debt Crisis and Germany’s Euro Trilemma” che l’euro e la creazione della Bce dovevano rappresentare il culmine di cinquant’anni di cooperazione monetaria europea volta a limitare le svalutazioni competitive, quelle incentrate sulla modifica dei tassi di cambio e che miravano di fatto a impoverire il proprio vicino.
Con l’introduzione della moneta unica i tassi di cambio sono spariti, ma la competizione si è spostata inopinatamente sul costo della mano d’opera e sul tasso di inflazione. «La regola aurea di una unione monetaria richiede che le tendenze nei costi per unità di prodotto nazionali stiano in linea con il tasso di inflazione comune al quale i membri dell’Unione si sono impegnati, ma questa è stata violata», scrive Bibow.
«Una realtà ben nota è che la tendenza del costo per unità di prodotto in Germania si è allontanata per un certo tempo dalla norma di stabilità del 2 per cento, arrivando a sfiorare lo zero in regime di euro (iniziato già l’1 gennaio 1999, quando diventa possibile fare operazioni finanziarie in euro, mentre la moneta entra in circolazione l’1 gennaio 2002, ndr). Quando la Germania divenne supercompetitiva, i suoi soci nell’euro persero competitività in una misura equivalente a una svalutazione del 20 per cento in epoca anteriore all’unione monetaria».
Quando, nel 1996, la Germania ha deciso unilateralmente di imbarcarsi in una politica di tasso di inflazione più vicino a 0 che a 2, e di perseguirla comprimendo i salari e la domanda interna, il destino dell’Eurozona è stato segnato prima ancora che nascesse: l’unione monetaria che stava per costituirsi attorno al comune impegno dei paesi partecipanti a perseguire «un tasso di inflazione inferiore ma prossimo al 2 per cento» (come ancora oggi si può leggere nella homepage della Bce) si sarebbe destabilizzata, era solo questione di tempo.
Un avvocato difensore della Germania e dell’euro a questo punto potrebbe intervenire dicendo: «Ma gli altri paesi dell’Unione Europea non potevano non capire il senso di questi fatti mentre accadevano, e avevano due possibili scelte: condizionare la loro partecipazione all’Unione monetaria al rispetto dei criteri da parte della Germania, oppure imbarcarsi anche loro in una politica di inflazione zero».
Più facile a dirsi che a farsi. Uno degli strumenti della strategia tedesca per il raggiungimento della ipercompetitività è stato proprio quello di incoraggiare l’indebitamento pubblico e privato negli altri paesi Ue: anziché reinvestire in Germania il suo attivo della bilancia del commercio con l’estero (che è cresciuto di 10 punti percentuali da quando è stato istituito l’euro!) facendo lievitare i salari, cosa che avrebbe fatto lievitare i consumi e quindi l’inflazione, i tedeschi hanno investito i loro soldi in titoli di Stato e obbligazioni bancarie dei paesi dell’Europa mediterranea, alimentando bolle immobiliari e indebitamento pubblico.
In questo la Bce è stata un alleato oggettivo della strategia tedesca, perché ha mantenuto il costo del denaro a un livello intermedio fra quello che avrebbe dovuto essere in Germania e quello che avrebbe dovuto essere nei paesi del sud Europa; col risultato appunto di scoraggiare l’indebitamento in Germania e di incoraggiarlo nei cosiddetti paesi Piigs (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna).
Scrive Bibow in un editoriale apparso su El Pais: «I flussi di credito dalla Germania furono fondamentali nel rendere possibile che persistessero divergenze all’interno dell’Eurozona e che crescessero gli squilibri. Lì risiede anche l’origine dell’odierna esposizione della Germania ai problemi di solvibilità nella periferia europea. Questi dati di fatto dovrebbero essere ben noti, ma l’interpretazione ufficiale scarica la colpa interamente sui paesi debitori».
La forza di America e Giappone
Il problema dunque l’hanno creato principalmente i tedeschi, e il problema non può essere risolto senza di loro; se non si prende in considerazione la soluzione del default selettivo nei paesi sotto pressione, che avrebbe come conseguenza la fine dell’euro, la via maestra dovrebbe essere quella della mutualizzazione del debito. I tedeschi, cioè, dovrebbero garantire i debiti degli altri paesi dell’Eurozona in cambio degli impegni al risanamento dei conti da parte di questi ultimi.
Ma da questo orecchio Berlino non ci sente, come spiega suggestivamente Martin Wolf (britannico di origini austriache), altro editorialista del Financial Times: «La Germania come vuole che sia organizzata l’Eurozona? Questo è quel che capisco della posizione delle autorità politiche e monetarie tedesche: no agli eurobond; no a ulteriori fondi per il Meccanismo di stabilità europeo (non hanno voluto concedergli la licenza bancaria che gli avrebbe permesso di procurarsi altro credito, ndr); no a una vera unione bancaria (l’unione entrerà in funzione fra parecchi anni e non prevederà nessuna tutela comune dei depositi, ma solo una supervisione delle attività delle principali banche, ndr); no a deviazioni dall’austerità fiscale, anche in Germania (in base al Fiscal compact nessuno Stato potrà più aumentare il proprio debito di una percentuale superiore allo 0,5 per cento del Pil all’anno, ndr); no al finanziamento monetario dei governi (cioè no alla svalutazione, ndr); no al rilassamento della politica monetaria dell’eurozona (cioè no a ulteriori riduzioni del costo del denaro, ndr); no a un boom creditizio in Germania. Il paese creditore, nelle cui mani sta il potere in tempo di crisi, sta dicendo “nein” almeno sette volte». L’unica cosa a cui la Germania dice sì è il doloroso aggiustamento strutturale dei paesi indebitati in cambio dei quattro soldi del Meccanismo di stabilità europeo. Ma la ricetta non può funzionare per almeno due innegabili motivi.
Primo, i casi di Irlanda, Grecia, Spagna e Italia dimostrano che le politiche di austerità producono recessione che logora il rapporto debito/Pil, in attesa di un ritorno alla crescita che forse renderà il debito in qualche modo sostenibile, ma non lo eliminerà.
Allora come potranno i paesi in crisi rispettare l’impegno, contenuto nel Fiscal compact e voluto da Angela Merkel, di ridurre di un ventesimo all’anno il loro indebitamento eccedente il tetto del 60 per cento del Pil?
Per raggiungere tale demenziale obiettivo i paesi Piigs dovrebbero semplicemente smettere di pagare le pensioni e di provvedere copertura sanitaria per qualche anno. Secondo: mentre l’Eurozona si dissangua a colpi di “svalutazione interna” per recuperare competitività, i paesi extraeuropei perseguono lo stesso obiettivo ricorrendo alla tradizionale svalutazione monetaria.
In sei mesi il dollaro Usa è passato da 1,22 sull’euro a 1,33, mentre è di pochi giorni fa la notizia che il governo giapponese ha minacciato la sua banca centrale che avrebbe messo mano ai suoi statuti e ridotto la sua indipendenza se non si fosse decisa a deliberare una svalutazione dello yen. Il presidente della Bundesbank Jens Weidmann ha gridato al pericolo di guerra valutaria innescata da una politicizzazione delle banche centrali, ma le sue urla, diversamente da quello che accade quando le emette in Europa, non gioveranno a nulla.
L’amara realtà è la seguente: Usa e Giappone si mangeranno come niente il recupero di competitività che l’Italia e gli altri paesi europei indebitati stanno riconquistando con sforzi sanguinosi.
Da cui un’amara quanto logica conclusione: l’Eurozona si avvia a implodere, e i tedeschi non hanno intenzione di fare nulla che eviti questo esito. Perché preferiscono la fine dell’euro alla fine della loro indipendenza politica ed economica in un’Europa politicamente ed economicamente unita.
Rodolfo Casadei
Fonte: Tempi.it