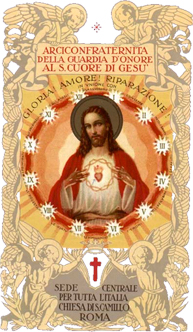Mio suocero mi racconta spesso di quando, in un paesino del basso mantovano, loro in campagna, i micini messi al mondo in sovrannumero dalla gatta di turno e presto abbandonati al loro destino sull’aia, li eliminavano a badilate. Avete mai fatto caso a come l’ambientalismo sia un fenomeno perfettamente cittadino? Chi infatti nella campagna ci vive ha una immagine parecchio diversa da quella da cartolina che s’immagina la gente ecologista di città, quella che non ha la minima idea di cosa voglia dire sgobbare quotidianamente a contatto sul serio con la natura, con la natura vera, quella che significa sempre e solo fatica, pericolo e insidia, e solo molto dopo, semmai, frutto da cogliere a patto di averlo coltivato senza vedere esiti per tempi assai lunghi.
Mio suocero mi racconta spesso di quando, in un paesino del basso mantovano, loro in campagna, i micini messi al mondo in sovrannumero dalla gatta di turno e presto abbandonati al loro destino sull’aia, li eliminavano a badilate. Avete mai fatto caso a come l’ambientalismo sia un fenomeno perfettamente cittadino? Chi infatti nella campagna ci vive ha una immagine parecchio diversa da quella da cartolina che s’immagina la gente ecologista di città, quella che non ha la minima idea di cosa voglia dire sgobbare quotidianamente a contatto sul serio con la natura, con la natura vera, quella che significa sempre e solo fatica, pericolo e insidia, e solo molto dopo, semmai, frutto da cogliere a patto di averlo coltivato senza vedere esiti per tempi assai lunghi.
Per l’agricoltore, il contadino o l’allevatore i parassiti sono una minaccia grave. L’agricoltore, il contadino e l’allevatore sanno bene che persino i boschi occorre siano puliti e rassettati, altrimenti finisce che si rimangiano in un solo boccone le terre strappate con il sudore della fronte al regno selvatico.
Il fatto è che, lontani dalla campagna e stretti nelle città, è facile rappresentarsi in maniera idilliaca ma irreale la vita della natura, persino il lavoro della campagna. E tenendo presente che la maggior parte della gente vive oggi in città, e che verso le città la popolazione mondiale si sposta con un movimento a crescita esponenziale (nel 2011 gli abitanti della Terra hanno raggiunto i 7 miliardi e si prevede che nel 2050 il 70 per cento di loro abiterà in agglomerati urbani, ma già oggi nei paesi industrializzati vive nelle città tra il 70 e l’80 per cento della popoalzione) è facile spiegarsi l’insorgere di una sorta di nostalgia collettiva per la natura abbandonata per necessità ma con qualche sospiro, per lo più confezionata in una idea del tutto mitizzata di quello che, oramai quasi con un marchio di denominazione di origine protetta, viene chiamato wildlife.
In questa chiave, la natura smette però di essere ciò che davvero è, vale a dire selvatica, pericolosa e ostile, per tramutarsi in un quadretto neoromantico che però nemmeno le fiabe autentiche descrivono davvero. A voler citare i nomi grossi, ci sarebbe da chiamare sul banco degli imputati per responsabilità culturali oggettive il ginevrino Jean-Jacques Rousseau: lui e quella sua invenzione di uno incontaminato “stato di natura” primigenio in cui il “buon selvaggio” scorrazzava come un’ape nel miele e a cui occorre presto fare ritorno abbattendo le corrette e corrosive strutture della civiltà. Ma anche lì c’è del dolo.
Rousseau ripeteva infatti certe frasi fatte che al tempo suo erano assai comuni; e se un copyright a quell’idea si dovesse proprio trovare, il suo detentore sarebbe piuttosto l’inglese Thomas Hobbes, il quale però, animato da ben diverso realismo, persino cinico e utilitaristico cantore di una incipiente forma di coercizione statalistica qual era, nel suo Leviatano lo “stato di natura” se lo ipotizzava ben altrimenti: «terribile e brutale», una guerra immane e continua di tutti contro tutti, dove la vita dell’uomo era «solitaria, povera (…) e breve».
Ma anche il rousseauvismo à la page che imperava all’alba del movimento ecologista contemporaneo va oggi stretto ai borghesissimi ambientalisti nuovi. Con loro, infatti, il quadretto arcadico imperniato sul “mito del buon selvaggio” si trasforma in un desolato paesaggio senza figure. Vista con i loro occhi dalla città, la campagna è sì un bene da proteggere, ma soprattutto dalla gente che vi abita: contadini e agricoltori, allevatori e mandriani, montanari e pescatori, che lavorando faticosamente la terra o le coste, inevitabilmente modificano il paesaggio (come avviene da che l’uomo ha preso ad abitare il tempo) e quindi sporcano quell’immagine incontaminata della natura che invece si vuole conservare così, immacolata e intonsa, soprattutto priva d’impronta e volto umani.
Non è più, dunque, un contrasto d’antan fra il sentimento della campagna e la freneticità delle aree urbane, ma una guerra senza quartiere all’uomo e alla sua attività sul territorio. Un nuovo modo, insomma, d’intendere ciò che è bene e ciò che è male definito da ciò che è “naturale” (il bene) e ciò che è toccato da mano umana (il male). Il contadino, l’agricoltore e l’allevatore non sono più visti, cioè, come garanzia e tutela della campagna, presidio intelligente e operoso delle sue peculiarità, custodia di una risorsa (un bene) per tutti, ma come i nemici primi e giurati della “naturalezza”. Curioso questo ritorno d’impeto a favore della natura selvatica in un frangente storico in cui invece si calpesta, forse proprio in nome della medesima visione delle cose, la natura intima, data e pertanto immutabile dell’essere umano.
Gli uomini della campagna sono infatti nemici del wildlife poiché intervengono fisicamente sul territorio, spostano zolle, modificano perimetri, deviano corsi d’acqua, spianano e accumulano, disboscano qui e rimboscano là, rimodellano coste per farvi ormeggi, rinchiudono bestie per terra e per acqua, e irreggimentano i campi. Gli animali addirittura li uccidono: per cibarsene o venderne le carni, per operare selezioni, per alterare il corso della natura. Nulla di fatto li distingue dai cacciatori di terra e di acqua, uccisori per puro diletto, coloro che invece, in un ordine autenticamente naturale di cose, sono in realtà degli ottimi guardiani degli equilibri esistenti.
Pagine sapide al tema le hanno dedicate due inglesi, il filosofo Roger Scruton e il sociologo Frank Furedi; a quest’ultimo si deve l’efficace immagine delle fattorie che agli occhi dei neoambientalisti di estrazione tutta urbana diventano «campi di concentramento rurali, dove gli animali, detenuti contro la propria volontà, vengono sistematicamente sottoposti alle pratiche più barbariche».
Il mito urbano della natura incontaminata sacrifica dunque il nemico umano sull’altare di una nuova morale, quella che per esempio ritiene peccato grave consumare carne animale (il culto conosce diverse espressioni, dai vegetariani ai vegani integrali), ma che pure ritiene un reato di lesa maestà non solo le biotecnologie ma l’impiego di fertilizzanti e di antiparassitari.
 Ma come le bugie hanno le gambe corte, anche le illusioni vanno poco lontane. Una volta espunto l’uomo dal paesaggio naturale, dal lavoro nei campi e dalla tutela del paesaggio in nome di un’idea astratta di wildlife, costruita al tavolino di un ufficio del centro cittadino, finisce che l’ambiente selvaggio non più calmierato e raffrenato dall’azione di continua bonifica svolta sul territorio dall’unico soggetto che la può pensare e realizzare, l’uomo, si trova dirimpetto alle aree urbane senza più il cuscinetto offerto dagli spazi coltivati.
Ma come le bugie hanno le gambe corte, anche le illusioni vanno poco lontane. Una volta espunto l’uomo dal paesaggio naturale, dal lavoro nei campi e dalla tutela del paesaggio in nome di un’idea astratta di wildlife, costruita al tavolino di un ufficio del centro cittadino, finisce che l’ambiente selvaggio non più calmierato e raffrenato dall’azione di continua bonifica svolta sul territorio dall’unico soggetto che la può pensare e realizzare, l’uomo, si trova dirimpetto alle aree urbane senza più il cuscinetto offerto dagli spazi coltivati.
La pressione del wildlife sulla città si fa in questo modo diretta e così, oltre a non potere in prima battuta più godere degli indispensabili frutti dell’agricoltura e dell’allevamento che la campagna garantisce anche alla città, l’ambientalista radicale urbano prepara il proprio destino inesorabile spalancando le porte a una natura terribile e brutale che reclama il sopravvento.
Nella lingua inglese, la coltura dei campi s’indica con il sostantivo husbandry, derivante da husband, marito, termine usato però nel secolo XIII anche per indicare il contadino, l’allevatore e l’agricoltore: cioè il capofamiglia che garantisce la casa e la sua economia (la “regola della casa”) “sposando” la natura che a lui si sottomette. Un matrimonio impegnativo come lo sono tutti, ma immancabilmente fecondo. L’antidoto alle chimere del neoinselvatichimento antiumano erano già tutte contenute in quel concetto.
Articolo tratto dallo speciale Più Mese di Tempi di dicembre
Fonte: Tempi.it