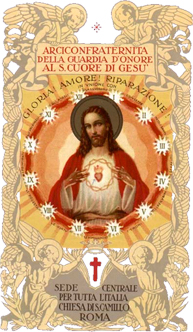Ebbene sì, Girolamo era un vecchio brontolone. Senza sapere questo, non si possono capire certe sue prese di posizione, e i suoi scritti possono risultare, talvolta, persino imbarazzanti: di primo acchito, dunque, San Girolamo lo si direbbe “vecchio dentro”.
Ebbene sì, Girolamo era un vecchio brontolone. Senza sapere questo, non si possono capire certe sue prese di posizione, e i suoi scritti possono risultare, talvolta, persino imbarazzanti: di primo acchito, dunque, San Girolamo lo si direbbe “vecchio dentro”.
Difficile immaginare che, leggendo queste parole, il patrono dei traduttori possa offendersi: in realtà non sappiamo neanche quando è nato, perché Agostino ne parla solo come di uno “molto anziano”, visto che lui gli faceva continuamente osservare il carico di esperienza e di erudizione che poteva vantare.
Quanto era anziano, questo saccente erudito? Beh, da quando Agostino comincia a dare notizie di lui, Girolamo sarebbe vissuto quasi altri trent’anni: o è morto ultracentenario, oppure sembrava (e voleva sembrare) più vecchio di quanto non fosse.
Il primo scambio di lettere tra i due è molto significativo per capire entrambi i personaggî: era il 394, e Agostino era prete da poco, quando aveva appena varcato la soglia dei quarant’anni. La prima lettera di Agostino a Girolamo era molto deferente e carica di ammirazione: «Nessuno mai fu noto a chiunque altro di persona tanto quanto lo è a me l’attività tranquilla, lieta e veramente nobile dei tuoi studi religiosi» (Ep. 28,1.1.). Tra i tanti complimenti, Agostino giunse anche a porre al grande traduttore delle obiezioni piuttosto radicali: «Forse io avrei dovuto limitarmi a scrivere fino a questo punto se intendessi accontentarmi di una lettera del tipo di quelle che si scrivono di solito; […] Quanto alla traduzione in lingua latina dei Libri Sacri canonici, non vorrei che tu vi attendessi se non seguendo il metodo da te usato nel tradurre il libro di Giobbe, in modo che, grazie all’uso di segni particolari, appaia in che cosa la tua versione differisca da quella dei Settanta, di cui preminente è l’autorità» (2.2.). Come si capisce facilmente, Girolamo – che era effettivamente un filologo di un certo calibro – aveva lavorato sul libro di Giobbe annotando con particolari segni le differenze tra le diverse versioni, in particolare tra quella ebraica e quella greca dei LXX.
L’ideatore di questo metodo era il grande Origene, delle cui fatiche relative alle traduzioni bibliche abbiamo già accennato qualcosa, e sempre Origene era stato l’inventore dei segni diacritici come l’asterisco e l’òbelon (da cui vengono anche Asterix e Obelix… ma questa è un’altra storia); qualcosa però stava accadendo, dentro Girolamo, e l’entusiasmo per Origene diminuiva mano a mano che, per altre cause, crescevano le sue difficoltà nell’analisi delle Scritture. Troppe le differenze tra le versioni greche, troppe varianti nelle traduzioni… Girolamo si stava decidendo a lasciar perdere le traduzioni di Origene e quelle dal greco, e a buttarsi tutto nella traduzione direttamente dall’ebraico. Agostino era stato avvertito di questo cambiamento, perché l’amico Alipio era stato a trovare Girolamo a Betlemme, e aveva notato i cambiamenti.
Cercando di provocarlo positivamente, Agostino – che teneva per ferma l’autorità della versione greca dei LXX – gli scrisse che trovava strano che i traduttori si fossero sbagliati su tante cose, compilando le versioni dai testi originali: «Ed esse [queste tante cose, n.d.r.] o sono oscure o sono chiare. Se sono oscure, è da credere che anche tu possa ingannarti su di esse; se sono chiare, non è da credere che essi vi abbiano potuto commettere degli errori» (ivi). Girolamo non era un talent scout, e non sospettò affatto che quel prete africano che gli scriveva non fosse uno qualunque, ma bensì che sotto la sua penna tutta la terra avrebbe tremato per lunghissimi secoli.
Il vecchio non gli rispose che intorno al 404, quando ormai la sua decisione di lasciar perdere il greco era presa, e la rispettiva via abbondantemente intrapresa. Non è improbabile che gli amici che dovevano consegnare le lettere abbiano veramente fatto un po’ di confusione, comunque Girolamo lamentò di aver ricevuto quella lettera, insieme con altre due, praticamente dieci anni dopo che Agostino l’aveva scritta: l’esegeta sottolineò acidamente che la lettera di Agostino conteneva «diversi quesiti (così li chiami tu) mentre a mio parere sono critiche dei miei opuscoli. Se volessi dare ad essi una risposta, questa assumerebbe le dimensioni di un libro. Mi sforzerò tuttavia, per quanto mi sarà possibile, di non oltrepassare la misura di una lettera, anche se un po’ lunga» (75, 1.1.).
La lettera era effettivamente lunghissima, ma nell’impeto della dettatura il vecchio Girolamo non dimenticò quell’osservazione caustica dell’allora giovane Agostino: «Un singolare sillogismo […]. Ti rispondo citando il tuo argomento. Tutti gli antichi esegeti […] hanno spiegato passi oscuri o chiari. Se oscuri, come hai tu osato spiegare, dopo di essi, ciò che essi non hanno potuto spiegare? Se chiari, è stata una fatica inutile voler spiegare ciò che non poteva loro sfuggire. […] Pertanto, sia in un modo sia in un altro, il tuo commento sarà inutile. […] Dovresti invece sentirti in dovere, come uomo, di permettere anche agli altri di fare ciò che permetti a te stesso! Ora, col mio lavoro ho inteso non tanto cancellare le opere degli autori che mi hanno preceduto […], quanto mettere sotto gli occhi di tutti le espressioni saltate o corrotte dai Giudei, affinché i nostri fedeli conoscano il contenuto genuino della Sacra Scrittura redatta in ebraico» (6.20). E chiude, stizzito: «Se poi a qualcuno non garba il mio lavoro, nessuno lo costringe a leggerlo contro il suo volere; […] ho tradotto il testo divino come l’ho trovato in ebraico. Se per caso hai dei dubbi, interroga gli Ebrei! […] Finisco la presente chiedendoti di non costringere un vecchio veterano a riposo come me ad impugnare le armi e a mettere a repentaglio ancora la propria vita. Tu che sei giovane, dall’alta cattedra della dignità episcopale ove ti trovi, ammaestra i popoli, arricchisci i magazzini di Roma delle nuove messi africane […]» (21-22).
Certo, il sarcasmo di Girolamo sapeva essere sferzante: si sarebbe perfino tentati di pensare che il vecchio traduttore invidiasse il giovane vescovo, se si dà retta alle voci che girarono ai temi della morte di papa Damaso, vent’anni prima, quando pareva che Girolamo fosse uno dei papabili… Forse però quello che aveva indurito di più il vecchio cuore del principe dei traduttori era stata la morte della carissima amica Paola, che l’aveva seguito (anzi, “preceduto e accompagnato”) da Roma a Betlemme.
Agostino fu però abbastanza umile (nonché furbo) da sopportare le bizze del suo orgoglioso corrispondente, e le cose si sarebbero distese definitivamente, quando i due si sarebbero ritrovati insieme nel dare l’allarme contro la sorgente insidia pelagiana. Il giovane vescovo accolse, dunque, la rispostaccia del vecchio bisbetico, e riconobbe che aveva pure una certa parte di ragione, pur continuando a non capire come i LXX avrebbero potuto alterare la verità biblica, dal momento che risalgono perfino a prima di Cristo: «Riguardo alla tua traduzione, mi hai ormai convinto dell’utilità che ti sei proposto di raggiungere nel tradurre le Sacre Scritture dal testo ebraico, ch’era quello di mettere in risalto le parole saltate o alterate dai Giudei. Ti chiedo tuttavia d’indicarmi di quali giudei si tratta. […] Non riesco a immaginare per qual motivo avrebbero dovuto fare una simile cosa i traduttori della generazione precedente!» (5.34.).
Anche la lettera di Agostino era molto lunga, e riserva verso la fine una dichiarazione che ci rende un po’ più chiaro il motivo per cui si stava tanto accapigliando con Girolamo: «Quanti poi pensano ch’io sia geloso dei tuoi utili lavori [in effetti le lettere venivano sbirciate e spifferate un po’ da tutti, prima di essere recapitate, n.d.r.], capiscano una buona volta (se pur sarà possibile) perché non voglio che venga letta nelle chiese la tua versione dall’ebraico: non voglio ch’essa venga introdotta come una novità contro l’autorità dei Settanta e si vengano in tal modo a turbare con un grave scandalo i fedeli cristiani. Le loro orecchie e la loro mente sono infatti abituate a sentire quella versione già approvata dagli Apostoli» (5.35.).
Sembrerebbe un criterio tutto pastorale, così preoccupato dello “scandalo per la povera gente”, contrapposto a un criterio tutto scientifico, studioso invece dell’esattezza letterale del testo. In realtà, gli studî scientifici contemporanei rivalutano molto la ragionevolezza dell’argomento addotto da Agostino (argomento che anche Girolamo aveva sostenuto, da giovane… eh, sì, doveva esserlo stato anche lui!).
Passarono gli anni, l’eresia pelagiana sorse e fu gagliardamente combattuta da Girolamo e Agostino. Girolamo quasi ne morì di dolore, mentre Agostino mise mano alla «grande e difficile opera» del De civitate Dei, in cui venivano nuovamente gettate le basi della cultura occidentale, che doveva prepararsi a sopravvivere all’Impero romano.
In uno degli ultimi libri dell’opera, quando ormai Girolamo era morto e Agostino l’avrebbe raggiunto in pochi anni, il (non più) giovane vescovo si ricordò dell’(ormai defunto) vecchio prete, e parlando dei LXX spese per lui accenti carichi di stima e d’affetto, come sanno fare solo i vecchî che non perdono la giovinezza del cuore: «Della traduzione dei Settanta si ha anche la traduzione in latino, che usano le chiese di lingua latina, sebbene ai nostri giorni sia vissuto il prete Girolamo, uomo assai colto e conoscitore delle tre lingue, il quale ha tradotto i libri della Bibbia in latino, non dal greco ma dall’ebraico. Ma sebbene i Giudei ritengano valida la sua opera erudita e sostengano che i Settanta hanno parecchi errori, tuttavia le Chiese di Cristo giudicano che all’autorevolezza di tanti uomini, scelti per un’opera così grande da Eleazaro (che allora era pontefice), nessuno vada preferito. […] Lo Spirito che agiva nei Profeti quando hanno parlato, agiva anche nei Settanta quando hanno tradotto. È possibile che lo Spirito, con autorità divina, abbia suggerito un altro significato nella versione come se il Profeta avesse inteso l’uno e l’altro, poiché era il medesimo Spirito a parlare in ambedue i sensi, o meglio a esprimere il medesimo significato in modi diversi, cosicché, se non le medesime parole, almeno ai buoni intenditori apparisse il medesimo significato» (XVIII, 43).
Giovanni Marcotullio
Fonte: La Porzione