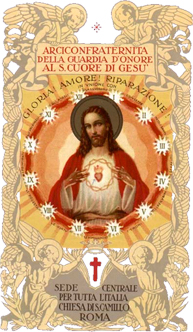Fra “lunga durata” e “congiuntura”: le forze in presenza nell’XI secolo
[Da F. Cardini (a cura di), Processi alla Chiesa. Mistificazione e apologia, Piemme, Casale Monferrato 1994] – Fonte: Contro la leggenda nera
Chi ha ritenuto, in passato, di poter studiare la crociata anzitutto come guerra, e guerra “santa”, ne ha ricercato origini e modelli sia nel cristianesimo marziale e trionfale di Bisanzio (quello delle lotte contro l’Islam dei secoli VIII-X, fra dinastia isaurica e dinastia macedone), sia nella sacralizzazione della guerra a sostegno della cristianizzazione dell’Europa orientale quale si configurò nell’Occidente degli imperatori carolingi e ottoniani.
Guerra contro i pagani e missione: un tragico legame rivelatosi molto presto, a partire cioè dall’ultimo quarto dell’VII secolo. In un mondo cristianizzato forzosamente ma non intimamente nelle istituzioni ma non ancora nelle strutture, nei riti ma non nei costumi, affiora – nelle guerre contro i Sassoni o contro gli slavi pagani – il tema della scelta fra il battesimo o la morte che il vincitore cristiano propone al vinto infedele. L’incontreremo più tardi, nelle chansons de geste che saranno sì specchio di lotta contro l’Islam, ma anche ricordo di quegli eventi. Il cristianesimo che presiedeva a tali atteggiamenti era quello d’impronta veterotestamentaria e apocalittica: un cristianesimo sacrale e regale, con le sue reliquie portate in battaglia, armi benedette, i suoi vescovi-feudatari più esperti nell’arte di schierare le truppe o in quella di stanar l’orso e inseguire il cinghiale che non nelle scienze e nei riti del Signore.
Un cristianesimo ereditato da quello legionario di Teodosio e di Giustiniano e percorso dal possente soffio barbarico dei figli della foresta e della steppa che avevano sì accettato il battesimo, e sinceramente magari, ma senza mai del tutto dimenticare i loro antichi dèi, signori delle battaglie e delle tempeste. Un cristianesimo quasi senza vangelo.
Ma al principio della crociata non ci sono gli stendardi dell’arcangelo Michele, non le croci-elsa-di-spada. Non solo queste cose, almeno. C’è, prima di tutto, il grande e sotto qualche aspetto repentino sviluppo demografico, agricolo, sociale, economico che prende avvio già durante gli ultimi decenni del X secolo e culmina nel successivo. Definirlo repentino è perché i terreni, scarsamente concimati, tendevano presto a esaurirsi e quindi interi insediamenti contadini potevano trovarsi nella necessità di mutar periodicamente sede.
Protagonista dell’XI secolo è, quindi, la strada, sulla quale s’incontrano i contadini in cerca di terra, i mendicanti, i pellegrini, i predicatori itineranti, i primi mercanti, i girovaghi più vari per ceto e per vocazione, da chi vive d’espedienti a chi cerca l’avventura cavalleresca. In un certo senso, in questi anni, tutti sono un po’ – magari per caso – dei pellegrini: nessuno, qualunque sia la ragione principale per cui viaggia, trascura di arrestarsi strada facendo, se li incontra sul suo cammino, nei santuari più o meno famosi che costellano l’Europa, da Santiago de Compostela a Mont-Saint-Michel, da Le Puy a Conques. In Italia, la via che dalle Alpi Occidentali scende per Piacenza e Lucca sino a Roma è la Via Francigena, la via dei pellegrini d’Oltralpe: essa conduce oltre la città del papa, sino al santuario di San Michele del Gargano e ai porti pugliesi da dove, passando l’Adriatico e proseguendo attraverso i Balcani, si può giungere a Costantinopoli, immenso reliquiario dalle dimensioni d’un’enorme metropoli. I maggiori e minori luoghi di pellegrinaggio sono collegati da un fitto reticolato di strade sul quale si dispongono, a guisa di tappe, pievi e abbazie all’ombra delle quali si aprono ospizi che offrono quotidianamente cibo e riparo e si organizzano periodicamente giorni di mercato in coincidenza con le grandi feste del santo locale (le “fiere”).
Questa mobilità, questo rigoglio di vita economica e culturale – dai cantastorie delle fiere nasceranno le chansons de geste e non mancheranno pellegrini che, visitando le abbazie, spanderanno attorno la fama delle loro biblioteche – s’inserisce in un mondo feudale ormai in crisi di trasformazione. Alla fine del X secolo, per sedare o quanto meno per contenere le continue guerre fra masnade feudali contrapposte che insanguinavano soprattutto la Francia e impedivano lo sviluppo dei traffici e la vita serena dei centri abitati, i vescovi di alcune diocesi del centro e del sud di quel paese si erano riuniti in sinodi dai quali scaturirono più tardi i movimenti della pax Dei e della tregua Dei. Nella pratica, prendendo atto dell’endemico stato di guerra, si dichiaravano sotto pena di scomunica intangibili certi luoghi (i mercati, le aree adiacenti i santuari) e certe categorie di persone (i chierici, i pellegrini, gli indifesi in genere), e sacrilego il combattere in certi giorni della settimana. Per assicurare il rispetto di queste prescrizioni, si organizzarono delle “leghe di pace”, sorta di armate popolari inquadrate però da feudali o da cavalieri “convertiti”, che si caricavano di punire i violenti e di ridurre alla ragione i riottosi.
Non erano soltanto misure di polizia: dietro le “leghe di pace”, non v’erano soltanto guerrieri “pentiti” e bravi contadini stufi del clima d’insicurezza. Il secolo XI è stato un tempo di riforma della Chiesa: riforma istituzionale, certo, ma anche orale. A promuovere entrambe erano alcuni grandi centri monastici: soprattutto l’abbazia di Cluny, grande motore dinamico di tutto il periodo, che patrocinò instancabilmente disboscamenti e costruzioni di nuove chiese, culti di santi e di reliquie e pellegrinaggi. Risale in gran parte ad essa l’iniziativa del pellegrinaggio a Santiago de Compostela, strettamente connessa alla reconquista cristiana della Spagna condotta certo dalle consorterie cristiane locali, ma anche da cavalieri-pellegrini provenienti dall’altra parte dei Pirenei. Non a caso, la saga di Rolando è legata a un passo pirenaico e alla lotta contro gli ispano-musulmani.
Non erano soltanto i contadini bisognosi di nuove terre, quindi, a muoversi. Sulla strada s’incontravano anche i rampolli d’un’aristocrazia feudale impoverita dal rialzo dei prezzi, dal sorgere dell’ economia monetaria, dal polverizzarsi dei patrimoni familiari; e i milites, i cavalieri che non possedevano sovente altro che le proprie armi e uno o al massimo due cavalli e che battevano le strade d’Europa in compagnia d’uno o d’un paio d’inservienti, ma accompagnati soprattutto dai loro sogni e dalla loro pelle dura. Il “cavaliere errante”, figura romantica dell’esistenza effettiva del quale molti hanno dubitato, era una realtà: ma assai meno “bella” (per quanto, dal punto di vista storico, non meno affascinante) di quanto non vorrebbero farci credere i romanzi cavallereschi scritti fra XII e XVI secolo. Nella pratica, doveva trattarsi di poveracci che, brigantaggio a parte, non avevano altra risorsa che l’ingaggio mercenario presso qualche potente. Per questo ceto di guerrieri, la Spagna costituiva una risorsa tradizionale, e non necessariamente dalla parte dei cristiani: non era raro il caso di guerrieri cristiani al servizio degli emiri arabo-ispanici o maghrebini.
La diaspora cavalleresca era comunque un caratteristico segno dei tempi. Caso limite ne furono i Normanni, le cui aristocrazie guerriere si sparsero un po’ dappertutto alla ricerca di terre e di danaro. Li troviamo mercenari nell’Italia meridionale, in Asia Minore al soldo degli imperatori bizantini, nell’Inghilterra sassone. In molti casi, ebbero fortuna: come gli Altavilla, che nel giro di pochi decenni si insediarono di Italia meridionale e Sicilia: o lo stesso duca di Normandia, Guglielmo, che strappò la corona d’Inghilterra: o Boemondo di Taranto, che con la prima crociata sarebbe divenuto nientemeno che principe di Antiochia.
La Chiesa del tempo – e in special modo la grande congregazione cluniacense nonché l’ambiente di prelati e intellettuali che avrebbe avuto la sua massima e politicamente più lucida espressione in Ildebrando di Soana, poi papa Gregorio VII – ebbe la geniale trovata di conferire un senso ecclesiale a queste guerre e a queste conquiste, quindi nell’inculcare in questi guerrieri degli ideali di servizio alla causa cristiana e alla cattedra di Pietro. Dalla Spagna all’Inghilterra alla Sicilia, i conquistatori incedevano recando nella destra il vexilum Petri, lo stendardo pontificio concesso loro dal papa che al tempo stesso giustificava e legittimava – almeno dinanzi alla Cristianità occidentale – le loro conquiste e prefigurava una sorta di rapporto feudale tra loro e il capo della Chiesa, dal momento che la concessione dello stendardo era un tipico gesto del signore feudale all’atto dell’investitura d’un vassallo. Nasceva così a poco a poco, su presupposti in apparenza contingenti, un nuovo modo di essere miles Christi, “guerriero del Cristo”: fino ad allora, tale espressione era stata usata per i martiri e poi per gli asceti; ora, la si impiegava a indicare quei cavalieri che accettavano di porre le loro forze al servizio della Chiesa. La nuova etica cavalleresca di lotta per la giustizia e di difesa del deboli nacque come etica penitenziale proposta a un ceto di combattenti professionisti per i quali la lotta e il rischio della vita divenivano, ora, mezzo di salvezza spirituale: e in questo è già in nuce l’essenza dello spirito di crociata.
Ma la lotta contro l’Islam, sulla quale si andavano catalizzando queste energie dalla Spagna alla Sicilia, si conduceva anche nel Mediterraneo, e soprattutto nel Tirreno dove le giovani marinerie genovese e pisana andavano consolidando le loro teste di ponte in Corsica e in Sardegna e respingendo intanto dallo specchio d’acque da esse controllato quel che restava dei regni corsari musulmani sorti fra VIII e IX secolo, con le loro tradizionali basi alle Baleari e lungo la costa settentriomale del continente africano. Questa lotta per il predominio sul mare e la sicurezza dei traffici, che condusse i marinai-mercanti cristiani a saccheggiare il porto saraceno di Palermo e a espugnare alcune città costiere nordafricane, comportava – per il fatto stesso di esser condotta contro degli “infedeli” – una tensione religiosa forse rozza, certo non disinteressata (in fondo, trattava di guerre fra corsari), ma che non si ha motivo di ritenere pretestuosa.
Così, in tutto il bacino mediterraneo-occidentale dalla Spagna alla Sicilia l’Islam – che non era peraltro affatto un’entità unitaria, ma che gli Occidentali immaginavano tale – arretrava, per la prima volta dai tempi del Profeta, sotto la spinta d’un Occidente ormai risvegliato. Una Cristianità rifondata attorno al pontefice romano, dalle città rigogliose di merci e di traffici, dai porti colmi di navi ormai protese alle rotte orientali, domandava un’idea-forza nuova che associasse il nome cristiano all’esplosione delle energie di cui si sentiva nuova. Sbocco logico e conseguente, a guardarlo col senno di poi, fu la crociata: non a caso taluni storici hanno definito “pre-crociate” le imprese cristiane di Spagna, di Sicilia e del Mediterraneo avvenute prima del “fatale” 1095. Ma, sul momento, a caldo, la crociata fu un frutto della contingenza per non dire del caso, una strada intrapresa quasi alla cieca sotto il premere di forze tanto impreviste quanto irruenti.
Il fiore della Cristianità e la schiuma d’Europa
Una storiografia non necessariamente sprovveduta ha per generazioni insistito su un mito storico che trova qualche riscontro nelle fonti stesse della prima crociata, ma che nella sua sostanza è infondato: quello d’una forte minaccia alla fine dell’XI secolo, alla Cristianità orientale e alle frontiere bizantine da parte dei Turchi, spietati guerrieri e musulmani fanatici (come accade sempre ai neofiti). La crociata avrebbe costituito la risposta cristiana a tale minaccia.
Vediamo i fatti. L’arrivo dei Turchi Selgiuchidi nel Vicino Oriente, la loro egemonia sul califfato sunnita di Baghdad, il controllo da essi assunto sulla stessa Terrasanta – secolare mèta di pellegrinaggi cristiani, ma anche musulmani – e il loro dilagare verso la penisola anatolica erano cose che avevano in effetti provocato sulle prime un certo allarme. In Palestina, si erano avute occasionalmente (e contro la tradizione musulmana) delle violenze contro i cristiani delle Chiese locali e i pellegrinaggi ai Luoghi Santi; intanto, ai confini con l’impero bizantino, l’offensiva dell’Islam era ripresa e nel 1071, a Nanzikert. i Selgiuchidi avevano riportato una grande vittoria. Ma si può dire che le cose si fossero arrestate a quel punto. In genere. I rapporti fra Bisanzio e le corti musulmane d’Anatolia erano buoni, quelli fra la corte di Costantinopoli e le corti califfali di Baghdad (sunnita) e del Cairo (sciita) amichevoli e il basileus veniva considerato il naturale protettore dei cristiani residenti in terra musulmana.
Quanto alle comunità cristiane soggette al potere politico dell’Islam e ai pellegrini, entrambi godevano d’un trattamento ispirato a tolleranza e perfino a sentimenti di carità e di simpatia: magari si spillava loro un po’ di danaro, ma le violenze erano qualcosa di assolutamente episodico; quanto alle “umiliazioni” che certi pellegrini cristiani narrano con sdegno di aver subito dagli infedeli, si trattava in genere di questioni di scarso conto. Insomma, nessuna grave minaccia, nessuna speciale violenza poteva giustificare, nello scorcio dell’XI secolo, un massiccio soccorso militare da parte degli Occidentali ai fratelli in Cristo d’Oriente.
Vero è che nella primavera del 1095, durante un concilio tenuto a Piacenza, papa Urbano II aveva ricevuto degli ambasciatori greci venuti, pare, a sollecitare un aiuto militare da parte dei Latini. Ma è probabile che questi cercassero semplicemente di reclutare come mercenari un po’ di quei cavalieri pesantemente armati che da decenni figuravano periodicamente ingaggiati negli eserciti imperiali. Del resto, lo scisma d’Oriente del 1054 era ancora fresco, e ben altre dovevano essere le preoccupazioni diplomatiche correnti fra Roma e Costantinopoli.
Ma nel novembre successivo, a Clermont in Alvernia, alla fine di un altro concilio, il papa rivolse ai convenuti una celebre allocuzione rivolta soprattutto all’aristocrazia feudo-cavalleresca del paese: dopo aver descritto in rapidi e coloriti tratti le sofferenze dei cristiani d’Oriente sotto la fèrula musulmana, esortò quanti avevano fino ad allora messo a repentaglio la vita e la salute eterna dissanguandosi nelle guerre feudali a partire pellegrini in Oltremare e a combattere per la fede. Chi avesse accettato, avrebbe avuto piena remissione dei peccati. Non di conquista della Terrasanta si trattava comunque, bensì di aiuto ai cristiani orientali. Insomma, nessun programma preciso oltre quello papale di liberarsi di tanto importuni guerrieri che turbavano l’Occidente in un momento nel quale era necessaria invece – finito il “periodo caldo” delle lotte per la riforma della Chiesa – un po’ di serenità.
L’appello di Urbano II non cadde nel vuoto. A riprova che il vero fine di esso consisteva nel drenare dall’Europa una certa quantità di forze perturbatrici, si noti che, a capo delle truppe crociate che cominciarono senza fretta ad ammassarsi tra Francia, Paesi Bassi e Germania nella primavera del 1096, v’erano alcuni fra i più bei nomi dell’alta aristocrazia feudale che la recente contesa fra il papa e l’imperatore e l’avvio d’una nuova fase economica dovevano aver messo in crisi. I principi che avevano accettato di guidare la spedizione erano uomini come Ugo di Vermandois fratello del re di Francia, Goffredo di Buglione duca della Bassa Lorena, Roberto duca di Normandia e fratello del re d’Inghilterra, Roberto conte di Fiandra, Raimondo conte di Tolosa e marchese di Provenza; più tardi, si sarebbe aggiunto loro anche Boemondo di Taranto, figlio di Roberto il Guiscardo conquistatore dell’Italia meridionale. Insomma, a mettere insieme i loro possessi e i loro diritti, i padroni di mezza Europa: perché accettavano – fede religiosa ed entusiasmo guerriero a parte – di cambiar aria, e per un periodo abbastanza lungo del quale oltretutto avevano coscienza, dato che taluni fra loro partirono con la famiglia e dopo aver sistemato i problemi della successione?
Evidentemente, era un’alta aristocrazia in crisi. Se i poveri cavalieri partivano spronati dalla mancanza di terre e di danaro, i principi partivano perché in un modo o nell’altro rimasti emarginati nel processo di assestamento continentale dopo i gravi avvenimenti della seconda metà del secolo. Qualcuno di loro pagava il fio d’essersi mantenuto fino all’ultimo fedele alla causa “sbagliata”, quella dell’imperatore Enrico IV contro il papa; altri erano rimasti sconfitti o si erano trovati in condizioni d’inferiorità nelle loro questioni dinastiche, come il duca di Normandia o il principe di Taranto che avevano nei loro famigliari i loro avversari più duri. Insomma, falliti di lusso alla ricerca d’un occasione per rifarsi o interessati a far passare un po’ di tempo prima di rientrare nelle loro terre e riprenderne il governo, pacificati o perdonati.
Ma l’appello di Clermont aveva trovato altre forze pronte ad accoglierlo. Durante tutto il secolo l’Occidente, e soprattutto certe città dell’Italia padana, della Germania renana, della Fiandra, erano state percorse da una quantità di movimenti religioso-popolari che si erano configurati (come i celebri “patarini”) come fiancheggiatori e spesso coprotagonisti della riforma della Chiesa, ma che avevano ben presto rivelato un aspetto “rischioso” nel loro carattere radicale e antigerarchico, nella loro carica escatologica tesa al sogno d’una Chiesa rinnovata secondo il modello della vita apostolica, una Chiesa povera. Anche nelle campagne, predicatori e profeti vaganti, di condizione spesso non facile a cogliersi, parlavano alle folle del regno di Dio che era alle porte. Questi sentimenti, queste attese, avevano ormai nel pellegrinaggio uno dei loro sbocchi più caratteristici: non c’è da meravigliarsi che l’appello di Clermont, ripreso e rimbalzato di bocca in bocca, avesse innescato – ben oltre le sue prospettive – un movimento di massa.
Tuttavia, in quei lontani fatti, c’è molto che ancora ci sfugge. Quei grossi gruppi di gente male o nient’affatto armata che prese la via dell’est pregando e depredando, sterminando le comunità ebraiche delle città renane e danubiane e desolando i villaggi contadini dei Balcani, giunte a Costantinopoli si accamparono alla periferia della città come uno spaventoso esercito di accattoni: i funzionari imperiali procurarono precipitosamente il loro passaggio in Asia, dove essi furono quasi totalmente sterminati dai Turchi, salvo qualche epigono che si accodò alle sopraggiunte colonne dei baroni. Eppure quegli oscuri fanatici cenciosi tennero alta durante tre lunghi anni di battaglie e di stenti la bandiera del loro cristianesimo millenario ed egalitario, continuando a comportarsi come se vedessero nei cavalieri e nel clero degli avversari dal punto di vista tanto sociale quanto spirituale; essi restano per noi un’incognita inquietante. I nomi dei predicatori vaganti o dei cavalieri antati che li guidavano – un “Pietro l’Eremita”, un “Gualtieri Senza Averi” – restano sospesi fra cronaca e leggenda, poco più reali di personaggi da chanson de geste. Una canzone epica ci parla della misteriosa confraternita dei “Tafuri”, strani poveri che della povertà hanno fatto il loro distintivo, quasi inermi eppur ferocissimi in battaglia, temuti dai cavalieri stessi quasi quanto dai Turchi, delle carni dei quali essi si sfamano dopo il combattimento.
Quel che sembra insomma di scorgere con una certa chiarezza – in quest’elemento “popolare” della crociata, disprezzato dai baroni perché a livello militare e disciplinare doveva essere un bell’impiccio, e guardato con sospetto dagli ecclesiastici – è la fine disperata e a suo modo eroica delle speranze più radicali offerte dalla riforma della Chiesa che, aperta all’insegna della lotta contro la gerarchia mondana e corrotta, si era chiusa (e non certo contro i programmi dei capi della riforma; forse però contro le illusioni di molti di coloro che l’avevano appoggiata) in una grande rivoluzione morale e istituzionale, ma al tempo stesso in una vigorosa restaurazione gerarchica. Forse, sui campi dell’altopiano anatolico, fra i gioghi del Tauro, nelle pietraie di Giudea, è morta (e non solo in senso traslato) quella parte della “pataria” che non ha avuto né la disciplina sufficiente ad accettare il nuovo ordine imposto nella Chiesa dai seguaci e dai successori di Gregorio VII, né il coraggio di passare risolutamente alla contestazione o addirittura all’eresia.
Pure, nei tre secoli successivi e forse anche oltre, uno spettro si è aggirato per l’Europa: quello della crociata popolare: lo vediamo affacciarsi nei vari momenti a metà tra pellegrinaggio e rivolta, fra pogrom antigiudaico e sommossa a carattere sociale. Questi poveri a tratti inferociti o ispirati della Gerusalemme Celeste sulla terra si chiameranno per volta, “fanciulli”, “innocenti”, “pastorelli”, “incappucciati” e così via; carismatici visionari o sinistri mestatori li guideranno; di solito, le loro imprese finiranno tragicamente nel loro stesso sangue, ma la loro sete e fame di sentire fino a molto lontano, fino alla “guerra dei contadini” della Germania del primo Cinquecento e al “regno” anabattista di Giovanni da Leida.
Una grande incognita. Non la sola, del resto, di quella grande spedizione che iniziatasi nel 1096 si concluse tre anni dopo, nel luglio 1099, con la presa di Gerusalemme. A ben guardare l’intera impresa fu un assurdo inspiegabile, un enigmatico non-senso: e la cosa più incomprensibile è che riuscì. O meglio: che riuscì potremmo affermarlo, se si potesse anche ammettere che il suo scopo era la presa di Gerusalemme; senonché lo divenne tardi, quando non v’era altra scelta né altra via d’uscita. Ma, fino ad allora, che cos’era stata?
Durante l’intero 1096 Urbano II aveva constatato con meraviglia – e, sembra di capire, anche con preoccupato disappunto – che il sassolino da lui gettato a Clermont stava divenendo una valanga: addirittura i novizi d’interi monasteri chiedevano di partire, mentre c’era chi abbandonava la famiglia e i beni: la crociata rischiava di scardinare l’ordine sociale, di dissolverlo in un vento di “santa” follia… Dall’altra parte del mare, a Costantinopoli, l’imperatore di Bisanzio, che avrebbe assoldato volentieri qualche decina o qualche centinaio di quei meravigliosi cavalleri pesanti tutto orgoglio e barbarie, non sapeva cosa fare quelle migliaia di pellegrini incivili e turbolenti. L’avvio della campagna militare vera e propria fu un disastro, l’attraversamento dell’Anatolia in piena estate una pazzia: non v’erano né programmi, né unità di comando, né infrastrutture logistiche, né piani di marcia. Pure, attraverso inenarrabili sofferenze e prove di coraggio paragonabili solo ad altrettanto grandi prove di ferocia, quest’accozzaglia di principi semifalliti, di cavalieri, di fanatici straccioni riuscì a varcare il Tauro, a conquistare una quantità di fiorenti centri della Cilicia e della Siria, a impadronirsi di città prestigiose come Antiochia ed Edessa, a strappare all’Islam la stessa Città Santa.
Un elemento di spiegazione può esser dato dal fatto che l’Islam dell’intera area siro-libanese-anatolica era profondamente disunito e conteso fra i califfati rivali, e che non era facile capire, per chi si vide arrivare addosso la valanga crociata, che cosa stesse accadendo. È un fatto che la prima crociata riuscì laddove le altre, assai meglio organizzate, fallirono l’una dietro l’altra.
I principati franchi di Siria
“Ecco che noi, che fummo occidentali, siamo diventati orientali. L’Italico e il Franco di ieri, una volta trapiantato, è divenuto un Galileo o un Palestinese (…) perché chi laggiù era povero, qui per grazia di Dio ha ottenuto l’opulenza; chi non aveva che qualche soldo, qui possiede dei tesori; chi non godeva neppure di un modesto possesso, qui si vede fatto padrone d’una città intera. Perché dunque tornare, dal momento che abbiamo trovato un tale Oriente?”.
All’indomani della conquista della Terrasanta uno dei più intelligenti cronisti della crociata, Fulcherio di Chartres, scriveva queste parole colme di letizia, quest’inno dei figli della Nuova Israele finalmente giunti nella loro Terra Promessa. E tale la Palestina doveva sembrare davvero, con la sua terra leggera che si lavorava facilmente e – a patto di disporre di un filo d’acqua – donava messi copiose, ai guerrieri e ai contadini abituati ai terreni pesanti, alle foreste così ardue a dissodarsi, alle brughiere inospitali. E poi, ancora, la frutta fresca dai dolci sapori e dai colori splendidi, l’ombra dolce delle oasi e dei giardini, le città bianche dai bazaar allietati dalle tinte delle stoffe preziose e odorosi di spezie. Predecessori anche in ciò dei moderni colonialisti, i crociati s’innamorarono delle terre conquistate: il “mal d’Asia”, per la cultura europea, cominciò da allora…
Ma quel mondo che agli uomini del nord poteva sembrar favoloso, era in realtà – e per causa loro – agonizzante. Ci volle un buon quarto di secolo (fino alla presa di Tiro del 1124) prima che i “Franchi” – come gli Orientali chiamavano gli occidentali – riuscissero a impadronirsi stabilmente della costa siro-libano-palestinese e della sottile fascia d’entroterra sino al Giordano e al Mar Morto. In questa prima fase della conquista, i crociati si erano comportati con stolta quanto barbarica imprevidenza: del tutto privi d’esperienza relativa ai territori che stavano conquistando e di comprensione culturale per le popolazioni di questi (all’inizio erano perfino incapaci di distinguere un cristiano orientale da un Ebreo o da un musulmano), avevano trattato l’area di conquista come un grande campo da saccheggiare. Il massacro, la ruberia indiscriminata, lo stupro furono la sola metodologia d’approccio al mondo siro-palestinese che essi seppero produrre. Ancor peggio si comportavano i marinai genovesi, pisani, veneziani che appoggiavano dalla parte del mare le campagne militari costiere: in cambio del loro efficace aiuto nella conquista dei centri litoranei, essi chiedevano il bottino e al massimo, più tardi, un quartiere nel quale impiantare i loro fondaci.
Questa politica, che sarebbe stata atroce ma realistica se si fosse trattato di passare sulla Terrasanta come un ciclone e di tornare ai castelli e ai villaggi d’origine, si rivelò suicida nella misura in cui molti crociati decisero di stabilirsi con le rispettiva famiglie nelle terre conquistate: soluzione in parte naturale e addirittura necessaria viste le scelte che, ponderate o no, erano state fatte quando parecchi erano partiti dall’Europa tagliandosi dietro i ponti (non si stava marciando verso la Gerusalemme Celeste? Non ci si avviava a conquistare un Cielo Nuovo e una Terra Nuova?). L’oscura e confusa ansia millenaristica che aveva indotto tanta gente a partire dopo essersi scossa dai calzari la polvere d’Europa, andava a poco a poco lasciando il posto alla presa di coscienza del fatto che quella sita fra Mar di Levante e Giordano era ormai la loro nuova patria. Assistiamo così alla nascita d’una “coscienza coloniale”.
Intanto, l’Occidente si era entusiasmato alle gesta dei liberatori del Santo Sepolcro e si aspettava naturalmente da loro le conquiste fossero mantenute: ecco un nuovo grosso problema, in fondo più arduo a risolversi che non quello della conquista stessa. Certo, i marinai genovesi, pisani e veneziani si ponevano troppi problemi. Essi restavano ben attaccati alle loro fiorenti città europee; andavano comunque rendendosi conto anche da parte loro che era necessario assicurarsi delle solide teste di ponte su un litorale al quale giungevano dal Golfo Persico e dal Mar Rosso le carovane cariche delle premerci del profondo Oriente.
Era ormai chiaro che alla lunga la politica di saccheggio e di sterminio si sarebbe tradotta in un suicidio degli stessi conquistatori. I pochi musulmani ed Ebrei superstiti dalle città conquistate fuggivano verso la Siria e verso l’Egitto portandosi dietro i loro cari superstiti, il po’ di masserizie che erano riusciti a racimolare e a salvare e, soprattutto, il loro odio, la loro rabbia, la loro disperazione. Se la croce era stata fino ad allora, fra loro, un segno disprezzato, ora essa era diventata oggetto di rancore e di cieca paura. Quello che rimaneva d’un tessuto urbano, portuale e viario fra i più antichi e floridi dell’intero bacino mediterraneo stava ormai cedendo il passo alla desolazione: le carovane non giungevano più agli empori del litorale; le campagne, rimaste prive di chi le lavorasse, inaridivano; lo splendido artigianato locale – stoffe, vetrerie, metalli sbalzati – languiva per mancanza di manodopera specialistica. E a che cosa mai poteva servire, agli stessi conquistatori, aver fatto il deserto e chiamarlo regno di Dio?
Così, i crociati si resero finalmente conto che non bastava trasformare le croci in moschee e drizzar croci dorate sulle torri della città. La crociata non era finita con la presa di Gerusalemme: cominciava allora. I principi e i prelati (e i cavalieri diventati principi, e i chierici trasformati d’urgenza in prelati) posero da canto le loro aspre rivalità e si diedero a organizzare le terre conquistate secondo i criteri feudali dell’Occidente, non senza tuttavia prendere atto e tener conto, in un qualche modo, d’una realtà profondamente diversa e che pian piano cominciavano a comprendere. Si elesse prima una sorta di governatore straordinario di Gerusalemme e dintorni, l’”Avvocato del Santo Sepolcro”, nella persona di Goffredo di Buglione; ma ben presto, scomparso questi, si addivenne alla più solida scelta monarchica. Primo re “latino” – o “franco” – di Gerusalemme fu Baldovino di Botilogne, fratello di Goffredo, che inaugurò una monarchia feudale sul modello di quelle europee, distribuendo città e villaggi in feudo ai suoi fedeli. Intanto, a nord del territorio direttamente controllato da lui e dai suoi vassalli (e grosso modo corrispondente all’odierno stato d’Israele) si stavano organizzando dei principati feudali fondati da altri capi della prima crociata: la contea di Edessa (conquistata nel 1098 dallo stesso Baldovino), il principato di Aritiochia fondato da Boemondo di Taranto, la contea di Tripoli organizzata da Bertrando, figlio di Raimondo di Tolosa. I legami istituzionali fra il re di Gerusalemme e questi grandi princiPi rimasero sempre in qualche misura ambigui, sospesi fra il rapporto vassallatico e quello federativo.
Pian piano, comunque, l’ordine s’impose e l’intera area urbana e rurale soggetta agli Occidentali (un’area che, nel periodo di sua maggior espansione durante il secondo quarto del xii secolo, andava dalle montagne del Taro e dal golfo di Alessandretta fino al Sinai e al golfo di Aqaba) tornò a fiorire; si riuscì a mantenervi o a richiamarvi gruppi di artigiani, di mercanti e di agricoltori musulmani o ebraici, e l’antica tradizione di più o meno cordiale vicinato fra genti di stirpe e religione diverse – un “carattere originale” del Vicino Oriente – ebbe il sopravvento. I rudi occidentali impararono dalle comunità che avevano assoggettato non solo l’uso dell’arabo (e anche del greco, dell’ebraico, del siriaco) e di tutta una quantità di tradizioni, consuetudini, accorgimenti che servirono loro a viver meglio in quelle contrade nelle quali l’arte del viver bene era (a differenza che in Europa) tanto raffinata: essi vi appresero anche l’arte e la misura orientali del ben governare, l’arte per loro difficile della tolleranza religiosa.
Nasceva così ben presto una società di parte almeno disposta all’integrazione, dove fra l’altro i matrimoni misti (anche negli alti strati della società, fra nobiltà cr0-ciata e aristocrazia sirocristiana e armena) erano frequenti. Una società “coloniale”, che un intelligente osservatore arabo del XII secolo, Usama ibn Munqidh emiro di Shaizar, descrive ad esempio così:
“Ci sono dei Franchi alcuni che, stabilitisi nel paese, han preso a vivere familiarmente con i musulmani, e costoro son migliori di quelli che sono ancor freschi dei loro luoghi d’origine (…).Venimmo alla casa di un cavaliere di quelli antichi, venuti con la prima spedizione dei Franchi. Costui, ritiratosi dall’ufficio e dal servizio, aveva in Antiochia una proprietà del cui reddito viveva. Fece venire una Sella tavola, con cibi quanto mai puliti e appetitosi. Visto che mi astenevo dal mangiare, disse: “Mangia pure di buon animo, che io non mangio del cibo dei Franchi, ma ho delle cuoche egiziane, e mangio solo di quel che cucinano loro: carne di maiale in casa mia non ne entra!””.
Se per giungere a risultati del genere la società laica ebbe bisogno di un iter abbastanza lungo, quella ecclesiastica per contro seppe organizzarsi rapidamente. In quella terra d’antiche tradizioni cristiane, si trattava tutto sommato soltanto d’istituire un’organizzazione ecclesiastica dipendente dal patriarca latino di Gerusalemme e di subordinarle di diritto o di fatto le varie gerarchie delle Chiese orientali.
Restava comunque il problema della difesa. I conquistatori della Terrasanta erano poche migliaia fra cavalieri e non, e molti, sciolto il voto, se ne erano tornati in Europa. Ma il paese aveva bisogno di venir presidiato continuamente: infatti, passato il primo istante di disorientamento, l’Islam sirogidano ed egiziano cominciava a passare al contrattacco, mentre le strade interne del paese e le aree suburbane non erano affatto sicure.
V’erano, sì, pellegrini che giunti dall’Occidente si sobbarcavano con entusiasmo l’onere di una campagna militare: ma poi ripartivano. Per il presidio delle frontiere e la difesa dei pellegrini inermi si erano semmai organizzati liberi gruppi di cavalieri che, a titolo penitenziale, sceglievano di rimanere in Terrasanta per difendervi le conquiste cristiane e per vivere in comunità e in povertà nei luoghi che aveva veduto il Salvatore. Nasceva una singolare, quasi paradossale – in quanto guerrie-ra – applicazione alle necessità contingenti del principio della “conversione” alla vita monastica, uno dei principi che in Occidente aveva costituito il lievito della vita della Cristianità.
Col tempo, quelle “fraternità” si trasformarono in veri e propri ordini religiosi, acquartierati in caserme-abbazie disposte lungo i confini e nei punti strategici del deserto a guardia delle piste carovaniere. Le loro regole si ispirarono variamente alla matrice benedettina (o alle norme canonicali d’origine agostiniana) e trovarono un estimatore d’eccezione nel più gru mistico dell’Occidente di allora, Bernardo di Clairvaux, un breve ma famoso scritto – il De laude novae meditae (“In lode della nuova cavalleria”) – propose la loro la vocazione militare come simbolo esteriore del combattimento spirituale da. combattersi contro il peccato.
Nacquero così gli ordini religioso-militari dei “Poveri Cavalieri del Cristo” (più tardi detti “Templari”), dei “Cavalieri di San Giovanni”, (detti “Ospitalieri”), poi dei “Cavalieri di Santa Maria” (detti “Teutonici”). Anche in Spagna, una situazione per parecchi versi analoga a quella siropalestinese (un’altra società “coloniale” con analoghi problemi d’integrazione e con una frontiera insicura e bisognosa d’esser presidiata) produsse ordini analoghi; e la stessa cosa accadde lungo un’altra frontiera della Cristianità, quella ad est dell’Oder dove i cavalieri, i mercanti e gli agricoltori tedeschi fondarono porti e città, castelli e abbazie, evangelizzando i popoli slavi e baltici con il terrore ma anche creando le basi d’una grande cultura e di una solida rete economica e amministrativa.
Di questo mondo ammirevole e sconcertante, i Templari rimangono l’incognita ancor più indecifrabile. Guerrieri coraggiosi e spietati e abilissimi banchieri, odiati come nessun altro “franco” dai musulmani eppure in frequenti contatti – e non solo culturali con l’islam, fedeli al loro voto di personale povertà eppure membri di un ordine che ai primi del Trecento fu sciolto sotto accuse infamanti, in un clima equivoco e persecutorio. Essi hanno lasciato, con le loro chiese, i loro castelli e la loro leggenda, l’ombra inquietante dei loro mantelli bianchi sull’Europa e sull’Oriente. Molte fonti europee attribuiscono loro vizi e peccati: magia nera e sodomia, crudeltà e usura; per contro, i loro acerrimi avversari arabi ce ne hanno lasciato un quadro improntato spesso a simpatia, ad ammirazione, ad amicizia. Ascoltiamo ancora una volta il sensibile e raffinato emiro Usama:
“Quando visitai GerusaJemme io solevo entrare nella moschea al-Aqsa, al cui fianco c’era un piccolo oratorio, di cui i Franchi avevan fatto una chiesa. Quando dunque entravo nella moschea al-Aqsa, dov’erano insediati i miei amici Templari, essi mi mettevano a disposizione quel piccolo oratorio per compiervi le mie preghiere”.
Terrasanta, Spagna, Baltico: dovunque ordini religioso-militari, dovunque crociati. La crociata era appena nata, il nome con il quale noi la indichiamo oggi correntemente non era ancor usato, e già i suoi primitivi obiettivi si modificavano, si distorcevano, si ampliavano, si diluivano. Prima soccorso all’Oriente cristiano, poi conquista e conservazione dei Luoghi Santi, poi trasformazione dei crociati in coloni e in monaci-cavalieri, quindi ancora nuovi fronti crociati in Spagna e nel nord-est europeo, infine come vedremo crociate interne alla stessa Cristianità. Più che un’utopia la crociata è una sorta di Proteo dalla mille forme, sempre la stessa eppur sempre diversa.
La “galassia crociata”
Il regno di Gerusalemme e i principati adiacenti non si possono certo considerare delle semplici entità politiche “occidentali”, ma non sono mai neppure riuscite a divenire entità politiche “orientali”. Rispetto all’Occidente, essi non hanno mai acquistato autonomia né spirituale, né economica, né politica, né militare. Del resto, non l’hanno mai cercata: al contrario! Essi avevano bisogno del papato e della Cristianità latina per mantenere la loro legittimità storica; dei pellegrini occidentali, che assicuravano loro – al pari dei mercati latini – i legami con la madrepatria e la giustificazione così spirituale come economica; di periodici aiuti militari dall’Europa contro un Islam in via di riorganizzazione e di consolidamento.
L’organizzazione delle grandi crociate del XII e del XIII secolo scandisce la crisi e l’agonia dei principati franco-siriaci. Tutte quelle spedizioni, nonostante vi prendessero spesso parte i più grandi sovrani della Cristianità, si conclusero con più o meno clamorosi fallimenti e costituirono in tutto o in parte delle manovre diversive rispetto al dichiarato scopo primario della difesa o del recupero della Terrasanta. La seconda crociata (1147-48) si organizzò in seguito alla caduta di Edessa nelle mani dell’atabeg (“governatore”) di Aleppo e Mosul; fu predicata dallo stesso Bernardo di Clairvaux e guidata dai re Corrado III di Germania e Luigi VII di Francia: ma s’infranse sotto le mura di Damasco, logorandosi in un assedio tanto assurdo (i Damasceni avrebbero potuto essere degli alleati contro l’atabeg) quanto vano. La terza crociata ebbe la sua principale causa nella commozione in Europa sollevata dalla riconquista musulmana di Gerusalemme effettuata nel 1187 da un grande condottiero curdo al servizio del califfo di Baghdad, Salah edDin (che noi conosciamo come “il Saladino”).
L’impresa, guidata dall’imperatore Federico I, dai re di Francia Filippo II Augusto e d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, si concluse con un nulla di fatto. L’imperatore morì in viaggio e i due sovrani di Francia e d’Inghilterra – peraltro rivali fra loro – si limitarono a dare un contributo alla riorganizzazione del regno crociato con una nuova capitale nella città portuale di Acri e permisero la fondazione di un nuovo regno crociato nell’isola di Cipro.
Dalla perdita di Gerusalemme l’idea di crociata trasse un primo importante spostamento: si trattava non più di difendere, bensì di recuperare la Città Santa. Tale il programma dei pontefici del Duecento, da Innocenzo III in poi; ma sarebbe rimasto inadempiuto. La quarta crociata, a capo della quale erano alcuni nobili francesi, tedeschi e italosettentrionali, ma che in realtà fu gestita soprattutto dal doge di Venezia Enrico Dandolo,il quale provvide la flotta per il viaggio, non giunse mai in Terrasanta; i crociati si fermarono a Costantinopoli dove, approfittando di una crisi dinastica, s’impadronirono della città e dell’intero impero bizantino che smembrarono fra toro dando vita all’esperimento del cosiddetto “impero larino di Costantinopoli” (1204-12(1), autentica beneficiaria del quale fu la repubblica di San Marco che poté monopolizzarne i traffici.
A Costantinopoli, con la presa da parte dei crociati, si erano ripetute scene di barbarie che tuttavia gli occidentali ornarono dei colori della fede religiosa e del senso di meraviglia dinanzi alle fiabesche ricchezze bizantine. Ascoltiamo un cavaliere” francese testimone oculare dell’impresa, il re e cronista Roberto di Clari:
“Dopo la presa della città e dopo che i pellegrini furono acquartierati, come vi ho già narrato, e dopo che i palazzi furono occupati, vi si trovò una straordinaria quantità di ricchezze. Il palazzo di Bucoleon era così ricco e così fatto che vi racconterò come.
Dentro questo palazzo, che il marchese (di Monferrato) aveva occupato, c’erano cinquecento sale tutte comunicanti e rifinite a mosaico d’oro; c’erano ben trenta chiese fra grandi e piccole. Una, che si chiamava la Santa Cappella, era così ricca e nobile che non v’era serratura né chiavistello né altro infisso che fosse di ferro, ma tutti erano d’argento; né c’era colonna che non fosse di diaspro o di porfido o di sontuose pietre preziose. Il pavimento della cappella era di marmo bianco così levigato e traslucido che pareva cristallo; e la cappella era tanto ricca e splendida che se ne potrebbe adeguatamente descrivere la bellezza. Entro questa cappella si rinvennero molti antichi reliquiari: vi si trovarono due pezzi della Vera Croce grandi come la gamba d’un uomo e lunghi mezza tesa; vi si trovò il ferro della lancia dalla quale Nostro Signore ebbe il costato trafitto e i due chiodi che Egli ebbe confini attraverso le mani e attraverso i piedi; vi si trovò in una fiala a cristallo gran parte del suo sangue; vi si rinvenne la tunica che aveva indossato, che Gli fu tolta quando lo condussero al Morir Calvario; vi si trovò la benedetta corona con cui fu incoronato fatta di giunchi marini acuminati come spade; vi si trovò anche la veste di Nostro Signore, e la testa di monsignor Giovanni Batti e tanti altri reliquiari che non vi potrei descrivere né dei quali vi saprei dire con esattezza il numero”.
Innocenzo III non approvò l’avventura di Costantinopoli; pure vi si adattò, scorgendovi se non altro un mezzo provvidenziale per la soluzione dello scisma d’Oriente. Comunque, durante il concilio del 1215, ribadì che uno dei principi veri della Cristianità rimaneva il passagium generale, la crociata per il recupero di Gerusalemme. Si organizzò così una nuova impresa, sotto la guida del legato pontificio ca1 essa adottò una strategia nuova, attaccandi i porti egiziani del delta del Nilo. Si pensava così che il sultano del Cairo, l’economia del quale si reggeva essenzialmente sui traffici di Alessandria e di Damietta, avrebbe volentieri ceduto Gerusalemme pur di indurre i crociati a sgombrare un’area tanto vitale dei suoi territori. Ma la campagna, condotta senza tener conto del regime delle acque del Nilo, finì in un disastro.
È incerto se si possa davvero considerare una crociata quella condotta, nel 1228-29, dall’imperatore Federico II: strana crociata, dal momento che fruttò al suo capo la scomunica di papa Gregorio IX. Il fatto era che il sovrano svevo negoziò col sultano del cairo Malik al-Kamil, discendente del Saladino, il ritorno pacifico d’una parte della città di Gerusalemme ai cristiani: il che dette luogo a un equilibrio molto precario, che andò a monte nel 1244 allorché la Città Santa venne presa d’assalto e conquistata dai nomadi provenienti dal Kwarezm e spinti a ovest dall’incalzare dell’ondata mongola.
E, con i Mongoli di Genghiz Khan e dei suoi eredi e successori, un altro capitolo si apre nella storia delle crociate. Il fatto che i principi mongoli avessero fama di tolleranza religiosa e addirittura di filocristianesimo (si ebbero allora, in Europa, confuse notizie sull’esistenza di comunità cristiane – cioè nestoriane – nell’Asia centrale ed orientale) dette luogo a illusioni appoggiate, fra l’altro, a speranze profetiche e a computi astrologici: si vagheggiò d’un’alleanza fra Occidentali e Mongoli che avrebbe stretto l’Islam in una morsa. La celebre leggenda del favoloso re-sacerdote cristiano d’Asia, il “Prete Gianni”, favorì queste illusioni; esse tuttavia svanirono col disgregarsi dell’immenso impero mongolo e col passaggio all’Islam, l’uno dopo l’altro, dei khan che – dalla Russia meridionale alla Persia – se ne divisero le spoglie.
La storia delle crociate come storia delle imprese militari nel Vicino Oriente volte alla conquista della Terrasanta si conclude, a parte qualche episodio avventuroso di minor portata, con le due sfortunate spedizioni di Luigi IX re di Francia: quella del 1248 contro l’Egitto che finì con l’imprigionamento di quel sovrano costretto a riscattarsi ad alto prezzo, e quella del 1270 contro l’obiettivo ancor più sviante del regno di Tunisi, ad attaccare il quale Luigi era stato indotto dalla politica del fratello Carlo I d’Angiò re di Napoli. Durante questa seconda spedizione il re di Francia avrebbe trovato la morte.
Da allora in poi gli Occidentali, stanchi di inutili e costose spedizioni, abbandonarono di comune tacita intesa i principi Franchi di Siria al loro destino; da parte loro, i sultani d’Egitto completarono in pochi decenni la riconquista del territorio siro-palestinese, e – un po’ per eliminare dei concorrenti ai porti egiziani, un po’ per dissuadere gli Europei da tentare ulteriori spedizioni – smantellarono sistematicamente gli empori costieri degli ex principati crociati, condannando l’intera area a una “vocazione alla povertà” destinata a durare per molti secoli. L’ultima piazzaforte crociata, Acri, cadde nel 1291 dopo una strenua, eroica difesa condotta dai Templari.
Ma, se la crociata in Terrasanta veniva posta da canto, i crociati coglievano altre vittorie e altre “glorie”, magari meno pie. La crociata riempiva di sé l’Occidente: ma non era più quella di Goffredo di Buglione. Nel corso del Duecento la Curia pontificia mobilitò i suoi canonisti e i professori delle nascenti università per elaborare un diritto della crociata che, canonisticamente appoggiato alla dottrina disciplinare dei voti solenni, si trasformò quello ch’era stato un generoso ideale in un formidabile strumento di pressione sia giuridico-politica sia fiscale. Per la crociata si raccoglievano elemosine e donazioni; ma, soprattutto, si raccoglievano speciali imposte, le “decime”.
I collettori pontifici delle decime, i banchieri che ne gestivano l’appalto o la raccolta, i frati mendicanti che incitavano a donare generosamente per la santa impresa estorcendo somme ai morenti oppure chiedendole in suffragio delle anime dei defunti, divennero un avido esercito deriso ma anche temuto – e odiato – nell’intera Europa.
Ma la disciplina dei voti, ne permetteva la pèrmuta e il riscatto: non solo il danaro raccolto per uno scopo si poteva – legittimamente sotto il profilo formale – utilizzare per uno scopo considerato equivalente o miglio lo stesso si poteva fare con i voti degli uomini. Una volta commessa, sotto i più vari impulsi (compreso l’entusiasmo suscitato da un predicatore famoso, la commozione e via dicendo) l’imprudenza di prendere la croce, si poteva uscirne – e se ne usciva di fatto – solo versando una certa somma di serviva o che sarebbe dovuta servire ad allestire il prossimo esercito della croce. Sotto il profilo delle indulgenze, partir crociato o armare un combattente crociato si equivalevano.
Ma si andava più oltre. La gestione sempre più diretta dalla gran “macchina crociata” da parte della Curia aveva fatto subire all’impresa e ai concetti che l’animavano un lento ma anche progressivo slittamento di scopi: da difesa della Terrasanta a difesa della Chiesa e della Cristianità in genere, e infine a servizio della Santa Sede contro i suoi nemici, religiosi prima, politici poi. Erano legittimamente crociati, al pari dei combattenti in Terrasanta, quelli di Spagna e del nord-est europeo: spettavano loro le medesime indulgenze, le medesime prerogative giuridiche e spirituali.
Ma vi fu di più. Fin dai primi del Duecento, si era risolto di stroncar con la forza l’eresia catara che aveva in Provenza il suo centro. Quella contro gli “Albigesi” fu, dal punto di vista formale, un’altra vera e propria crociata, i cui partecipanti poterono godere dei medesimi privilegi materiali e spirituali (esenzioni da certe tasse, sospensione dei procedimenti a loro carico e così via) previsti per chi andava a combattere i saraceni.
V’era, in fondo, una logica in questo: non erano forse gli eretici – come si andava proclamando – “peggiori dei saraceni”? Ma agli eretici si poteva finir con l’equiparare, usando adeguatamente lo strumento della scomunica, gli avversari politici del papato.
Ed ecco le vere e proprie crociate politiche, quelle ad esempio bandite nel Duecento e nel Trecento contro i vari signori ghibellini della penisola italica, alcuni soltanto dei quali potevano essere seriamente sospettabili di simpatie ereticali. La voce di Dante, che si scaglia violentemente contro la pratica della crociata bandita contro i cristiani, dà solo una lontana idea dell’orrore che essa dovette sollevare e che del resto si coglie in questa pagina tremenda d’un cronista peraltro insospettabile di simpatie ghibelline, Salimbene da Parma. Così lo scrittore francescano descrive la crociata predicata contro i da Romano che avevano per anni terrorizzato i guelfi del Veneto:
“(il cardinale Ottaviano degli Ubaldini) predicò la crociata contro il malefico Alberico (da Romano), e chiunque avesse preso la croce e fosse andato in guerra o avesse finanziato l’invio di qualcuno al posto suo avrebbe ricevuto l’indulgenza plenaria per tutti i suoi peccati. Per il potere di Dio Onnipotente e dei santi apostoli Pietro e Paolo, nonché per l’autorità di legato che egli stesso aveva ricevuto dalla Santa Sede, confermò solennemente a tutti concessione dell’indulgenza. Tutti presero quindi ardire e accettarono la croce dal piccolo al grande, dall’uomo alla donna. (…) Alberico mori di mala morte, con la moglie, i figli e le figlie. Coloro che li uccisero estrassero dalle carni dei suoi figlioletti ancora vivi le ossa e con queste percossero in faccia i loro genitori; poi legarono moglie e figlie di Alberico a dei pali e le bruciarono. E quest’ultime erano ancora vergini e bellissime fanciulle, e non avevano colpa alcuna: ma la loro innocenza e la loro bellezza non valsero a risparmiarle, dato l’odio che i loro genitori avevano accumulato (…)”.
Contro una tanto profonda degenerazione dello spirito crociato, è comprensibile che si levassero ben presto voci di protesta. Già i rovesci di tutte le crociate successive alla prima avevano provocato – in un modo tutto sommato convinto della giustizia immanente di Dio – dubbi, perplessità, dissensi. Deus vult (“Dio lo vuole”) era stato il grido di guerra dei vincitori del 1099: ma ora che le armi della croce venivano sistematicamente sconfitte dagli infedeli c’era da chiedersi che cosa Iddio volesse veramente. Lo stesso Bernardo di Clairvaux, nel trattato De consideratione, si era interrogato sui peccati dei cristiani che avevano potuto indurre il Signore a provarli così duramente.
Ma sulla sfiducia nei confronti della crociata contro gli infedeli si appoggiava appunto l’iniziativa sostitutiva della crociata contro i cristiani. Il grande “cardinale Ostiense”, vale a dire il canonista Enrico di Susa, chiuse in pieno Duecento la quesUone teorica affermando che, nella misura in cui gli infedeli si limitavano a minacciare la cristianità dal di fuori mentre gli eretici la distruggevano più gravemente dal di dentro, la crux cismarina era di gran lunga più santa e più meritoria della crux transmarina.
Non che fosse facile persuadere di ciò l’opinione pubblica. Perfino molti mistici levarono la loro voce contro la crociata sia contro quella rivolta a battere gli infedeli,sia contro quella rivolta a battere gli infedeli, che Iddio sembrava non favorire più, sia quella contro i cristiani, che par va ben più scandalosa. É strano e paradossale, tuttavia, che in una maniera o nell’altra, mistificata e poi laicizzata, la crux cismarina sia sopravvissuta al medioevo, insieme con l’idea che gli eretici (e, più tardi, i non cattolici, gli agnostici, i laicisti, gli atei) siano “peggiori dei saraceni”. Un atteggiamento di fondo del genere è rintracciabile durante le guerre di religione tra cattolici e ugonotti nella Francia cinquecentesca, poi nella propaganda vandeana e sanfedista contro i giacobini, poi addirittura nel linguaggio propagandistico (ma anche in quello ufficiale) dell’alzamiento nazionalista della Spagna fra 1936 e 1939.
Non che, intendiamoci, la crociata nel suo originario significato d’impresa contro gli infedeli d’Oriente perdesse mai del tutto il suo affascinante richiamo. Essa mutò, semmai, di contenuti e di metodologia. Nel corso del Duecento, specie grazie agli ordini francescano e domenicano, l’idea di crociata si accompagnò e si alternò – non sempre necessariamente opponendosi – a quella di missione. Non mancò, anzi, chi, come Raimondo Lullo, intese crociata e missione come due strumenti e due valori complementari, il primo rivolto a rivendicare alla Cristianità il legittimo possesso dei luoghi Santi, il secondo teso all’espansione pacifica della Cristianità attraverso la salvezza delle anime degli stessi infedeli.
Ora, è un fatto che la crociata non aveva mai avuto come scopo la conversione degli infedeli: comunque, nella concreta realtà storica, è indubbio che attraverso di essa cristiani e musulmani impararono a conoscersi e in parecchi casi anche a stimarsi.
È tuttavia ovvio che, se crociata e missione potevano concettualmente parlando convivere, in concreto tale convivenza era assai ardua: l’idea di missione costituisce, se non una negazione, quanto meno un superamento dell’idea di crociata, e non a caso alla cerniera fra quelle due dimensioni noi troviamo proprio l’azione di un crociato sui generis, Francesco d’Assisi, presente al campo di Damietta nel 1219-20 e pronto secondo la tradizione a sfidare a sua volta i musulmani, ma con la forza non già delle armi, bensì della fede, dell’amore, a persuasione.
E, poiché il dialogo – e magari la polemica – abbisognava di reciproca conoscenza, la missione aprì nuovi orizzonti intellettuali: il concilio di Vienna del 1311-12, organizzando su basi razionali la preparazione dei missionari, fondò i primi istituti orientalistici della storia della Cristianità. Fu la Spagna – che già nel XII secolo aveva fornito all’Europa l’equipe dei traduttori di Toledo – la patria di questo primo tentativo.
Gli eventi impedirono ad ogni modo che l’idea di crociata venisse del tutto posta da parte: semmai, nuovi mutamenti l’attendevano. Non a caso i secoli XIII e XIV, se videro la sua pratica liquidazione, assisterono però anche a una serie quasi spasmodica di tentativi di teorizzazione. Fra i due successivi concili, quello di Lione del 1274 e quello di Vienne del 1311-12, si sviluppò una vasta trattatistica tattico-strategica relativa ai progetti di rìconquista della Terrasanta: sono scritti noiosi, ma anche preziosi per la qualità d’informazioni storiche, geografiche, militari, tecnologiche ed economiche offerte. Questa letteratura non fece comunque che confermare che la discordia politica esistente nell’Europa del tempo e gli alti costi che sarebbero stati necessari a finanziare una nuova spedizione che avesse qualche probabilità di successo la rendevano, di fatto, inattuabile.
Il profilarsi d’una nuova minaccia orientale, quella dei Turchi Ottomani, causò verso la fine del Trecento un revival crociato destinato a durare almeno due secoli e a trascinarsi anzi fino al Settecento.
Era però una “crociata” difensiva; non era più questione di riconquistare il Santo Sepolcro, bensì d’impedire ai ‘turchi di dilagare per l’Europa e d’impadronirsi dell’intero bacino orientale del Mediterraneo. Inoltre, la Santa Sede non poteva ormai più gestire da sola la lotta contro gli infedeli: col Quattrocento e col Cinquecento, furono le “sante leghe” ad affermarsi, leghe di stati e quindi di sovrani delle quali i papi ottenevano al massimo la presidenza.
Comunque, i secoli fra medioevo ed età moderna risuonano tutti della tradizione crociata, sia pur trasformata in problema turco: dalla battaglia di Belgrado del 1456 che vide fra i suoi protagonisti Giovanni da Capestrano agli sforzi crociati di Pio II fra 1458 e 1464, dalla battaglia di Lepanto del 1571 (7 ottobre) fino all’estrema stagione crociata, quella dell’assedio turco di Vienna del 1683 e dell’epopea di Jan Sobiezki.
Ma la presenza degli infedeli non fu il solo elemento causante la permanenza comunque modificata degli ideali crociati. V’era un’altra tradizione crociata, in Occidente, una tradizione non-allineata, “popolare”, messianica: quella che traeva alimento dall’attesa del Millennio e dalla speranza di rigenerazione collettiva. Le profezie relative all’avvento dell’Anticristo e alla Seconda Venuta del Cristo l’alimentarono in una tensione forse continua, che tuttavia si espresse in sussulti successivi: i “fanciulli” del 1212, i “pastorelli” del 1251 e poi ancora dei primi del Trecento, i movimenti dei flagellanti che non si possono definire crociate popolari ma che con essi hanno molti punti di contatto.
È l’Europa del malessere, l’Europa della congiuntura e delle profezie, l’Europa delle speranze e delle paure che affiora a ricorrenti intervalli e che assume i simboli e il linguaggio crociato, quello forse più immediatamente a disposizione per esprimere un’antica sete di giustizia. Comunque, si trattasse di vincere gli infedeli o di por fine al falso cristianesimo dei potenti e degli ipocriti, il fine della crociata – il fine concettuale, intendiamo – non apparteneva mai del tutto ed esclusivamente alla storia. Esso, per sua natura, sconfina nella metastoria e nella metapolitica.
La crociata come guerra escatologica, come “ultima delle guerre”, come “guerra pacifica” finisce quindi con lo sconfinare nell’utopia. Giovanna d’Arco e Cristoforo Colombo, Hernan Cortes e Tommaso Campanella, Miguel Cervantes e Torquato Tasso culleranno, ciascuno a suo modo, un ideale religioso e guerriero come parte d’un più ampio sogno di rinnovamento e di rìgenerazione. Alle soglie dei nostri tempi, sarà significativamente nell’ambiente di un Saint-Simon che ancora una volta – l’ultima, forse – si parlerà a livello non pretestuoso di crociata, una crociata “laicizzata” eppure a modo suo ancora santa, una crociata di pace e di progresso, di libertà e d’amore. Senonché, il pratico esito di tanto fulgidi ideali sarà un capolavoro d’ingegneria al servizio dell’economia capitalistica e delle flotte delle potenze imperialiste: il canale di Suez.
Come si diventa crociati
Ma, esaurito il nostro forzatamente breve excursus storico, torniamo un istante ai tempi dei rigoglio delle spedizioni crociate o del permanere delle illusioni ad esse relative, diciamo al Due-Trecento, e domandiamoci: come – e perché – nella pratica, si diventa crociati?
La risposta a una domanda del genere richiede una precisazione. Nel medioevale l’Oriente è lontano, favoloso, misterioso: la Terrasanta, però, è vicina. I pellegrinaggi sono frequenti: a volerli fare con un qualche comfort possono essere cari, ma si possono anche fare con poco, da mendicanti o quasi. La gente conosce bene gli episodi fondamentali delle Scritture e soprattutto della vita di Gesù, per quanto non legga la Bibbia: c’è l’insegnamento orale della Chiesa e poi vi sono le sculture, i mosaici, gli affreschi, le vetrate, le pale d’altare; e poi ci sono le leggende dei santi e i volgarizzamenti e le epitomi della letteratura sacra.
I pellegrini riportano dalla Terrasanta delle reliquie e, soprattutto, dei racconti: qualcuno tiene addirittura un diario della sua esperienza, spesso la più bella, la più avventurosa, la più commovente della sua esistenza. Talvolta, nelle chiese d’Occidente, vi sono altari o edicole riproducenti la forma e le dimensioni del Santo Sepolcro, consuetudine questa che i francescani – verso la metà del Trecento incaricati, col benestare del sultano, della “custodia” dei luoghi Santi – incoraggeranno. A Roma, un vero tesoro di reliquie nel grande complesso laterano – prime fra tutte la “Veronica” e la “Scala Santa” – ricorda Gerusalemme e accende nel cuore dei pellegrini il desiderio di recarvisi.
E v’è, soprattutto, la propaganda dei predicatori, specie di quelli francescani e domenicani: dei “divi della penitenza”, come sono stati definiti. Essi sanno come esercitare la passione delle folle: le loro prediche per la crociata sono uno spettacolo, una sacra rappresentazione. E d’altra parte è ancora una volta la parola di altri predicatori, magari non sempre del tutto in regola con la disciplina ecclesiale, a scatenare le crociate popolari.
Ma non pensiamo a queste ultime. Volgiamoci alle crociate “ufficiali”, quelle bandite dai pontefici e provviste del consueto bagaglio di privilegi per i partenti. Alla fine della predica si formulano i voti, si distribuiscono solennemente le croci distintivo del pellegrinaggio. Le premesse di partenza vengono registrate con precisione:
“giurò di recarsi a visitare il Santo Sepolcro del Signore a Gerusalemme e (…) con giuramento devotamente promise di compiere nella dovuta maniera tale voto oltremarino, quando dalla Sacro-santa Chiesa Romana sarà stato ordinato il prossimo passaggio generale in Terrasanta.
A questo punto i generosi, gli emotivi, le teste calde, gli sbruffoni sono incastrati: se vorranno uscire dalla pania del voto senza infrangere la loro pace con la Chiesa ma anche senza rischiar la pelle, non potranno che versare una somma di danaro. In pratica, l’assunzione del voto diventa col tempo una sorta di promessa di contributo: per le spedizioni non c’è bisogno di pellegrini imbelli ed entusiasti, ma di professionisti (nel Trecento e nel Quattrocento si penserà perfino di assoldare delle Compagnie di Ventura per la crociata). Chi, per devozione o per farsi bello, o semplicemente per ritardare o per sospendere un procedimento giuridico ai suoi danni (per debiti, ad esempio), vuol ottenere un’indulgenza, prende la croce e poi la riscatta con una somma di danaro.
Ma prendiamo il caso che parta davvero. I crociati, dopo il XII secolo, corsero sempre meno il rischio di dover percorrere grandi distanze via terra. La strada anatolica fu abbandonata dopo la terza crociata: dal Duecento in poi, quando si parlava crociata si pensava a una spedizione via mare. Ma, dopo quel secolo, le crociate come fatto “popolare” tesero a scomparire o a esaurirsi nel continente. Restarono i pellegrinaggi, oltre il fermare i Turchi divenne sempre più una faccenda di principi o di ordini religioso-militari a loro volta divenuti potenze marinare: come i Cavalieri di San Giovanni, costretti dall’incalzare dell’offensiva musulmana a spostarsi a Rodi e a Malta.
Occasionalmente, come ai tempi di Pio II e poi ancora a quelli di Lepanto o degli assedi turchi di Vienna, l’entusiasmo crociato popolare parve riaccendersi: ma furono fuochi di paglia. L’interesse dell’Europa protomoderna era ormai volto altrove, soprattutto al Nuovo Mondo; quando tornò a guardare all’Asia, lo fece con occhi nuovi, gli occhi del colonialismo e del suo risvolto letterario, l’esotismo. La stessa questione turca, mutando un’altra volta aspetto, era diventata questione orientale. Gli ultimi nostalgici a modo loro della crociata, come abbiamo detto, furono i costruttori del canale di Suez.