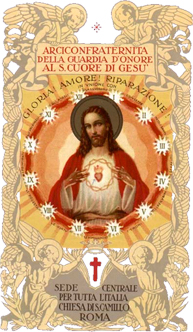A forza di interpretare la Scrittura a proprio estro, come ha insegnato il cardinale Carlo Maria Martini e prima di lui Lutero e prima ancora Valdo e prima di loro uno stuolo per nulla originale di eretici, troppi cattolici hanno finito per praticare al contrario il chiarissimo monito evangelico che invita a essere candidi come colombe e astuti come serpenti. Perché solo gente candida come serpenti e astuta come colombe può applicarsi al tentativo di sottrarre il cardinale Martini all’uso che il mondo ne sta facendo dopo la sua morte.
A forza di interpretare la Scrittura a proprio estro, come ha insegnato il cardinale Carlo Maria Martini e prima di lui Lutero e prima ancora Valdo e prima di loro uno stuolo per nulla originale di eretici, troppi cattolici hanno finito per praticare al contrario il chiarissimo monito evangelico che invita a essere candidi come colombe e astuti come serpenti. Perché solo gente candida come serpenti e astuta come colombe può applicarsi al tentativo di sottrarre il cardinale Martini all’uso che il mondo ne sta facendo dopo la sua morte.
Solo un’astuzia spuntata e un candore ingrigito possono condurre un cattolico a non rendersi conto che il mondo sta facendo dell’arcivescovo, in morte, l’uso che lui stesso aveva scelto in vita.
Non deve proprio stupire se il primo frutto pubblico post mortem dell’opera del cardinale è la notizia della proposta di legge sul fine vita elaborata da Furio Colombo e intitolata proprio “Legge Martini”. Un sorta di miracolo laico, verrebbe da dire, che “Il Fatto Quotidiano” del 12 settembre 2012 presenta così: “Il testo si compone di tre soli articoli. Primo: ogni cittadino ha il diritto di decidere liberamente di non ‘vivere’ in stato di coscienza la propria agonia e la propria morte.
Ha diritto perciò di chiedere di essere ‘sedato’ entrando nella fine irreversibile di ogni sofferenza e ogni angoscia, anche qualora l’uso di narcotici possa abbreviare la continuazione della vita dell’organismo. Secondo: la legge istituisce una ‘alleanza medico-paziente’ che stabilisce inequivocabilmente il diritto di ogni ammalato (irreversibilmente inguaribile) di scegliere il momento in cui ricevere una ‘sedazione’ definitiva che lo accompagni, in perfetta incoscienza senza ritorno, alla morte dell’organismo.
Tale diritto è esercitato da chi, per legame naturale o come indicato da una precedente dichiarazione esplicita, rappresenta la volontà dell’ammalato, nel caso di impossibilità diretta di comunicare da parte del paziente. Terzo: le strutture sanitarie pubbliche e private sono responsabili della sofferenza fisica, psicologica e morale conseguente alla non applicazione della presenta legge, a causa di carenze tecniche e o amministrative, e ne rispondono in sede civile e penale. Si parla dunque di palliazione nella proposta di Colombo che pone l’accento sulla volontà espressa da Martini ‘di dire ai medici che lo assistevano, di rinunciare a qualunque proseguimento delle tecniche di mantenimento in vita. Dunque l’espressione della richiesta, a cui i medici hanno aderito, di essere sedato in modo da poter morire senza terrore e senza dolore’”.
Come sempre, al dramma è seguita la farsa delle smentite, delle controsmentite, delle interpretazioni e delle contronterpretazioni. Ma è difficile sottrarre all’uso del mondo la morte del cardinale, oltre che la sua vita, dopo la lettera della nipote Giulia Facchini Martini, pubblicata sul “Corriere della Sera” del 4 settembre. Nel testo, si legge tra l’altro: “Avevi paura, non della morte in sé, ma dell’atto del morire, del trapasso e di tutto ciò che lo precede. Ne avevamo parlato insieme a marzo e io, che come avvocato mi occupo anche della protezione dei soggetti deboli, ti avevo invitato a esprimere in modo chiaro ed esplicito i tuoi desideri sulle cure che avresti voluto ricevere. E così è stato. Avevi paura, paura soprattutto di perdere il controllo del tuo corpo, di morire soffocato.
Se tu potessi usare oggi parole umane, credo ci diresti di parlare con il malato della sua morte, di condividere i suoi timori, di ascoltare i suoi desideri senza paura o ipocrisia. Con la consapevolezza condivisa che il momento si avvicinava, quando non ce l’hai fatta più, hai chiesto di essere addormentato. Così una dottoressa con due occhi chiari e limpidi, una esperta di cure che accompagnano alla morte, ti ha sedato”
Quand’anche, scorrendo queste righe, non ci si trovasse in quella zona grigia tanto evocata e vezzeggiata dal cardinale, non pare proprio questo l’atteggiamento che il gregge si attende dal pastore davanti alla morte. Qui ci si trova davanti a un sentire e a un pensare che turbano e rimandano inevitabilmente a quanto Martini confessava nelle Conversazioni notturne a Gerusalemme durante il colloquio con il confratello Georg Sporschill: “Le mie difficoltà hanno riguardato un grande interrogativo: non riuscivo a capire perché Dio lascia soffrire suo Figlio sulla croce. Perfino da vescovo, a volte, non riuscivo ad alzare lo sguardo verso il crocifisso, perché questa domanda mi tormentava. Me la prendevo con Dio… Soltanto in seguito un concetto teologico mi è stato di aiuto nel mio travaglio: senza la morte non saremmo in grado di dedicarci totalmente a Dio… Nella morte spero di riuscire a dire questo sì a Dio”.
Parlare del cardinale Martini, del suo pensiero e della sua opera dentro la Chiesa vorrebbe dire affrontare senza ipocrisie passi intessuti di tragedia come questo. Senza esimersi dal pregare generosamente per la sua anima, poiché nessuno, tranne Dio, sa dove si trovi e quale sia il suo destino. E, invece, per mesi e forse per anni, si dovranno sorbire lenzuolate di giornali, di libri, di siti, di radio, di tv cattoliche che spiegheranno come e qualmente il cardinale non ha detto ciò che ora il mondo gli fa dire e non ha fatto quello che il ora il mondo gli fa fare. Come se, a suo tempo, il cardinale si fosse mai degnato di ritrarsi, anche solo di un passo, dal ruolo di papa alternativo che il mondo laico, in solido con quello cattoprogressita, gli ha attribuito. Non lo ha mai fatto e, anzi, ha sempre contribuito ad alimentare tale vulgata con il pensiero e l’azione.
La questione del fine vita è solo l’ultimo degli esempi, eclatante come lo sono tutti gli altri. L’abolizione del celibato sacerdotale e il sacerdozio femminile, le aperture su convivenze, sugli omosessuali e la comunione ai divorziati risposati, la collegialità, il conciliarismo e la contestazione del primato petrino, l’esaltazione di figure come Lutero e il fiancheggiamento dei preti cosiddetti scomodi e quindi accolti in tutti i salotti che contano: sono tutte scelte meditate e praticate che hanno incontrato il plauso del mondo e ora non c’è più tempo per ritrattarle.
Eppure c’è chi spiega e spiegherà che il cardinale non voleva dire quello che ha detto e, anzi, metterà in guardia le avanguardie del mondo e del progressismo cattolico dal fare un uso indebito della sua eredità. Come dire, l’ermeneutica della continuità applicata al martinismo, una dottrina che, prima ancora che essere un contenuto, consiste in un metodo fondato sull’esercizio del dubbio e dell’ambiguità. Pane per qualsiasi ermeneuta deciso a trarne ciò che vuole, ma impossibile da digerire per chiunque legga il magistero martiniano alla luce dell’ortodossia.
Uno degli esiti più eclatanti di tale pensiero si è mostrato nella “Cattedra di non credenti”, un’intrapresa culturale che ha contribuito gagliardamente alla devastazione dottrinale della diocesi di Milano e poi, per contagio, del resto d’Italia e non solo. Nel 2002, in un discorso agli studenti del Pontificio Istituto Biblico, il cardinale la ricordava così: “(…) la ‘Cattedra dei non credenti’ (…) non è di per sé un’iniziativa biblica, ma nasce dalla Scrittura. ‘Dice l’empio: non c’è Dio’, dunque ascoltiamo l’empio. Cioè chiamiamo in cattedra i non credenti a spiegarci perché non credono. Poi non facciamo con loro un dibattito apologetico o una conferenza, cerchiamo di ascoltarci. Con la percezione che c’è in ciascuno di noi, almeno in me, una duplice personalità: un credente e un non credente che continuamente fa obiezioni, pone domande, problemi”.
Non può passare inosservata l’evidente autocertificazione di schizofrenia dottrinale e spirituale sottoscritta da Martini. Una vera e propria patologia pericolosa per qualunque fedele, ma addirittura sciagurata per un pastore che dovrebbe confermare nella fede il proprio gregge. Eppure è proprio questo il cuore dell’azione pastorale e dottrinale dell’arcivescovo di Milano, il quale usò più volte le stesse parole e gli stessi concetti per illustrarlo. Su “Il nostro tempo” del 17 ottobre 1993, esaltava il dubbio come “quell’esercizio dello spirito che in questi anni a Milano ha avuto il nome un po’ provocatorio di ‘Cattedra di non credenti’. (…) Ho organizzato questi incontri partendo dall’ipotesi che c’è in ciascuno di noi una parte credente e una non credente, o almeno resistente alla fede. (…) I due si parlano, si contrastano, si confrontano. Ciascuno di noi dà poi la prevalenza all’uno o all’altro dei due atteggiamenti, ma quello opposto gli rimane dentro. Il non credente sente una domanda di certezza, il credente viene vessato dalle ombre del dubbio”.
E’ evidentissimo che, secondo le stesse parole del cardinale, dal confronto, è proprio il credente, “vessato dalle ombre del dubbio”, a uscire malridotto dal confronto. Perché è proprio questo l’esito della dottrina e della pastorale martiniana: la destrutturazione della fede. Un esito disumano in cui non esistono più certezze e punti riferimento che ha come corrispettivo iconografico l’incomprensibile arte moderna.
Ma, fatti salvi i dubbi involontari che possono sorgere nell’intelletto riguardo alla verità proposta dalla fede, poiché questa rimane oscura alla ragione, chi crede non è un povero cieco che brancola inutilmente nel caos. Il credente ha il preciso dovere di rigettare il dubbio, poiché la fede non poggia sull’evidenza della ragione, ma sulla veracità di Dio. Nella Summa Teologica (II II, q.4, a. 8, ad 2), San Tommaso spiega che “A parità di condizioni vedere è più certo che ascoltare. Quando però colui dal quale si ascolta supera di molto la perfezione di chi vede, allora udire è più certo che vedere. Come un uomo di cultura modesta è più certo di ciò che ascolta da una persona dottissima che di ciò che a lui può apparire secondo la sua ragione. E un uomo è molto più certo di ciò che ascolta da Dio, il quale non può ingannarsi, che di quanto egli vede con la sua propria ragione ingannevole”.
Abbandonato questo criterio, il metodo della “Cattedra dei non credenti” ha infranto anche un altro chiarissimo ammonimento deposto dalla sapienza e dalla fede di San Tommaso nella Summa, il cui articolo 7 della questione 11 (II II) porta l’inequivocabile titolo “Se si debba disputare pubblicamente con gli infedeli”. La risposta del santo dottore inizia così: “Nelle dispute sulla fede si devono considerare due cose: una a proposito di chi affronta la disputa, l’altra a proposito degli ascoltatori. A proposito di chi disputa dobbiamo considerare l’intenzione. Se infatti uno disputasse perché dubita della fede, senza avere come presupposto la certezza della sua verità, ma volendola raggiungere con degli argomenti, peccherebbe indubbiamente, in quanto incredulo e dubbioso sulle cose di fede. Se invece disputa sulla fede per confutare, o per pio esercizio, fa una cosa lodevole”.
Come al solito, implacabile nella sua chiarezza e nella sua lucidità, Tommaso mostra che il contenuto e il metodo della “Cattedra dei non credenti” cadono sotto il caso di chi disputa “perché dubita della fede”. Con l’aggravante tutta moderna della volontà di rimanere nel dubbio.
Poi, l’articolo della Summa procede parlando del pubblico: “E a proposito degli ascoltatori si deve vedere se coloro che ascoltano la disputa sono istruiti e fermi nelle cose della fede, oppure sono delle persona semplici e titubanti. Infatti nel disputare sulle cose di fede dinanzi a persone istruite e ferme nel credere non c’è alcun pericolo. Se invece si tratta di gente semplice bisogna distinguere. Infatti questi ascoltatori o sono sollecitati e combattuti dagli infedeli, per esempio dagli Ebrei, dagli eretici o dai pagani che tentano di corromperne la fede, oppure sono tranquilli come avviene nelle regioni in cui non ci sono gli infedeli.
Nel primo caso è necessario disputare pubblicamente sulle cose di fede: purché vi siano delle persone capaci e preparate, che possano confutare gli errori. (…) Invece nel secondo caso è pericoloso disputare pubblicamente sulla fede dinanzi a persone semplici, la cui fede è più ferma per il fatto che non hanno mai ascoltato qualcosa di diverso da ciò che credono. Perciò non conviene che essi ascoltino i discorsi degli infedeli che discutono contro la fede”.
Anche su questo versante, pare chiarissimo come l’iniziativa del cardinale contravvenga all’insegnamento tomista e sia andata a turbare la fede di chi non avrebbe proprio avuto bisogno di essere “vessato dal dubbio”. Senza contare che non uno degli interlocutori non credenti portati in cattedra da Martini abbia dato mostra di aprirsi alla fede cattolica. Non uno dei grandi intellettuali agnostici, atei, eretici o di altre religioni che lo hanno osannato in vita e in morte l’hanno trovato così attraente da arrendersi a Cristo.
Del resto, il cardinale non lo chiedeva. Impugnando il dubbio come un pastorale, ha sempre preferito viaggiare sul filo dell’ambiguità pensando bene di sospingere le pecore oltre gli steccati dell’ovile e soprattutto, di mantenervi fuori quelle che già erano uscite. A volte in manifesto contrasto con la dottrina cattolica, altre mantenendosi un passo indietro e alimentando l’eresia altrui, basta che circolasse.
Tra i casi recenti più celebri, va ricordato quello del libro di Vito Mancuso, L’anima e il suo destino. Un’operina che demolisce il concetto di peccato originale, la resurrezione di Gesù, il ritorno del Salvatore nella gloria, l’eternità dell’inferno, Dio come fonte della salvezza, le Sacre Scritture come parola di Dio, l’intervento divino nella storia e definisce il purgatorio una “salutare invenzione”. Là dove le tesi di Mancuso non coincidono con quanto detto da Nostro Signore e da San Paolo è presto fatto: sono Nostro Signore e San Paolo a sbagliarsi. Quanto alla morale sessuale, il professore ha sistemato tutto mettendo sotto il compressore la dottrina della Humanae Vitae sulla contraccezione: “Occorre guardare in faccia la realtà per quello che è, non per quello che si vorrebbe che fosse, e la realtà è che i rapporti sessuali sono praticati largamente al di fuori del matrimonio e a partire da giovanissima età”.
Su “Civiltà cattolica”, padre Corrado Marucci, dopo aver stroncato il libello mancusiano, ha concluso: “Se per teologia si intende la riflessione dell’intelletto umano illuminato dalla fede sulla Sacra Scrittura e sulle definizioni della Chiesa, allora il nostro giudizio complessivo su questa opera non può che essere negativo. L’assenza quasi totale di una teologia biblica e della recente letteratura teologica non italiana, oltre all’assunzione più o meno esplicita di numerose premesse filosoficamente erronee o perlomeno fantasiose, conduce l’Autore a negare o perlomeno svuotare di significato circa una dozzina di dogmi della Chiesa cattolica. A fronte di una relativa povertà di dati autenticamente teologici, la tecnica di accumulare citazioni da tutto lo scibile umano, oltre al rischio di distorcerne il senso reale ai propri fini poiché esse fanno parte di assetti logici a volte del tutto diversi, non corrisponde affatto alla metodologia teologica tradizionale”.
Eppure, nella prefazione, l’ex arcivescovo di Milano raccomanda vivamente il libro, anche se vi ravvisa concetti “che non sempre collimano con l’insegnamento tradizionale e talvolta con quello ufficiale della Chiesa”. Un colpo di genio, con quell’apparente innocente “non sempre”, il cardinale ha trovato il pertugio per il genere di operazione in cui è sempre stato maestro: smarcarsi da un’eventuale ricognizione della Congregazione per la Dottrina della fede e, nel contempo, aprire grazie ad altri un’autostrada diretta verso l’eterodossia conclamata. Come al solito, grazie al dubbio. “Sarà difficile parlare di questi argomenti senza tenere conto di quanto tu hai detto con penetrazione coraggiosa” dice il cardinale al vecchio pupillo. “Anche quelli che ritengono di avere punti di riferimento saldissimi possono leggere le tue pagine con frutto, perché almeno saranno indotti o a mettere in discussione le loro certezze o saranno portati ad approfondirle, a chiarirle, a confermarle”.
In questo modo, nel corso dei decenni, Martini ha prodotto un instancabile lavorìo che ne ha fatto l’icona delle icone del progressismo cattolico, il cardinalissimo che a Milano ha impietosamente oscurato il cardinale successore e il successore del successore per chissà quanti mandati. Ne ha fatto il Grande Antagonista che ha sempre colto l’occasione giusta per esercitare il suo magistero alternativo: vuoi l’intervista, vuoi l’opera di esegesi, vuoi la raccolta di riflessioni, vuoi il dialogo con un spalla che le spari grosse e gli permetta di andare oltre fingendo di ritrarsi.
Sono esemplari, da questo punto di vista, le 96 paginette di Siamo tutti sulla stessa barca, firmate con don Luigi Verzé e piene della solita roba: la morale sessuale della Chiesa da buttare, i divorziati risposati da ammettere alla comunione, il celibato dei sacerdoti da mandare a ramengo, l’ottusità dell’etica cattolica da scrollarsi di dosso, e poi la sinodalità, l’apertura al mondo, il popolo di Dio che elegge direttamente i vescovi come se fossero dei borgomastri. Tutto spruzzato di snobistico orrore per “le fiumane di gente” che “quando arriva il Papa, hanno più o meno il valore delle carnevalate”.
Il fremito clerical-chic del dialogo con l’antico nemico don Verzé è giusto una carezza consegnata dal cardinale ai suoi seguaci, un discorso della Luna per chi avrebbe voluto vederlo Papa al posto di Benedetto XVI.
Il cardinale, con uno sparring partner come il fondatore del San Raffaele, ha buon gioco a mostrare con studiata ritrosia il suo disegno di una nuova Chiesa. A un don Verzé sicuro che quando Cristo tornerà sulla terra troverà ancora la fede perché ci sarà ancora il San Raffaele, risponde evocando le zone grigie dell’etica su cui ama tanto avventurarsi senza portare un solo contributo per discernere il bianco dal nero. A un don Verzé che parla di morale cristiana incongruente col mondo confida con rammarico che, in effetti, “oggi ci sono non poche prescrizioni e norme che non sempre vengono capite dal semplice fedele”. A un don Verzé ossessionato da una Chiesa che non rincorre abbastanza velocemente la scienza consegna i suoi “non so”, “non voglio giudicare” vuoti di dottrina e di speranza.
Il cardinale sta un’ottava sotto il prete manager, ma tra le righe il colpo d’ala c’è: per rimettere un po’ d’ordine in questa barca, caro il mio don Verzé, “non basta un semplice sacerdote o un vescovo. Bisogna che tutta la Chiesa si metta a riflettere su questi casi”.
Per farla corta, urge un Concilio Vaticano III. Chi altri, se non il Cardinale Antagonista, avrebbe potuto evocarlo senza cadere nel ridicolo? Anzi, potendo vantare di averlo addirittura sognato fin dal Sinodo per l’Europa del 1999. Ma per arrivarci, non basta enunciare una nuova dottrina, serve un metodo per farla passare nell’opinione pubblica. E il metodo consta nella ripetuta pubblicazione di opere e operine, di cui quella con don Verzé è solo un esemplare fra i tanti.
Nella strategia martiniana, opere e operine progressivo-moderniste sono stati altrettanti schemi preparatori sul genere di quelli, che fino al Vaticano II compreso, redigeva la curia romana e su cui i Padri conciliari erano tenuti a discutere. Il fatto che, nel corso di questi decenni, siano stati diffusi a mezzo stampa invece che consegnati ai vescovi tramite Corriere della sera dipende dalla natura del Vaticano III: quella di Concilio mediatico, celebrato quotidianamente sui giornali, in tv, sul web, dove il dialogo paritario tra Chiesa e mondo trova la sua luciferina manifestazione in una Chiesa che si prostra davanti mondo.
Virtualmente in corso da tempo, al Vaticano III mancava una formale cerimonia d’apertura, che ora ha una sua collocazione storica precisa nella morte del cardinale Martini e nella istantanea canonizzazione celebrata all’unisono dal mondo laico, dal mondo ecclesiale progressista e dalla gerarchia a ogni livello. Salvo lodevoli voci isolate che non sono neanche state udite, si è assistito alla edificazione di un vero e proprio mito che ha ridato forza a un neomodernismo saldamente al potere ma in deficit di idee e di prospettive.
L’esito inevitabile dell’inedita unanimità degli elogi al capo riconosciuto della chiesa antagonista ha formalmente aperto il Vaticano III rendendo grottescamente inutili gli sforzi di trovare la migliore ermeneutica del Vaticano II. Sarebbe bastato, non si dice una critica aperta o una chiara presa di distanza, ma almeno un silenzio per incrinare il mito nascente e renderlo inoperante. Invece no. Persino il messaggio firmato da papa Benedetto XVI parlava di “Pastore generoso e fedele della Chiesa”, “uomo di Dio, che non solo ha studiato la Sacra Scrittura, ma l’ha amata intensamente, ne ha fatto la luce della sua vita, perché tutto fosse ‘ad maiorem Dei gloriam’, per la maggior gloria di Dio”. E poi ancora pastore “capace di insegnare ai credenti e a coloro che sono alla ricerca della verità che l’unica Parola degna di essere ascoltata, accolta e seguita è quella di Dio, perché indica a tutti il cammino della verità e dell’amore”.
Oppure, si potrebbe citare l’intera omelia del cardinale Scola, attuale arcivescovo di Milano che, secondo la vulgata diffusa al suo arrivo, avrebbe dovuto demartinizzare la diocesi ambrosiana per conto di Benedetto XVI. O il mandato non è mai stato conferito, o è evaporato trasformandosi addirittura nel suo contrario: “Carissimi, siamo qui convocati dalla figura imponente di questo uomo di Chiesa, per esprimergli la nostra commossa gratitudine. In questi giorni una lunga fila di credenti e non credenti si è resa a lui presente. Caro Padre, noi ora, con i molti che ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione, ti facciamo corona. (…) Non siamo qui per il tuo passato, ma per il tuo presente e per il nostro futuro. (…) Il Cardinal Martini non ci ha lasciato un testamento spirituale, nel senso esplicito della parola. La sua eredità è tutta nella sua vita e nel suo magistero e noi dovremo continuare ad attingervi a lungo”.
Da qui in giù, si è assistito a una valanga di elogi della figura, del pensiero e del magistero martiniano che ha attraversato gli episcopati, le diocesi e i consigli pastorali. E ha investito persino quei movimenti che per decenni hanno fatto la guerra alla curia milanese e ora sostengono che guerra non vi fu, forse qualche malinteso e, se malinteso vi è stato, non fu certo per colpa del cardinale. Neanche a papa Giovanni Paolo II è stato tributato un osanna così unanime.
Potenza della mitologia massmediatica, che ammette voci difformi solo se scorrono a lato, fuori quadro, là dove pur risuonando non esistono, nel luogo dove non vengono udite perché non hanno dignità per essere decifrate, nell’unico inferno concepito dalla modernità e da quel cattolicesimo che le si è fatto connaturale: la segregazione dal mondo.
E adesso si assiste al povero spettacolo di coloro che, dopo aver anche solo vagamente intuito quali sono i disegni del mondo e in qual modo il mondo intende ghermire coloro che gli si danno in pasto, tentano di spiegare che il cardinale non voleva dire quel che gli fanno dire, non voleva pensare quel che gli fanno pensare, non voleva fare quel che gli fanno fare. Ma inutilmente, perché se esiste una cifra che ha caratterizzato il pensiero e l’operato di Martini sta proprio nel non essersi mai sottratto all’abbraccio con il mondo. Il quale, dopo aver tributato gli onori, passa sempre all’incasso degli oneri.
Adesso, c’è chi si stupisce che si osi presentare una proposta di legge palesemente laica sul fine vita intestandola al cardinale. Ma è proprio questo il modo di operare del mondo: creare miti per il proprio uso e consumo ai quali è impossibile opporre una resistenza razionale in quanto operano su livelli diversi, nei cieli in cui la logica e la cronaca non hanno cittadinanza.
E quale logica e quale cronaca, oltretutto, si tenta di opporre all’uso che il mondo fa del cardinale e della sua memoria. Un timido balbettare che, dopo aver gettato a mare il principio di non contraddizione e l’ossequio all’ortodossia, può solo venire travolto dalla dialettica infernale messa in campo dalla modernità. Una povera ricostruzione di fatti costruita sugli omissis e su improbabili ermeneutiche, in cui si tenta surrealmente di mostrare come il cardinale fosse altro. Uno “che lo conosceva bene” è arrivato fino a sostenere che le deviazioni di Martini non sono frutto di una cattiva teologia, ma di una cattiva sociologia.
Davvero poca cosa che, ancora una volta, mostra come sia tragicamente vero il detto evangelico secondo cui i figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce. Appena morto il cardinale, mentre in casa cattolica se ne organizzava la canonizzazione voluta dal mondo accompagnandola a un’inerme vulgata ortodossa, in televisione, Gad Lerner, parlando di musica e di eterodossia, spiegava che “l’interpretazione eretica degli spartiti di Bach sarebbe piaciuta tanto a Martini”. Una semplice battuta messa lì a fare da testo implicito in un discorso tessuto a elogio dell’eresia privo di vero contraddittorio. Questo, purtroppo, è sapiente uso dei mezzi di comunicazione e della mitologia di cui si alimentano. Con una sola frase, detta nel luogo e nel momento giusto, si seppellisce qualsiasi pensiero alternativo.
Per vanificare l’erezione del mito martinista sarebbe stato necessario un gesto difforme da parte della gerarchia, la carità nei confronti di ogni peccatore associata all’affermazione della verità là dove venga violata. Ma non si è visto. Al mondo è stato offerto lo spettacolo mediatico di una Chiesa associata al mondo nella canonizzazione del principe degli antagonisti: proprio l’unica operazione che il mondo, da solo, non avrebbe potuto fare.
Fonte: Corrispondenza Romana