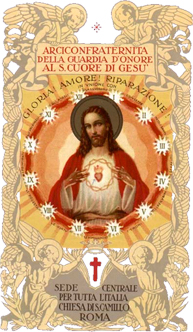Il 12 ottobre scorso la Regione Sardegna ha approvato la nuova legge sulla semplificazione amministrativa al cui interno è presente un emendamento, voluto da Annamaria Busia del Centro democratico, il quale prevede che alcuni sostantivi maschili riferiti ad incarichi istituzionali, se attribuiti a donne, debbano essere declinati al femminile. E così avremo sindaca, assessora, prefetta, questora (senza apostrofo in mezzo) o questrice, ma non questuante. Lo stupro alla femminilissima lingua italiana è ormai perpetrato sull’isola.
Il 12 ottobre scorso la Regione Sardegna ha approvato la nuova legge sulla semplificazione amministrativa al cui interno è presente un emendamento, voluto da Annamaria Busia del Centro democratico, il quale prevede che alcuni sostantivi maschili riferiti ad incarichi istituzionali, se attribuiti a donne, debbano essere declinati al femminile. E così avremo sindaca, assessora, prefetta, questora (senza apostrofo in mezzo) o questrice, ma non questuante. Lo stupro alla femminilissima lingua italiana è ormai perpetrato sull’isola.
Nonostante ciò, felicitazioni vivissime sono arrivate alla giunta regionale anche da personaggi illustri, quali la presidente (o presidentessa?) della Camera Laura Boldrini e la professoressa Cecilia Robustelli dell’Accademia della Crusca.
Entro sei mesi la Regione dovrà emanare alcune linee guida affinchè le amministrazioni locali adottino “un linguaggio non discriminante rispettoso dell’identità di genere, mediante l’identificazione sia del soggetto femminile che del soggetto maschile negli atti amministrativi, nella corrispondenza e nella denominazione di incarichi, funzioni politiche e amministrative”. Tutto questo al fine di “promuovere una nuova coscienza linguistica”.
La Busia tiene poi a precisare che “identificare la professione o il ruolo di una donna utilizzando il termine al maschile è un mancato riconoscimento, una forma sottile di discriminazione”.
Quindi chiamare “sindaco” una donna a capo di un comune è discriminatorio, sessista, misogeno, nonchè segno di machismo incipiente. Sindaca, assessora, prefetta e questrice è da asini, ma asini rispettosi delle donne.
In primis è da appuntare che questo emendamento inserito in una legge per la semplificazione amministrativa non semplifica un bel niente. Anzi complica non poco il lavoro degli impiegati amministrativi che spenderanno anni per adeguarsi alle bizzarrie di chi sta in alto e per questo vuole rimanere ben visibile (ed anche risibile).
Tra l’altro nessuno si era lamentato della mascolinizzazione di alcune cariche amministrative perché corrispondenti ad un maggior numero di sindaci, prefetti, etc. uomini sul suolo patrio rispetto a sindaci, prefetti, etc. donne. Questione statistica.
E poi c’è chi – ricorrendo ad un’immagine ecclesiale – criticava la Chiesa perché discuteva del sesso degli angeli (falso storico: mai la Chiesa discusse su questo). Ora si discute del sesso delle parole. Uno dei tanti mezzucci per portare avanti le teoria del gender.
Ma torniamo agli impiegati sardi in lotta con le vocali. Qui la vera discriminazione è alla stessa lingua italiana, davvero vituperata.
E’ di dominio pubblico infatti una verità linguistica inoppugnabile: è l’uso che determina la correttezza o meno di certe regole grammaticali, tra cui la declinazione al genere maschile e femminile, non certo le leggi regionali. Ecco perché è corretto e doveroso distinguere tra “maestro” e “maestra” e non è corretto ed è vietato usare “sindaca”. Suona male perché sbagliato. Tutto qui.
Il virus in rosa contaminerà anche altri ambiti del sapere. L’occhio sarà “occhia”, se il/la bulbo/a oculare apparterrà ad una donna. Il vestito diventerà “la vestita” se ad indossarlo sarà un essere pettoruto.
Il “seno” è già grammaticalmente errato per sua natura. Il rossetto in questo senso ha ormai il suo destino linguistico segnato, transessuali permettendo.
Ma esistono anche lemmi che sono la gioia sia delle femministe che dei loro cugini più giovani, i sigg. LGBT, perché sessualmente ambigui, quasi neutri, genere ripudiato dal nostro italiano.
Pensiamo alla “mano”, femminile nell’articolo e così virile in quel sostantivo adornato dalla vocale più mascolina che esista.
E parimenti poniamo mente alla parola “eco”, sebbene al plurale diventi trans e dimostri sessista intolleranza verso le donne. “Che passi prima sotto l’arcobaleno?”, si domandava in modo significativo nel 1878 l’esperto di grammatica Giovanni Moise. Esistono quindi termini che segnano una pacificazione nella guerra dei generi combattuta sul campo lessicale.
Di converso, e nel rispetto del principio di reciprocità, vorremmo promuovere un movimento di liberazione delle parole dal genere femminile vincolato, dal monopolio in gonnella, una eliminazione semantica del copyright in rosa di quei termini che ad oggi si declinano solo al femminile.
E così rivolgendoci alla Regione Sardegna chiediamo l’uso bipolare del binomio “isola-isolo” e del sostantivo “la città/il cittò” di Cagliari e alla Boldrini domandiamo la facoltà di chiamarla presidentessa del Camero (pare un insulto, ma non è così, cari amici trogloditi).
Da ultimo bisognerebbe poi mettere mano a tutta la prosa sessista di cui sono piene le nostre biblioteche.
Ad esempio i Promessi sposi dovrà diventare – anche in ossequio alla Cirinnà – le Promesse spose. E tutto lo scritto manzoniano dovrà subire un secondo e aggiornato risciacquo dei panni in quell’Arno avvelenato dai rifiuti ideologici-linguistici.
Così avremo, splendente nei suoi nuovi colori femminei, un restaurato abbrivio del capolavoro ottocentesco: “Quella appendice dell’acqua lacustre di Como, che volge a mezza giornata, tra due catene non interrotte di alture, tutta a tette e a insenature, a seconda delle sporgenze e delle rientranze di quelle, vien, quasi di fretta, a ristringersi, e a prender corsa e figura di acqua che corre, tra una collina a destra, e un’ampia costiera dall’altra parte”.
Non suona male. E’ solo più (politicamente) corretto.
Fonte: La NBQ