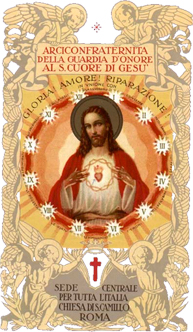ROMA, 9 gennaio 2016 – Hanno fatto notizia, a fine anno, i dati forniti dalla prefettura della casa pontificia sulle presenze nel 2015 alle udienze pubbliche con papa Francesco, con numeri quasi dimezzati rispetto all’anno precedente: Alle udienze generali del mercoledì si è scesi dalle 1.199.000 presenze del 2014 alle 704.100 del 2015. Mentre per gli Angelus domenicali il calo è stato da 3.040.000 a 1.585.000.
ROMA, 9 gennaio 2016 – Hanno fatto notizia, a fine anno, i dati forniti dalla prefettura della casa pontificia sulle presenze nel 2015 alle udienze pubbliche con papa Francesco, con numeri quasi dimezzati rispetto all’anno precedente: Alle udienze generali del mercoledì si è scesi dalle 1.199.000 presenze del 2014 alle 704.100 del 2015. Mentre per gli Angelus domenicali il calo è stato da 3.040.000 a 1.585.000.
Ciò non toglie che la popolarità di papa Francesco resti straripante. I suoi indici di popolarità non sono però in grado di dire quale grado di effettiva pratica religiosa vi corrisponda.
Molto più indicative sono, a questo proposito, altre rilevazioni. Ad esempio quelle ufficiali che l’ISTAT compie ogni anno in Italia sulla vita quotidiana di un gigantesco campione di cittadini, fatto di circa 24 mila famiglie, per un totale di circa 54 mila individui, residenti in 850 città grandi e piccole.
Nell’ultima rilevazione annuale resa nota, relativa al 2014, la “percentuale di persone di oltre 6 anni che si recano in un luogo di culto almeno una volta alla settimana” è risultata essere del 28,8 per cento.
Il fatto che più di un quarto degli italiani entri in chiesa almeno una volta alla settimana può essere giudicato notevole, in sé e in rapporto ad altri paesi. Ma se si confronta questo dato con le rilevazioni degli anni precedenti, anche qui si registra un calo netto.
Durante i sette anni del pontificato di Benedetto XVI questo stesso indicatore è stato in Italia costantemente superiore al 30 per cento, e mediamente attorno al 32-33 per cento. Decisamente più alto che nel 2014, il primo anno pieno del pontificato di Francesco, quello in cui la sua popolarità ha toccato il picco.
La lettera che segue tiene conto di questi indicatori statistici. Ma valuta il reale “effetto Francesco” sulla vita religiosa con lo sguardo più ravvicinato e diretto del pastore d’anime, del confessore. Il quale scrive d’aver sperimentato durante questo pontificato non solo un ulteriore calo dell’accesso alla confessione sacramentale, ma anche uno scadimento della “qualità” delle confessioni stesse.
Uno scadimento a cui non appare estraneo un utilizzo di certi detti di papa Jorge Mario Bergoglio che hanno avuto un enorme successo mediatico.
L’autore della lettera è un ecclesiastico con specializzazione scientifica di alto livello e con rilevanti incarichi d’insegnamento in Italia e all’estero, ma che dedica anche molto tempo ed energia alla cura pastorale.
Le sue valutazioni riflettono quelle di un numero crescente di parroci, che – in via riservata – non mancano di confidare analoghe preoccupazioni ai rispettivi vescovi.
E anche “www.chiesa” assicura riservatezza all’autore della lettera, troppo esposto alle prevedibili ritorsioni di un “new establishment” ecclesiastico – come lui lo chiama – che ha nell’ossequio conformistico a questo pontificato uno dei suoi vizi più deleteri.
Una riservatezza che consente quella “parresia” o franchezza di parola tanto incoraggiata dallo stesso papa Francesco, che anche durante un sinodo vuole sia noto “che cosa” si dice in aula, ma non “chi” lo dice.
__________
“Chi è lei per giudicarmi?”. Le confessioni di un confessore
Caro Magister,
sull’impatto del pontificato di papa Francesco “ad intra” e “ad extra Ecclesiae”, per quanto concerne il rinnovamento della vita spirituale dei fedeli e della loro partecipazione comunitaria a quella della Chiesa, così come l’auspicato ritorno alla pratica evangelica e sacramentale di quanti se ne erano allontanati negli scorsi decenni, non poco è già stato scritto.
E da diverse prospettive: teologiche, antropologiche, storiche, sociologiche, culturali, comunicative e politiche. Null’altro ritengo si debba aggiungere in proposito, anche perché molti di questi dati e di queste considerazioni devono ancora essere digeriti attraverso una riflessione critica e pacata.
Resta comunque aperta – e in parte impregiudicata – l’individuazione di un robusto indicatore spirituale e pastorale per misurare l’effetto di un cambiamento di personalità, di disciplina o di insegnamento sulle anime e sul popolo di Dio.
Ne sono consapevole. Quelle di “anime” e di “popolo di Dio” sono due categorie teologiche ed ecclesiali oggi in disarmo, in particolare negli interventi dell’attuale pontefice e del suo “new establishment”. Ma fanno pur parte, fino a evidenza contraria, della fede cattolica confermata dallo stesso Concilio Vaticano II.
E la loro negligenza porta con sé il rischio, tutt’altro che peregrino, di scambiare la “salus animarum” con i “vota aliquorum” e il “bonum populi Dei” con il “popularis consensus”. Traduco: la salute delle anime con i desiderata di alcuni e il bene del popolo di Dio con la popolarità.
Lascio ai cultori di sociologia della religione, di comunicazione pubblica della fede e di politica ecclesiastica ogni considerazione sulla partecipazione di massa dei fedeli e dei non credenti agli eventi pubblici in cui è presente il Santo Padre (udienze generali, Angelus, celebrazioni liturgiche, etc.) – i cui dati statistici ufficiali forniti dalla prefettura della casa pontificia mostrano una marcata flessione dal primo al terzo anno del pontificato di papa Francesco – e sul significato eventuale che questi numeri presentano in ordine alla conversione al Vangelo e all’adesione al messaggio “urbi et orbi” del pontefice per una “nuova primavera” della Chiesa, caratterizzata dalle “porte” spalancate con facilità verso tutti (se non ricordo male, il Vangelo di Luca però parla di una “porta stretta” per attraversare la quale occorre “sforzarsi”, fare fatica, e di “molti che cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno”).
Desidero invece comunicare semplicemente l’esperienza – i fatti così come si danno nella quotidianità del lavoro pastorale di periferia, cosicché “contra factum non valet illatio” – di un prete che dedica il tempo e le energie che gli restano, dopo aver adempiuto al ministero che il vescovo gli ha principalmente affidato, all’opera della riconciliazione sacramentale, convinto che la misericordia di Dio passi anzitutto, in via ordinaria e sempre accessibile, attraverso la discrezione della buia grata e della stretta finestra del confessionale e non percorrendo, alla luce dei fari delle basiliche e sotto gli occhi di tutti, le grandi porte dell’Anno Santo (il cui merito è un altro: quello di far ottenere la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i propri peccati qualora già rimessi, quanto alla colpa, nel sacramento della confessione, che resta il primo e fondamentale veicolo della misericordia di Dio verso di noi peccatori, dopo il battesimo).
I fatti sono questi. Dall’apertura dell’Anno Santo voluto da papa Francesco e in occasione delle festività natalizie del 2015 – così come da quando Jorge Mario Bergoglio siede sulla cattedra di Pietro – il numero dei fedeli che si è accostato al confessionale non è aumentato, né nei tempi ordinari, né in quelli festivi.
Il trend di una progressiva, rapida diminuzione della frequenza della riconciliazione sacramentale che ha caratterizzato gli ultimi decenni non si è arrestato. Anzi: mai come in prossimità di questo Natale i confessionali della mia chiesa sono stati ampiamente disertati.
Ho cercato conforto per questa amara considerazione immaginando che le basiliche legate all’Anno Santo a Roma o in altre città, oppure i santuari e i conventi, abbiano potuto attrarre un numero maggiore di penitenti.
Ma un giro di telefonate ad alcuni confratelli che ascoltano abitualmente le confessioni in questi luoghi (cogliendo l’occasione di un augurio, come faccio ogni anno) ha confermato la mia constatazione: file di penitenti tutt’altro che lunghe, ovunque, meno ancora che nelle festività degli anni passati.
E vi è sempre meno notizia anche di conversioni memorabili di pecorelle smarrite da tanti anni, che ritornano all’ovile del Buon Pastore attraverso i “servi inutili” della sua misericordia che siamo noi preti. Quando, molto raramente, questo accade, non vi è esplicito né implicito riferimento alla persona o alla parola del papa attuale più di quanto ve ne sia stato in passato per i suoi predecessori (quanti giovani tornavano dalle Giornate mondiali attuando il proposito di confessarsi regolarmente!).
Diffidando del valore dei numeri, perché anche la salvezza di una sola anima ha un valore infinito agli occhi di Dio, ho ripercorso la “qualità” delle confessioni da me ascoltate e ho chiesto – nel rispetto del segreto confessionale circa l’identità del penitente – notizie ad alcuni confratelli penitenzieri di lunga esperienza.
Il quadro che si presenta non è certo felice, sia per quanto concerne la coscienza del proprio peccato, sia in riferimento alla consapevolezza dei requisiti per accedere al perdono di Dio (anche in questo caso, so che il termine “perdono” sta cedendo il passo a “misericordia” e rischia di andare presto in soffitta, ma a quale costo teologico, spirituale e pastorale?).
Due esempi valgano per tutti.
Un signore di mezza età, al quale ho chiesto, con discrezione e delicatezza, se era pentito di una ripetuta serie di peccati gravi contro il settimo comandamento “non rubare”, dei quali si era accusato con una certa leggerezza e quasi scherzando sulle circostanze non certo attenuanti che li avevano accompagnati, mi ha risposto riprendendo una frase di papa Francesco: “La misericordia non conosce limiti” e mostrandosi sorpreso che ricordassi a lui la necessità del pentimento e del proposito di evitare in futuro di ricadere nello stesso peccato: “Quel che ho fatto ho fatto. Quel che farò lo deciderò quando uscirò da qui. Come la penso su ciò che ho compiuto è questione tra me e Dio. Sono qui solo per avere quello che spetta a tutti almeno a Natale: poter fare la comunione a mezzanotte!”
E ha concluso parafrasando l’ormai celeberrima espressione di papa Francesco: “Chi è lei per giudicarmi?”.
Una giovane signora, alla quale avevo proposto come gesto penitenziale, legato all’assoluzione sacramentale di un grave peccato contro il quinto comandamento “non uccidere”, la preghiera in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento esposto sull’altare della chiesa e un atto di carità materiale verso un povero nella misura delle sue possibilità, mi ha risposto seccata che il papa aveva detto pochi giorni prima che “nessuno deve chiederci nulla in cambio della misericordia di Dio, perché è gratis”, e che non aveva né tempo per fermarsi in chiesa a pregare (doveva “correre a fare gli acquisti natalizi in centro città”), né soldi da dare ai poveri (“che tanto non ne hanno bisogno perché ne hanno più di noi”).
È evidente che qualche messaggio, almeno così come ricevuto dal papa e giunto ai credenti, si presta facilmente ad essere frainteso, equivocato, e dunque non aiuta la maturazione di una coscienza certa e retta nei fedeli circa il proprio peccato e le condizioni della sua remissione nel sacramento della riconciliazione.
Con buona pace di mons. Dario Viganò, prefetto della segreteria per la comunicazione della Santa Sede, l’”incedere zigzagante” tra i concetti senza mai soffermarsi a precisarne uno – che egli riconosce come pregio dello “stile comunicativo di papa Francesco”, capace di “renderlo così irresistibile” all’ascoltatore moderno – presenta qualche inconveniente spirituale e pastorale, di non poco conto se ha a che vedere con la grazia e i sacramenti, il tesoro della Chiesa.
Mi fermo qui, per non abusare della sua pazienza nel leggermi. Non ho la pretesa di proporre come termometro della fede e della vita ecclesiale la quantità o la qualità delle confessioni e, più in generale, della frequenza ai sacramenti, né di fare di essi un parametro esclusivo per la valutazione di un pontificato o dello stato di salute della Chiesa. Non sarebbe equo e farebbe perdere di vista altre dimensioni della vita secondo il Vangelo e della missione ecclesiale.
Ma non dovremmo neppure trascurare di prendere in considerazione alcuni segnali preoccupanti che provengono dalle chiese di “periferia”, così come da quelle del “centro”.
Non avevano del tutto torto i vescovi che, almeno fino al Concilio Vaticano II e in molti casi anche dopo, durante le visite pastorali nella propria diocesi chiedevano anzitutto ai parroci quante confessioni e quante comunioni facevano in un anno, rapportandole al numero dei battezzati affidati alla loro cura.
E neppure avevano torto i papi che, in passato, si facevano consegnare dai vescovi in visita “ad limina apostolorum” il numero dei sacramenti amministrati complessivamente nelle loro diocesi.
Erano vescovi e papi che traevano utili indicazioni sullo stato della cura delle anime e della santità del popolo di Dio semplicemente dalla medicina delle anime e dal veicolo della grazia santificante.
Non disponevano certo di tutto l’apparato istituzionale, comunicativo, tecnologico e organizzativo reso possibile dalla sociologia religiosa e della stampa e radiotelevisione, ma avevano dalla loro l’umile certezza che non è accarezzando le mode culturali e antropologiche del tempo che si salvano le anime, né andando dietro all’onda dei (ri)sentimenti e delle rivendicazioni individuali e sociali all’interno e all’esterno della Chiesa che si edifica il popolo di Dio sulla via della santità.
Grazie per l’attenzione e tanti saluti cordiali, “ad maiorem Dei gloriam”.
[Lettera firmata]
Fonte: chiesa.espressonline.it