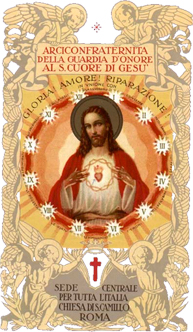Si parla di 500 mila visitatori all’Expo nella prima settimana e di 11 milioni di biglietti già venduti nel mondo. Al di là dei numeri l’Expo è ormai un fenomeno di costume perché ha messo a tema ciò che in quest’epoca più appassiona, il cibo: una delle cose che esprime la nostalgia del paradiso perduto e il desiderio delle delizie di quel giardino adamitico, simbolo della perfetta armonia fra corpo, mente, natura e spirito.
Si parla di 500 mila visitatori all’Expo nella prima settimana e di 11 milioni di biglietti già venduti nel mondo. Al di là dei numeri l’Expo è ormai un fenomeno di costume perché ha messo a tema ciò che in quest’epoca più appassiona, il cibo: una delle cose che esprime la nostalgia del paradiso perduto e il desiderio delle delizie di quel giardino adamitico, simbolo della perfetta armonia fra corpo, mente, natura e spirito.
E’ una fissa collettiva. Come dimostrano il proliferare di programmi televisivi, le vendite dei libri di ricette e le pagine che giornali e rotocalchi dedicano alle specialità di questo o quell’angolo d’Italia, mentre i tiggì – perfino quello satirico di Antonio Ricci – si sono riempiti di succulente rubriche di degustazione.
Tuttavia non si capisce il segreto della nostra civiltà del mangiare e del bere. All’Expo la si mette soltanto in mostra.
Poi si riflette sul dramma dell’alimentazione nel Terzo Mondo. Ma (come ho già scritto) il problema della fame viene affrontato soprattutto con banali luoghi comuni anti-industriali che ripropongono vecchie e fallimentari ideologie.
Non considerando un fatto essenziale: per gli uomini il cibo non è la mera risposta materiale a un bisogno fisiologico come per gli animali, ma è un fatto eminentemente culturale.
Infatti il cibo per noi in natura quasi non esiste: non solo non esistevano in natura il pane e il vino, ma nemmeno il grano e l’uva erano, nella preistoria, quello che sono diventati oggi grazie alla selezione umana.
E’ il lavoro, quindi un’intelligente capacità di adattamento e di trasformazione, poi di produzione, a dare il cibo commestibile per gli uomini e in quantità sovrabbondante.
L’uomo non è ciò che mangia, come voleva Feuerbach, ma mangia ciò che la sua intelligenza, la sua essenza spirituale sa cogliere, coltivare e trasformare in vita per tutti.
L’uomo trasforma il mondo in cultura, in cose buone e belle per sé, quindi in spiritualità. Le colline toscane, trasfigurate dal lavoro e dall’intelligenza, sono tanto cultura quanto natura e i casolari di pietra e i muri a secco e le vigne e le pievi romaniche sono tutt’uno col paesaggio. Coltura e cultura.
Ecco ciò che l’Expo dovrebbe far capire: l’alimentazione non è solo materia che riempie lo stomaco, ma è un fatto culturale ed è uno dei modi più interessanti per conoscere e capire le civiltà.
IL VINO E LE ROSE
In Italia infatti il turismo enogastronomico s’intreccia, ormai sempre di più, con la spettacolare offerta di arte, borghi, chiese, paesaggi, castelli, abbazie, torri, affreschi, piazze, colline, sole e spiagge.
A Siena il maiale di cinta che gusti nel piatto lo ritrovi rappresentato nella celebre Allegoria del Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti, sotto la Torre del Mangia.
Negli agriturismi toscani la degustazione di vini – conservati in cantine che somigliano a volte a chiese gotiche o sono capolavori di architettura moderna – viene fatta dopo l’esecuzione di arie d’opera o letture di poesie. E i pregiati vini di Bolgheri convivono benone con le poesie del Carducci, con i viali di cipressi e gli arrosti di cacciagione maremmana.
Perché il turista – forma moderna del pellegrino medievale (del viaggiare, della ricerca dell’Altro fa parte da sempre la ricerca di se stessi) – desidera avidamente di gustare pure col palato la bellezza che vede con gli occhi, la profondità della storia che coglie con la mente e il sole e il vento che sente sulla pelle.
Così il Brunello di Montalcino è tutt’uno con l’alabastro trasparente alla luce su cui sono stati scolpiti i favolosi capitelli dell’Abbazia carolingia di Sant’Antino, che risuona ancora oggi del gregoriano dei monaci premostratensi, e si trova su quella via Francigena dei pellegrini che nella bassa Toscana è inseparabile dai pici, dalla ribollita, dalla “fiorentina” e dai panorami mozzafiato sulla Valdorcia, che a sua volta è inseparabile dal pecorino di Pienza, piccola “città ideale” pensata dal papa umanista Pio II.
Umanesimo che letteralmente “fondò la scienza dell’alimentazione e la ‘liturgia’ della tavola” (Cardini), lanciandoci, col suo patrimonio di conoscenze scientifiche, addirittura alla scoperta del Nuovo mondo, sia per evangelizzare popoli sia in cerca di spezie (pepe, cannella, noce moscata, chiodo di garofano, cumino e coriandolo) che avevano il pregio di insaporire e anche di conservare i cibi.
GENIO DEL MONACHESIMO
Del resto molte delle specialità italiane, dal parmigiano al prosciutto (ma anche lo “champagne” francese) vengono da quei monaci benedettini che dissodarono le campagne d’Europa sottraendole alla foresta e alle paludi, che riempirono di mulini le campagne perché il cristianesimo aveva spazzato via la schiavitù.
Monaci che insegnarono all’Europa barbarica la dignità del lavoro, che esercitavano l’architettura e l’ingegneria idraulica mentre salvavano l’antica cultura classica, approfondendo la scienza delle erbe medicinali e della farmacologia e realizzando l’idea del chiostro e del giardino come immagine del “paradiso perduto” (tanto che l’abbazia di Vallombrosa sarà l’Eden del “Paradise Lost” di John Milton).
Tutti sentono il fascino di queste radici se ieri, sulla “Repubblica”, è uscita una bella lettera del professor Luciano Verdone dove si raccontano le abbazie benedettine in cui “la cultura classica è entrata in osmosi con quella germanica grazie all’elaborazione cristiana”.
In quelle abbazie l’ “ora, labora et lege” aveva “ripristinato il triangolo aristotelico dell’uomo composto di spirito, psiche, intelletto e ‘soma’, cura del corpo, attività fisica. Il monastero benedettino” spiega Verdone “riproduceva la ‘città platonica’, in cui ciascuno viene valorizzato per le proprie abilità. Dove al lavoro intellettuale della trascrizione dei codici antichi, si affiancava l’attività chimica dei ‘laboratoria’, che precorre quella moderna, e l’attività manuale di artigiani, allevatori e contadini. Grandezza dei monaci contadini che” conclude Verdone “dopo l’ondata barbarica, ci hanno restituito la dieta mediterranea degli antichi, i montepulciani, i trebbiani, l’olio delle nostre colline”.
Tutto fiorito in quel silenzio che era preghiera, un ordine e una bellezza che volevano evocare i “cieli e terra nuova” della “Gerusalemme celeste”.
Perfino il laico Corrado Augias ha risposto confermando l’apologia della cultura benedettina di questa splendida lettera. Poi ha ricordato il film sui “monaci di Tibhrine, in Algeria, massacrati da fanatici musulmani”, perché è un film capace di “una restituzione così intensa dell’atmosfera monacale da risvegliare quella nostalgia del sacro che la modernità occidentale ha ormai perduto”.
LA RISPOSTA
Per quanto possa sorprendere tutto questo è anche la vera risposta al primo problema dell’Expo, quello della fame.
E’ quanto dimostra uno straordinario articolo pubblicato nei giorni scorsi da padre Piero Gheddo, un missionario del Pime che ha trascorso la vita a viaggiare nel Terzo Mondo e a studiarlo.
La sua accurata analisi va letta per intero, ma ecco la conclusione:
“il maggior dono che possiamo fare all’Africa è l’annuncio di Cristo e del Vangelo”.
Spiega:
“Alla radice del sottosviluppo ci sono mentalità, culture e religioni fondate su visioni inadeguate di Dio, dell’uomo e della donna, del creato. La santa Madre Teresa di Calcutta diceva: ‘La più grande disgrazia dell’India è di non conoscere Gesù Cristo’ ”.
La fame si risolve solo con un cambiamento culturale in quelle terre: ecco perché proprio i cristiani dovrebbero dire che occorre aiutarli a casa loro.
Scriveva don Gianni Baget Bozzo: “Uomini di Occidente, non vedete che abbandonate le popolazioni africane a un destino di morte, che lo fate perché non siete più cristiani, che non avete più il desiderio di salvare i loro corpi perché non avete il desiderio di salvare le loro anime?”.
Occorrerebbero dunque nuovi benedettini, per la fame del Terzo Mondo, ma anche per far rifiorire il nostro deserto spirituale.
Antonio Socci
Da “Libero”, 17 maggio 2015
Facebook: “Antonio Socci pagina ufficiale”