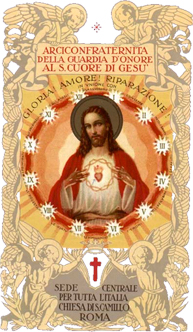La visita a Milano di Benedetto XVI ha risvegliato la memoria della splendida ghirlanda di pastori che lungo i secoli ha impreziosito la Chiesa ambrosiana, non raramente con elezioni inattese e imprevedibili.
La visita a Milano di Benedetto XVI ha risvegliato la memoria della splendida ghirlanda di pastori che lungo i secoli ha impreziosito la Chiesa ambrosiana, non raramente con elezioni inattese e imprevedibili.
Il caso di sant’Ambrogio è sintomatico. Difficilmente ci si poteva aspettare che quel clarissimus giovane senatore romano non ancora cristiano, fortemente riluttante, e perdi più contro una disposizione del concilio di Nicea, sarebbe stato eletto vescovo di Mediolanum. Nella città imperiale, dopo quasi vent’anni di episcopato di Aussenzio, il clero «doveva ormai essere in gran parte ariano» (Paredi) e il contributo dei laici litigiosi era quello di una reciproca avversione.
Quella «elezione obliqua» verrà in seguito rinfacciata all’antico governatore, ma Girolamo non esiterà a riconoscere che, «dopo la tarda morte di Aussenzio, nominato Ambrogio vescovo di Milano, tutta l’Italia si converte alla vera fede».
È vero che, con l’iracondia che lo contrassegnava, lo stesso Girolamo, forse perché intralciato dal vescovo di Milano nella sua mira a succedere a Papa Damaso, nel De viris inlustribus, con sottile perfidia, scriverà: «Di Ambrogio, poiché è vivente, non esprimerò il mio giudizio, affinché non mi si rimproveri o di adulare o di dire la verità». In ogni caso, nel nome e nel segno del suo pastore più celebrato, la Chiesa di Milano incomincerà il suo cammino glorioso.
Non meno imprevedibile, se non la nomina, in quei tempi di nepotismo, era la riuscita episcopale diCarlo Borromeo, il giovanissimo e ricchissimo nipote di Pio IV, che succedeva agli arcivescovi estensi, gli Ippolito, per fortuna quasi sempre assenti dalla diocesi, e sotto i quali la Chiesa di Milano visse una delle più buie e confuse stagioni della sua storia. Eppure Carlo Borromeo, in unaventina d’anni d’episcopato, lasciò in quella Chiesa una disciplina, uno stile e uno spirito durati secoli e costitutivi della tradizione giustamente chiamata borromaica.
Più vicino a noi troviamo l’elezione del cardinale Ferrari da parte di Leone XIII. Il Papa dell’Aeterni Patris, impegnato nella rinascita del tomismo, probabilmente convinto che l’ardente quarantaquattrenne vescovo di Como fosse un gran tomista, lo nominava cardinale arcivescovo di Milano, dopo il pio, intelligente e caritatevole monsignor Luigi Nazari, dei conti di Calabiana, che i Pontefici e la Curia romana avevano abitualmente contrastato ed emarginato.
Era una scelta inaspettata. Gli aristocratici milanesi per lo più non la gradirono, ritenendo che le origini umilissime di Ferrari non convenissero alla sede ambrosiana, quasi di diritto occupata da rappresentanti di nobili famiglie.
D’altra parte, neppure si può dire che le scelte del troppo giovane e focoso pastore nei primi dieci anni di episcopato siano tutte state delle più opportune: le tacciava di imprevidenza anche un giovane dottore, poi prefetto, dell’Ambrosiana, Achille Ratti, che — se pur lo difese contro le ingiuste accuse di modernismo e lo servì sempre lealmente — era ben lontano dal condividere la forma di governo del suo arcivescovo, che giudicava «un gran buon cristiano, ma pure un grande imprudente». La mentalità dei due grandi — osserverà Schuster — era così diversa da non permetterne la reciproca comprensione.
Con questo, dopo iniziali incertezze e talora maldestrezze, Ferrari concorse magnificamente sia a mutare in maniera radicale l’immagine del vescovo, avvicinandola finalmente al popolo, sia a rinnovare, secondo i tempi nuovi, l’opera pastorale di san Carlo, del quale, a riconoscimento dello stesso Ratti, Ferrari fu il successore più zelante e l’imitatore più fedele. Di fatto, dopo alcuni anni dinoviziato episcopale, l’ultimo decennio della sua vita, trascorso tra inenarrabili sofferenze d’ogni genere, vide la piena maturazione e il fulgore avvolgente della sua santità: egli lasciò, per la sua stessa morte, in tutti i milanesi, aristocratici e popolari, una splendida e incancellabile memoria.
A Ferrari, piuttosto inaspettatamente, succedette proprio l’«accorto e misurato » (Schuster) Achille Ratti, parco di parole, con fama di prete liberale legato all’aristocrazia milanese: in una parola, l’opposto del suo predecessore, che di Ratti aveva, come tutti, piuttosto soggezione; anzi, sarà lo stesso Ratti, diventato Papa, a non permettere a Schuster l’introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione. In realtà, sia pure dopo diversi e pretestuosi intralci, Ferrari beato lo divenne.
Al riguardo, non si può dire che i milanesi fossero entusiasti della nomina a loro arcivescovo del nunzio a Varsavia. A Milano, d’altronde, egli passò rapidamente, raptim transit proprio come previde nel suo motto episcopale: solo dopo qualche mese Ratti venne eletto al sommo pontificato col nome di Pio XI, e fu uno dei più grandi Papi dell’epoca moderna: rex tremendae maiestatis, ebbe a chiamarlo Giovanni Battista Montini.
Dopo Ratti arrivò Eugenio Tosi dietro la ferma imposizione di Pio XI, che all’eletto, suo antico e stimato alunno, riluttante e ammalato, non esitava a scrivere di pensarci su e di affrettare la sua venuta a Roma a vedere Pietro e a dire il suo sì, aggiungendo: nella decisione «non ci siamo entrati che Dio ed io».
Per il mite e paziente arcivescovo — sempre un po’ vigilato speciale del Pontefice, la cui presenza nella diocesi ambrosiana non cessava di essere incombente e condizionante — furono sette anni di martirio: martirio a cui non poco contribuì la minuziosa visita apostolica dell’abate Schuster, pur sempre personalmente riguardoso nei confronti dell’arcivescovo. Tosi ne soffrì moltissimo: «Sono del parere — afferma Rimoldi — che anche questa visita apostolica abbia in parte contribuito al suo affrettato tramonto».
A subentrare al cardinale EugenioTosi Pio XI inviò a Milano proprio l’ancor giovane e già rinomato abate Schuster. Quella nomina fu agli inizi più temuta che gradita, anche se era stata unanime l’ammirazione per il dotto e austero visitatore apostolico dei seminari milanesi.
In verità, la pietà e lo stile rigoroso della sua vita impressionarono da subito, mentre non mancarono di lasciare perplessi le sue iniziative e i suoi atti di governo, non tutti indovinati e pertinenti.
Col passare del tempo, tuttavia, i tratti di asprezza e di sbrigatività si vennero addolcendo. Quella diafana figura di monaco, quasi sempre rivestita della fiammeggiante porpora e che sembrava ogni volta apparire da un altro mondo, riuscì a conquistare sia i fedeli — i primi a esserne attratti — sia il clero, che finì per volergli sinceramente bene.
Alla morte dell’ascetico cardinale fu comune il riconoscimento: «È scomparso un santo!». E come Ferrari la Chiesa di Milano lo venera beato.
La cattedra di sant’Ambrogio fu quindi occupata dal pro-segretario di Stato di Pio XII, Giovanni Battista Montini: un pastore moderno, di grande finezza e levatura culturale, stimato e ascoltato. Anche quella venuta non era prevedibile; la si deve alla scelta personale di Papa Pacelli, che se non mancò di suscitare sorpresa e voci, fu, in ogni modo, oggettivamente lungimirante.
Giunto a Milano col prestigio della sua persona e del suo ufficio, vi sarebbe rimasto il tempo giusto per prepararsi al ministero pontificio.
Diventato Paolo VI Montini non ebbe la minima esitazione — tra i diversi aspiranti — a eleggere come successore il più prestigioso ecclesiastico milanese: Giovanni Colombo, rettore maggiore dei Seminari e vescovo ausiliare. Consapevole dei suoi limiti, egli accettò la designazione «con sgomento indicibile», come annotava in un suo diario, già ben sapendo che non sarebbe piaciuta a tutti. Scriveva a un amico: «So di essere un omino-attaccapanni su cui il Signore (non senza un sorriso) si compiace di appoggiare i mantelli della Sua gloria».
Alla morte di Colombo il cardinale Giacomo Biffi, che alla sua scuola imparò a fare il vescovo come si deve — ossia con l’affidabilità del pastore e la sapienza del maestro — affermava: «Sono fortemente tentato di dire che nessuno dei molti ecclesiastici e laici degni di stima e di ammirazione che ho avuto la fortuna di incontrare mi è parso raggiungere in una valutazione complessiva la sua statura».
Per l’intelligenza acuta, la magia della parola, chiara e levigata, il silenzio paziente, il giudizio penetrante e ponderato, la matura esperienza, il vivissimo senso ecclesiale, il limpido e rassicurante magistero, Colombo va senza dubbio annoverato tra i più illustri e avveduti successori di sant’Ambrogio. Si legge sulla sua lastra tombale: «Con luminosa dottrina e saggio governo resse la Chiesa ambrosiana». È detto sinteticamente e perfettamente.
Grazie a tali prerogative, in tempo di dissennata contestazione, alimentata da qualche sacerdote insoddisfatto o da qualche inquieto religioso spacciato per profeta, Colombo riuscì, senza ondeggiamenti, a portare la sua Chiesa fuori dalla tempesta degli anni travagliati, non lasciandosi coinvolgere, direbbe ancora l’arcivescovo di Bologna, «nella schiera dei troppi che avevano intrapreso a giocare agli “avanguardisti ”» e di quanti, capaci di «leggere, e a fatica, solo l’orario ferroviario», si improvvisavano lettori specialisti dei segni dei tempi: specialisti, per altro, non estinti, ma stagionalmente pronti a ricomparire sulla scena a recitare la loro parte. Il tempo, che, quando vuole, sa essere onesto, mostrerà la grandezza di questo successore di sant’Ambrogio.
Quanti vennero dopo Colombo son tutti viventi, e quindi la considerazione deve concludersi, non senza annotare quanto sia stata varia e ricca la fantasia di Dio nelle vicissitudini della Chiesa milanese, come del resto in tutta la Chiesa, dove si intrecciano le volontà e i progetti degli uomini, non infallibili, e la libertà dello Spirito, indocile ai nostri consigli e restìo a farsi aiutare nel discernimento. «Il voler nostro interroghi e a tuo voler decidi» scriveva Manzoni.
INOS BIFFI
Copyright © L’OSSERVATORE ROMANO