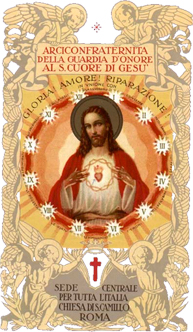L’avevo detto e l’ho fatto. Ho letto il libro di Pietro Maso e ne ho parlato a scuola. Perché è un libro sulla colpa e sul perdono, sulla giustizia e sulla misericordia. E’ un libro che parla di sguardi. Ne ho parlato perché educare vuol dire anche questo: far capire ai ragazzi che la scuola serve alla vita, o non è scuola. Che aiuta a comprendere se stessi, o non serve a nulla. “Il male ero io” – questo il titolo – racconta la storia di Pietro Maso, anzi: di Pietro e di Maso.
L’avevo detto e l’ho fatto. Ho letto il libro di Pietro Maso e ne ho parlato a scuola. Perché è un libro sulla colpa e sul perdono, sulla giustizia e sulla misericordia. E’ un libro che parla di sguardi. Ne ho parlato perché educare vuol dire anche questo: far capire ai ragazzi che la scuola serve alla vita, o non è scuola. Che aiuta a comprendere se stessi, o non serve a nulla. “Il male ero io” – questo il titolo – racconta la storia di Pietro Maso, anzi: di Pietro e di Maso.
Come c’è scritto a pagina 58. «Per molto tempo Maso aveva convissuto insieme a Pietro, come due gemelli uguali ma profondamente diversi. Maso si alimentava di narcisismo.
E quel narcisismo faceva sì che io godessi solo quando gli altri mi guardavano. O ancora di più quando gli altri provavano a imitarmi. Erano lo specchio nel quale io potevo mirarmi. Mi dava l’illusione di un potere immenso. Delirio. Ebbrezza. (…) Solo allora mi sentivo di esistere».
Chi lo sa se questo giovane di Montecchia di Crosara era affetto da “narcisismo bipolare”, come scrisse sulla sua perizia lo psichiatra Vittorino Andreoli; fatto sta che nel libro vengono elencate tutte le folli follie pensate e messe in atto con alcuni amici, per essere sempre sopra le righe.
«Hanno scritto di me, di noi, che abbiamo ucciso per fare la bella vita. Noi volevamo entrare nella vita – scrive Pietro – E invece, macchiandomi del più terribile dei crimini, a diciannove anni sono entrato nella tomba insieme a mamma e a papà».
Senza alibi e senza censure, Pietro racconta tutti i tentativi falliti per far fuori i genitori e intascare l’eredità: il veleno per topi una volta, e poi quell’altra con il gas, e quell’altra ancora: quando l’idea era fracassare la testa della mamma a colpi di schiaccia bistecche.
Fino a quella notte terribile del 17 aprile, recuperata dalla memoria in tutti i dettagli, in cui, con tre amici, i genitori li fa fuori davvero.
«Uccidere. Cosa vuol dire uccidere? Non lo so. Dare la vita e dare la morte può farti sentire eterno. Ma non c’è piacere. Io non l’ho provato. Uccidere è privazione. Assenza. Una vertigine distruttiva. E’ come lanciarsi da un palazzo sapendo che non puoi volare».
A 19 anni, il 19 aprile 1991 si apre il cancello grigio, spesso, del carcere Campone di Verona, e Pietro diventa il numero 42 della cella 3. Un numero. «Ci sono corridoi profondi e bui. E muri sporchi di piscio e sangue, di cibo e sputi. (…) Ci sono porte di legno grosso, scuro, con cerniere di ferro. Quando si aprono quella voce rauca, assordante, volgare, pare un urlo vomitato dalla pancia di un mostro. Ma quello che non riuscirò mai a cancellare è l’odore: quel puzzo che ti si appiccica addosso. Ti sporca dentro. E’ puzzo di carne umana, marcia, di cancrena aperta. E’ tanfo di tabacco mischiato al caffè»
Sono tante le pagine sul carcere, perché 22 anni dietro le sbarre a Verona e poi a Milano sono più della vita passata fuori. Davanti agli occhi della memoria sfilano volti, sapori, odori…
E colpisce come in giorni e notti che paiono ripetersi uguali perché niente più della galera è routine, si delinea invece, ricco di particolari, l’incontro con don Guido Todeschini, direttore di Telepace, che, udito per caso un giorno alla radio, di Pietro aveva detto così: «Che facciamo, lo abbandoniamo, lo seppelliamo vivo come meriterebbe o gli tendiamo la mano e cerchiamo di recuperarlo, tenendo conto della sua giovane età? Certo, in questo momento è più facile essere giustizialisti che muoversi al perdono. Ma se noi lo lasciamo lì in carcere, dimenticato, noi commettiamo lo stesso delitto».
E’ il sacerdote a prendere i contatti con lui: inizia a scrivergli delle lettere, poi, un giorno, chiede di incontrarlo.
«Io, sepolto vivo. Odiato. Rinnegato. Dimenticato. Io che quando arrivava il giorno dei colloqui mi rintanavo in cella in completa solitudine, ora avevo qualcuno che si interessava a me. Accettai». E’ questo incontro la svolta. E non si può dimenticare.
«Lo ricordo come fosse ieri. Sono le dieci del mattino. Quanto l’ho atteso questo giorno. Finalmente è arrivato. (…) Dopo quasi dieci mesi qualcuno viene per me, per Pietro (…) L’alba avrebbe portato qualcosa che avveniva solo per me. Il giorno non sarebbe arrivato invano».
Ed è vero, come scrisse Pavese, che «non c’è cosa più amara che l’alba di un giorno / in cui nulla accadrà». E’ così importante quel giorno, quell’incontro, che si stampa nella memoria per sempre.
«Eccolo. Don Guido è in piedi. Volge le spalle al tavolo. La porta si chiude. Finalmente. Davanti a me c’è un uomo sulla cinquantina, alto circa un metro e settanta, corporatura normale. Indossa l’abito nero con il colletto bianco. Quando faccio per entrare lui, invece di ritrarsi come ero abituato a veder fare, mi viene incontro. Mi abbraccia. Non era mai successo».
Sembra di vedere che si fa “carne” l’incontro tra l’Innominato e il cardinale Borromeo, dico ai ragazzi quando leggo loro queste righe. «Quando quella mattina di febbraio don Guido mi abbraccia, mi sento per la prima volta considerato da un adulto. Per la prima volta c’è qualcuno che mi guarda. Che guarda Pietro».
E’ questa la parte del libro che ho bisogno di far incontrare ai miei allievi: le righe da qui in poi. Quelle che descrivono il rapporto con questo prete straordinario che un giorno gli dice: «Sai Pietro quanti chilometri ho fatto per portarti tutti i sabati il corpo di Cristo? Se sommiamo i chilometri che ho fatto da Verona a Milano in tutti questi anni, equivarrebbero a più di tre giri attorno al mondo».
Più delle parole, è la fedeltà di questa amicizia a lasciare il segno. Vale per Pietro ma – me lo dicono i miei allievi, quando dal libro si passa alla nostra vita – vale per tutti.
«A volte era paterno. Altre duro, aspro. Non sapevo mai cosa aspettarmi. Ma c’era sempre. Non ha mai saltato un sabato. La sua fede, la sua tenacia, mi hanno dato una forza incredibile. Se lui faceva questo per me, dovevo diventare degno del suo sacrificio».
Dopo quello con don Guido, il ricordo dell’incontro con Nadia e Laura, le due sorelle. Il loro perdono… per dono. «Ci dividono pochi passi. Ma i miei piedi sono inchiodati a terra. Come i miei occhi.
Don Guido capisce e mi fa un cenno con la testa. Io non mi muovo. Nadia e Laura mi vengono incontro. Mi abbracciano. Ora siamo abbracciati. Siamo tre in uno.
Mi sarei aspettato di tutto: sguardi di rimprovero, rabbia, schiaffi. E tutto ci sarebbe stato. Ma non ero pronto a questa stretta d’amore. Senza saperlo Laura e Nadia posano una pietra importante sul mio cammino. Questa stretta scioglie tutto: il dolore, la pura, l’odio: la morte.
“Pietro, ti vogliamo bene, sei nostro fratello.” Ho gli occhi chiusi. Dio mi sta facendo il regalo più grande della mia vita. Non posso crederci, sta succedendo davvero, a me. Non me lo merito».
«Il loro perdono mi ha liberato da me stesso», scrive. «Come se qualcuno mi fosse entrato dentro e mi avesse rovesciato».
Ci vogliono vent’anni di carcere e quasi altrettanti di preghiera perché Pietro, che ora è definitivamente un uomo libero, impari a guardarsi in faccia di nuovo: a ri-conoscersi.
Ed è su questo che prosegue la discussione in classe, con i ragazzi. Non la riferirò, perché quel che accade tra le quattro mura di un’aula chiede riservatezza. Dico solo che, incarnata nella storia di Pietro Maso, abbiamo ritrovato la verità, attualissima, delle parole di S. Agostino su Zaccheo. «Fu visto e vide; ma se non fosse stato veduto, non avrebbe visto».
Così, una rinascita è possibile. Per Zaccheo, e per Pietro. Per ciascuno di noi.
Fonte: CulturaCattolica