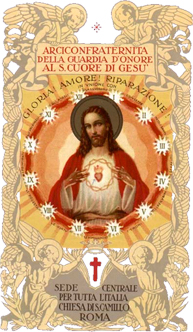Nel 1233 a Viterbo, roccaforte catara sulla via di Roma, nacque Rosa, bambina intraprendente ma sempre cagionevole di salute, quasi il temperamento portato a cose più alte della sua natura trovasse contrasto nella caducità del corpo. Afflitta da una malattia che l’aveva privata dello sterno fin dalla nascita, portava in sé una minima speranza di vita, non oltre i tre anni e quindi la prima infanzia.
Nel 1233 a Viterbo, roccaforte catara sulla via di Roma, nacque Rosa, bambina intraprendente ma sempre cagionevole di salute, quasi il temperamento portato a cose più alte della sua natura trovasse contrasto nella caducità del corpo. Afflitta da una malattia che l’aveva privata dello sterno fin dalla nascita, portava in sé una minima speranza di vita, non oltre i tre anni e quindi la prima infanzia.
Precocemente rapita dall’ascetismo, diafana e minuscola, Rosa voleva addirittura parlare con l’imperatore, Federico II, velenosamente propenso a sottomettere il Papa, contestando in nome della fede le sue pretese di asservimento del soglio di Pietro.
Intanto Rosa difendeva la fede e il Santo Padre dalla deriva catara, che seminava il nichilismo rifiutando i doni di Dio al pari di quelli del demonio, forte delle tesi dei sapienti bizantini che parlavano d’opposizione netta e feroce tra purezza dello spirito e caducità della carne, con i pochi mezzi a sua disposizione.
Poco più che adolescente, Rosa avrebbe voluto essere accolta nel convento delle clarisse, che reputava il domicilio più idoneo al suo desiderio di assoluto, al suo anelito che la vocava alla perfezione divina, solo possibile rimedio alle umane manchevolezze. Si offrì loro con spontaneità e cuore limpido, senza immaginare che la sua fragilità fisica, unita alla mancanza di un adeguato censo, mai le avrebbe aperto le porte del convento di San Damiano.
In tempi difficili come quelli, i poveri tali restavano, senza speranza di affrancamento, emarginati e ignorati, costretti a scegliere di sopravvivere piuttosto che a vivere una vita degna di questo nome. Quindi per quanto la giovane fosse sincera, le clarisse la tennero alla larga, inconsapevoli artefici di una difficoltà che avrebbe affinato la purezza d’animo e la determinazione della persona che decidevano di non accogliere.
Ma Rosa non si diede per vinta, chiese e ottenne di predicare come terziaria fuori dalle mura del convento che l’aveva tanto dolorosamente respinta. Cosicché inaugurò la sua spontanea predicazione per le vie di Viterbo, popolata da catari spalleggiati dal potentissimo imperatore che mai come allora pretendeva la radicale ridefinizione dei rapporti gerarchici rispetto al vicario di Cristo, nel segno di una sottomissione dell’altare al mestiere delle armi.
La sua quotidiana, ardente predicazione, la dichiarata insofferenza contro i catari, le fecero guadagnare un fendente di spada, durante l’assedio che l’imperatore pose contro Viterbo. In seguito a questi fatti il podestà emanò per la giovane predicatrice e la sua famiglia, il padre e la madre, un bando con il quale li si scacciava dalla città. Così la piccola Rosa dai magnetici occhi blu, poveramente vestita riparò — si era nel cuore dell’inverno — con la sua famiglia a Soriano del Cimino, quindi a Vitorchiano.
Seguitò a lottare contro lo strapotere imperiale in condizioni sempre più misere, assediata dal freddo e dalla carestia, forte solo di un’arma apparentemente inane, invece potentissima. L’unico suo strumento era infatti la preghiera offerta in dono alla Chiesa cattolica, attività che pure mai le varrà il premio dell’ingresso nel carmelo.
La giovane resta sola a condurre la sua guerra contro la deriva eretica lungo gli acciottolati e le mura spazzate dai venti. Con la morte dell’imperatore, da lei profetizzata, le si riaprono le porte della città.
Sembrerebbe una vittoria, ma il suo carattere estraneo alle cose del mondo la portava a ragionare e argomentare in termini diversi da quelli delle vittorie e delle sconfitte: categorie terrene, perciò viziate dalla caducità. La sua battaglia era invece per qualcosa che non poteva misurarsi con il metro delle cose mondane.
Nella città, che era stata e non era stata la sua, muore nel 1251. Il suo corpo è seppellito fuori dalla chiesa di Santa Maria in Poggio.
Nell’immediato si susseguono i prodigi, quasi che la vera vita di Rosa fosse cominciata dopo quella che ci si ostina a chiamare vita. Guarigioni dalla perdita della vista e da ogni altro male, fenomeni che chiamano e aumentano la devozione popolare di chi comincia ad appellare come santa la piccola e sperduta predicatrice, latrice di un messaggio che non è soltanto il suo.
Inaspettatamente Innocenzo IV, impegnato nella lotta furente contro i ghibellini indistinguibili dai catari, con il rispetto che si deve a un’anima pia e alle sue spoglie mortali, ordina che il corpo di Rosa venga traslato dalla campagna nel convento di San Damiano.
Cosicché il luogo ove non aveva potuto accedere da viva, diventò la sua dimora eterna, il convento delle clarisse. Qui il corpo di Rosa miracolosamente intatto, custodito in un’urna, ebbe l’onore di essere lasciato alla venerazione dei fedeli. La persistenza delle sue sembianze terrene è considerato il segno della potenza insita nella sua parola: una predicazione capace di imporsi sia sulla debolezza del corpo, sia sulla transitorietà di ogni cosa.
Il fiore che Rosa ha portato nel nome è qualcosa di più di un simbolo, come tale capace di uscire indenne anche dalla fiamma, retaggio dell’incendio che nel 1357 divora tutto tranne il corpo incorrotto della santa. C’era nel suo passaggio qualcosa che avrebbe illuminato il mondo.
Rosa Matteucci
Fonte: L’Osservatore Romano